Speciale Ghinea #5: Agnès Varda (prima parte)
Benvenutx al quinto numero speciale di Ghinea, che segue l’intervista a Elisa A.G. Arfini, la conversazione con un collettivo femminista brasiliano, l’esperimento corale dedicato alla regista Chantal Akerman e lo speciale letture estive. Quando la cineasta francese Agnès Varda è mancata a fine marzo 2019 abbiamo subito annunciato l’inizio dei lavori per uno speciale tutto su di lei e il suo cinema, e, come ci piace fare, abbiamo chiesto l’aiuto di chi ci legge.
Lo speciale Varda sarà diviso in due parti, perché una sola mail non sarebbe bastata per i quattro contributi esterni (di cui uno illustrato) che potrai leggere oltre ai nostri. Nella prima parte troverai Chiara Sélavy che ricorda i maggiori film di Varda attraverso una visita-pellegrinaggio alla sua casa parigina; Rebecca Santimaria sul sodalizio artistico tra Varda e Jane Birkin; Francesca Massarenti sul particolare carattere horror di Le bonheur. In mezzo, le illustrazioni con cui Ester Orellana ha riassunto la storia di Varda attraverso i titoli dei suoi film. Buona lettura!

Agnès Varda cammina a ritroso sul bagnasciuga mentre la sua stessa voce, fuori campo, dice che, se aprissimo le persone, ci troveremmo dentro dei paesaggi: dentro di lei, delle spiagge. È la sequenza iniziale di Les plages d’Agnès, documentario autobiografico del 2008, che Varda inaugura dicendo:
Recito la parte di una vecchina paffuta e chiacchierona che racconta la sua vita.
Agnès Varda è un’inseguitrice di belle immagini, una cineasta prolifica e poliedrica, un’amante dell’allitterazione e dell’assonanza. Era una novantunenne glaneuse aux cheveux vanille-fraise – “spigolatrice dai capelli fragola-e-vaniglia” – come recita la bio di Radio Agnès, il profilo Twitter aperto dal figlio per diffondere le frasi quotidiane di Varda dopo la sua morte, il 29 marzo 2019. Ma Varda è stata anche un’attenta creatrice di immagini potenti perché belle, un’imprenditrice cinematografica (ha fondato la sua casa di produzione indipendente Ciné-Tamaris nel 1954), un cervello che ha reso la propria persona un personaggio molto prima che l’ondata revivalista degli ultimi anni la volesse “nonna” della Nouvelle Vague, e che il cartonato portato in giro per premières e festival da JR (co-regista dell’ultimo film di Varda, Visages, villages, 2017) la rendesse un meme.
Eppure, sono gli altri che mi interessano davvero, e che amo filmare. Gli altri, che mi intrigano, mi ispirano, mi fanno domande, mi disorientano, mi appassionano […]
prosegue Varda all’inizio di Les plages d’Agnès. Varda ha ragionato seguendo i temi propri del suo tempo – il femminismo “corporale” delle rivendicazioni di piazza negli anni ’70, la Cuba post-rivoluzionaria, le lotte statunitensi contro la segregazione razziale – e cristallizzato nel suo tempo idee senza soluzione apparente – come vivere nonostante la corrosione della bellezza, come morire accettando l’orrore casuale e quotidiano, in che modo conservare ciò che si è imparato, in che modo conoscere gli altri, e attraverso gli altri.
La tecnica di Varda imita il glanage, raccoglie dal suolo le spighe sfuggite alla mietitura, e invita al grappillage, coglie frutti dal ramo senza permesso: da una parte recupera ciò che è stato scartato perché piccolo e modesto, dall’altra punzecchia, prevarica, suggerisce qualcosa di scomodo senza causare un danno visibile. Una filosofia che esplora ed esplicita con il documentario Les glaneurs et la glaneuse (2000), un reportage di viaggio attraverso la provincia francese per collezionare storie di persone comuni che vivono di scarti. Letteralmente, perché mangiano cibo gettato via nei campi o nell’immondizia, raccolgono ostriche spazzate dalla marea, o mele rimaste sul ramo. Oppure che raccattano, aggiustano, riutilizzano, donano oggetti e risorse in surplus: mobili, frigoriferi, tempo, rame dei tubi catodici, educazione.
Qui la mano di Varda è in primo piano, protagonista, insieme al suo sguardo dietro l’obiettivo della piccola videocamera digitale e alla sua voce d’intervistatrice. Impossibile dimenticare che l’operazione è parziale e personale – scénario et réalisation: Agnès Varda – ma è doveroso riconoscere che si apre verso un terreno vasto e libero, senza però volerlo conquistare. La vera glaneuse, infatti, è colei che non raccoglie tutto, ma solo quanto le basta, e lascia dietro di sé abbastanza per altre ed altri. Questo speciale vuole seguire la scia lasciata da Varda: si china a raccogliere quello che le è caduto, fa scorta di quello che sembra aver lasciato apposta indietro, ma stacca anche qualcosa dal ramo, e si ferma a guardare il paesaggio attorno, i boschi, le spiagge, gli specchi.

[Alt Text: ritratto di Varda, anziana, su uno sfondo di patate, il tubero che colleziona nel documentario Les glaneurs et la glaneuse.]
HANNO COLLABORATO:
Ester Orellana disegna @disegniniesterini su Instagram.
Rebecca Santimaria, atterrata nel 1996 in un paese di appena mille anime, porta con sé il suo terribile accento veneto. Laureata in Comunicazione, ora prova ad imparare qualcosa di più sul cinema e le serie tv al Citem di Bologna. Non sa ancora con certezza cosa farà “da grande”. Parla di femminismo e parità alla famiglia e agli amici, appena raccoglierà un po' di coraggio vorrebbe anche scrivere di questo. Puoi seguirla su Instagram.
Chiara Sélavy, pseudonimo, è nata su un confine e vive a Londra. Ha scritto per Soft Revolution, Nisimazine e Pixarthinking, ed è film programmer per Lago Film Fest. È @ChiaraSelavy su tutti i social, e cura la newsletter sporadica Expendable Chapters.

[Alt Text: illustrazione per il film-documentario Daguerréotypes: una figura di prestigiatore si staglia sullo sfondo della Tour Eiffel.]
86, Rue Daguerre
di Chiara Sélavy
La strada da casa mia alla piscina è tutta in discesa. Passo davanti a supermercati indiani, negozi di riparazioni per cellulari e un’improbabile agenzia di viaggi nel retrobottega di un barbiere. Carmen Grey scrive:
“Take the road as it comes / Invent everything from A to Z / And don’t be afraid.” RIP Agnès Varda.
La citazione è dal film L’une chante, l’autre pas. Ma sono anche il cinema e la vita di Agnès Varda riassunti in tre versi.

[Alt Text: l’attrice Corinne Marchand nei panni di Cléo guarda il suo riflesso in uno specchio decorato con caratteri cinesi. I sottotitoli recitano: “I always think everyone’s looking at me, but I only look at myself”, “Penso sempre che tutti mi stiano guardano, ma io guardo solo me stessa”.]
Cléo cammina senza meta per le strade di una Parigi in bianco e nero, con i suoi ponti, i caffè, le vetrine e i boulevard alberati. È il primo giorno d’estate, e la città è vibrante, iconica. Ma a lei importa solo che arrivino le sette, per poter finalmente ricevere i risultati delle analisi e sapere se – come già sospetta e come sembrano confermare i cattivi presagi che continuano ad apparirle – è malata di cancro oppure no.
Cléo Florence, la protagonista di Cléo de 5 à 7 (1961), è una giovane cantante. Ci viene presentata come vanitosa e superficiale, ma a guardarla mentre è in camera sua, avvolta in una vestaglia di piume, l’impressione è che sia un meraviglioso uccello in gabbia: il suo amante la tratta come una bambina, la cameriera e confidente ne alimenta il lato superstizioso, e gli amici musicisti con cui collabora prendono i suoi timori per capricci. “Cléopâtre, je vous idolâtre”, le canta uno di loro – ma anche le canzoni scritte per lei raccontano una donna bidimensionale, civettuola oppure completamente dipendente dall’amato. Sarà proprio il testo di Sans toi a indispettire Cléo e a spingerla fuori di casa, un gesto impulsivo che la porta a riflettere su di sé.
Sarebbe facile dire che il film traccia l’evoluzione di una Cléo sempre meno autoriferita (e lo fa, per esempio, attraverso l’uso degli specchi e dei riflessi, estremamente presenti nella prima parte del film per scomparire quasi del tutto sul finale). Il vero cambiamento, però, sta nel rendersi conto che se, come dice Sartre, “l’inferno sono gli altri” – perché la nostra esistenza dipende dal nostro essere riconosciuti dall’altro – è a noi che spetta decidere quanto lasciarci definire dalle opinioni altrui. È questa consapevolezza, suggellata dall’incontro casuale con un soldato in licenza dalla guerra d’Algeria (il conflitto è uno dei temi secondari del film), a dare a Cléo il coraggio di affrontare il risultato delle analisi, sola e finalmente libera.

[Alt Text: l’attrice Sandrine Bonnaire nei panni di Mona sdraiata nel suo sacco a pelo. I sottotitoli recitano “You chose total freedom but you got total loneliness”, “Hai scelto la totale libertà, e ti è toccata solo totale solitudine”.]
Il corpo di una giovane donna viene rinvenuto in un fossato nei pressi di una vigna. Nessuno sa chi sia, né da dove venga; in molti l’hanno incrociata mentre camminava per i campi e le strade della provincia francese, facendo l’autostop o qualche lavoretto in cambio di cibo o qualche soldo. Si chiamava Simone Bergeron, Mona, e di lei non sappiamo molto altro; la sua storia ci viene raccontata a ritroso, attraverso i giudizi e le impressioni di chi l’ha incontrata.
Una sbandata, una drogata, strafottente e perdigiorno: non è un personaggio a cui affezionarsi, Mona, che cammina e prende quello che le serve, lasciando indietro i consigli superflui e i suggerimenti su come stare al mondo. Eppure, guardando Sans toit ni loi (Senza tetto né legge, 1985), non si può fare a meno di intuire qualcosa di profondamente sbagliato: sarà la colonna sonora discordante, o la serie di movimenti di camera da destra a sinistra, contrari al senso di lettura occidentale e quindi istintivamente disorientanti. Ma c’è qualcos’altro che non va: per quale motivo una giovane donna decide di bruciare tutti i suoi documenti e vivere sulla strada?
Mona non offre risposte: la sua stessa esistenza è una domanda, un’accusa e forse una minaccia alla società che la circonda e alle possibilità di vita che le offre: e chi la incontra, temendo forse una parte di responsabilità nei confronti di persone come lei, la disprezza, la compatisce o la biasima, ma fa ben poco per comprenderla.
La Francia che Varda racconta è molto lontana dalla Parigi di Cléo: siamo nella provincia e negli anni Ottanta più profondi, fra mullet e braccianti maghrebini, eroinomani e pellicce imbarazzanti, un posto inospitale e piccoloborghese dove non è difficile immaginare consensi per il Front National. In questa Francia, una come Mona è una che se l’è andata a cercare. E per questo suo voler essere sé stessa, sputando metaforicamente in faccia alla società, viene rigettata e ripetutamente punita, fino alla morte.
Cléo de 5 à 7 e Sans toit ni loi sono molto più simili di quanto sembri: entrambi hanno una struttura episodica (il primo è scandito dai minuti che separano Cléo dall’appuntamento con il medico, il secondo dalle testimonianze con cui viene ricostruita la storia di Mona), e sono incentrati su una giovane donna in cammino o in fuga.
Ad accomunarli c’è anche una strana ironia: Cléo, che ha continuamente bisogno che qualcuno le dica che è bella, che è amata, che esiste, si racconta in prima persona, mentre la storia di Mona viene affidata alle stesse persone di cui lei non si cura affatto. Ma se Cléo de 5 à 7 è un film centripeto, ancorato alla protagonista sia nell’intreccio, sia nella cinematografia (la camera è spesso su di lei, talvolta anche in soggettive che ci danno l’impressione di essere uno dei passanti), Sans toit ni loi è invece, per certi versi, un film centrifugo, e Mona è la cartina di tornasole per raccontare il mondo che la circonda.
Ci sono venticinque anni fra i due film, anni in cui si passa dall’esistenzialismo del primo al nichilismo del secondo; ma soprattutto, venticinque anni di donne a cui viene costantemente detto chi essere, come comportarsi, cosa fare e dove andare.

[Alt Text: un mazzo di fiori e una fila di patate a forma di cuore lasciate in omaggio a Varda fuori dalla sua casa di Rue Daguerre a Parigi.]
Arrivo a Parigi a fine maggio, di mattina presto e senza avvisare nessuno.
Di solito, quando ci vengo, me ne rimango nel diciottesimo arrondissement, spingendomi al massimo lungo il Canal Saint Martin o nel Marais. Stavolta è diverso.
Prendo la metro fino a Denfert-Rochereau, e da lì a Rue Daguerre è un attimo. Arrivo al civico 86 quasi in punta di piedi: vedo la porta a strisce colorate e il muro rosa, le rose e girasoli sul davanzale, le patate a forma di cuore, le cartoline. Mi guardo attorno, cercando i volti che Varda ha raccontato – raccontandosi a sua volta – in Daguerréotypes (1975): il fornaio con sua moglie, il macellaio, la laconica coppia di anziani del negozio di profumi e bigiotteria. Non è rimasto più nessuno, nemmeno lei.
Prendi la strada così come viene / Inventa tutto dalla A alla Z / E non avere paura.
Penso a Cléo che cammina su Rue Huyghens, a pochi minuti da qui, alla curiosità con cui Agnès Varda camminava nel mondo, reinventandolo e individuando storie anche dove, agli occhi dei più, non c’era nulla da raccontare.
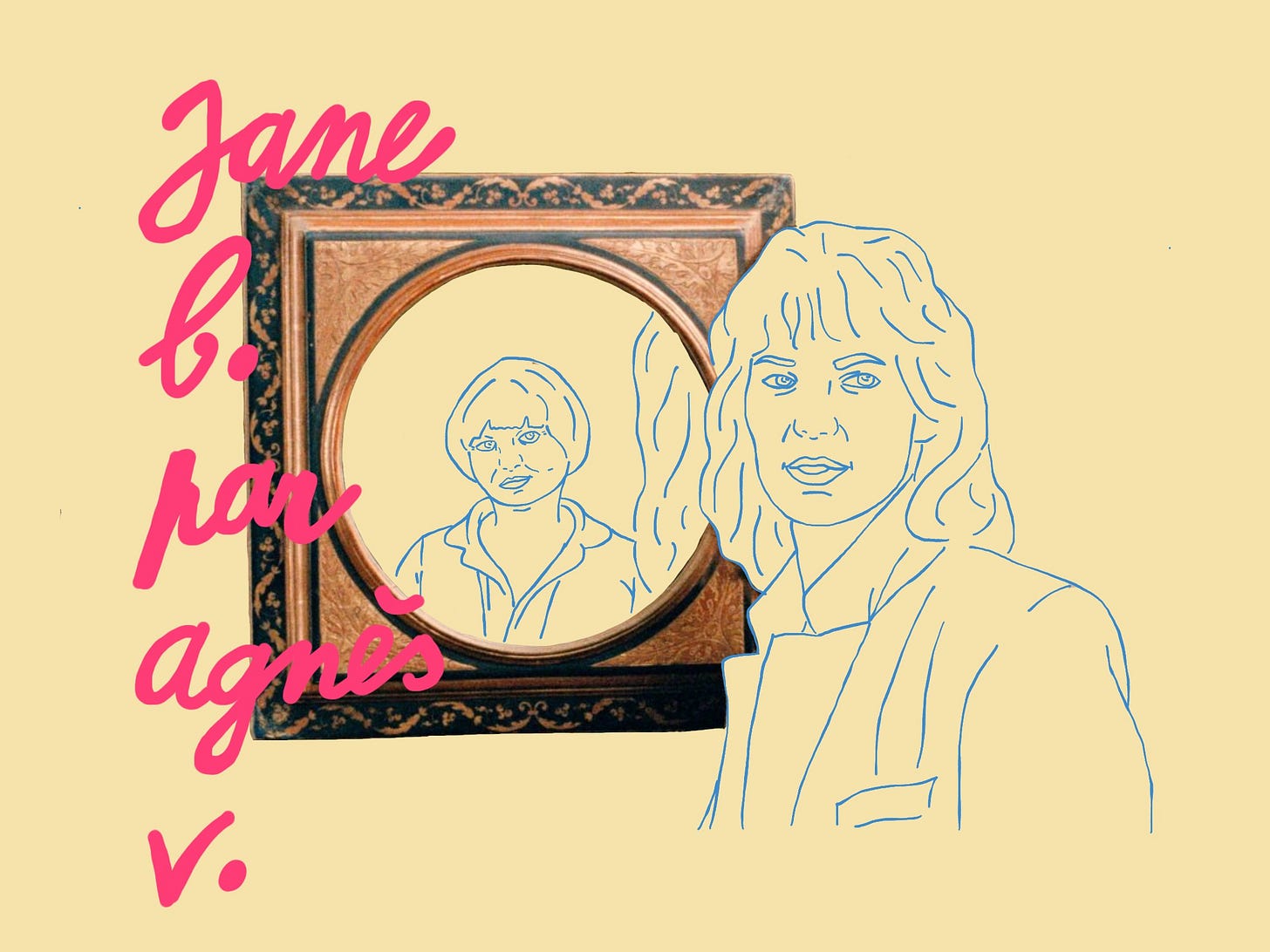
[Alt Text: illustrazione per il film Jane B. par Agnès V., lo specchio davanti a Jane Birkin riflette l’immagine di Agnès Varda.]
Jane B. par Agnès V., una conversazione allo specchio: ritratto confidenziale di una “fantasia pubblica”
di Rebecca Santimaria
Sono Jane B. Sono nata inglese. Sono alta un metro e settanta ora. Nessun segno distintivo. Nessun talento eccezionale, ma sono qui. Tu mi stai guardando.
Jane Birkin nel 1988 compie quarant’anni ed è all’apice della sua popolarità: attrice, icona di stile, cantante ed ex compagna di Serge Gainsbourg. La sua carriera è segnata dalla breve comparsa nel film Blow up (1966) di Antonioni, venti secondi in topless che plasmano l’immagine di donna scandalosa che accompagnerà Birkin per diversi decenni. Folgorata dalla poetica di Agnès Varda in Sans toit ni loi (Senza tetto né legge, 1985), Birkin scrive in un momento di emozione una lettera alla regista, congratulandosi per il meraviglioso lavoro cinematografico, da quest’incontro nasce l’amicizia tra le due donne, celebrata attraverso due film, entrambi del 1988, Jane B. par Agnès V. e Kung-Fu Master!.

[Alt Text: fotogramma di Jane B. par Agnès V. Birkin racconta a Varda l’idea di una storia da lei creata, in seguito diventa la trama per il secondo film del duo, Kung Fu Master.]
Jane B. par Agnès V. rappresenta un’opera-omaggio di Varda a Birkin, creata per esorcizzare la paura di quest’ultima nei confronti dell’età, un’occasione per restituire una versione inedita della diva. Alla soglia dei quarant’anni, Jane Birkin si trova a interrogare se stessa sull’identità della donna che vede riflessa nello specchio, quanto di questa sia oramai di dominio pubblico e quali aspetti invece restino celati ai riflettori. Varda sembra interessata a indagare questo paradosso: una donna che ama essere filmata, ma alla quale non piace parlare di se stessa, una “fantasia pubblica” che desidera essere anonima. «Il tuo desiderio di essere allo stesso tempo sconosciuta e celebre ti rende una fantasia pubblica. Forse è ciò che mi ha affascinato di te, mi ha fatto desiderare di creare un film su di te. Ti posso trasportare nei miei sogni, storie mitologiche, ricordi cinematografici, pensieri inattivi». La pellicola, di circa 90 minuti, è un esperimento cinematografico difficile da collocare all’interno di un genere specifico: a metà tra il documentario e la finzione, tra l’intervista e la confessione. Tableaux vivants, sketch comici, poesie recitate – dalla Venere di Tiziano a Olio e Stanlio – passando per riflessioni sulla bellezza – «Mi piacciono i corpi degli uomini e delle donne, soprattutto per i loro difetti» – e i sogni più remoti – «Non sogno di volare da molti anni oramai». Il copione appare parziale e il montaggio segue il flusso di coscienza della protagonista: nel suo insieme risulta un ritratto frammentato, surreale e ironico di un’esistenza femminile filtrata e interpretata liberamente dallo sguardo empatico della regista.

[Alt Text: fotogramma del film in cui Birkin gioca con la sua immagine deformata allo specchio. La sequenza sembra essere una metafora della sua esistenza, divisa tra il pubblico e il privato, scissa tra i vari ruoli che è chiamata ad interpretare.]
Come spiega Varda durante l’intervista di Dennis Bartok dell’ottobre 2015 (esclusiva dell’edizione dvd statunitense) sono immagini che rappresentano “variazioni su una donna mutevole e versatile”, spesso poco affidabili nel ricostruire la biografia di Birkin – «prendemmo in giro con la finzione per ottenere qualcosa di reale» – ma non per questo meno significative. Si arriva persino a dubitare di avere scoperto qualcosa di essenziale sulla famosa Jane Birkin, tanto è caotica la narrazione in alcuni momenti; l’ambizione dell’opera non consiste nel documentare la vita di Birkin affinché le spettatrici possano ricavarne una visione didascalica, al contrario, il principale destinatario sembra essere proprio Varda, oltre all’attrice, la quale interrompe a tratti la narrazione per svelare qualche episodio del suo passato, come fosse una conversazione spontanea e non ci fosse nessuna mediazione tra le due. Paradossalmente la spettatrice sembra essere esclusa da questa esperienza: come esplicita il titolo (Jane B. par Agnès V.) l’opera ha per protagoniste due donne, una di fronte all’obiettivo, ripresa e registrata, la seconda dietro alla macchina da presa, che ascolta senza indugiare o spettacolarizzare. Dall’intima conversazione, fatta di parole e immagini, emerge la complicità che lega la regista e la sua “musa”, lo stesso patto implicito che si crea tra artista e modella prima di un ritratto. Le confessioni delle proprie insicurezze aggiungono complessità alla figura di Birkin, come succede nei minuti iniziali dell’opera quando ammette il disagio che prova nei confronti dell’obiettivo, troppo invadente e indiscreto:
Non mi piace guardare l’obiettivo. È imbarazzante. È troppo personale. Come fissare qualcuno: è troppo intimo.
Per rendere meno spiacevole l’esperienza delle riprese la Varda le suggerisce di pensarlo come uno “specchio”:
Non guardi gli altri nello specchio, osservi te stessa. Sto girando il tuo autoritratto. Ma non sarai da sola nello specchio, ci sarà la macchina da presa che rappresenta un po’ me.
L’occhio meccanico è solo un’estensione della regista francese che si trova nella posizione di osservatrice privilegiata e ha il compito di narrare ciò che Birkin sceglie di far emergere. Illuminata continuamente dai riflettori, l’attrice realizza quanto le sia privata la banalità del quotidiano, soffocata troppo spesso dalla pressione mediatica e dalle aspettative che gravano su di lei:
Mi piacerebbe recitare in un film come sono realmente: jeans, vecchi maglioni, capelli spettinati, a piedi nudi in giardino. Solo per una volta vorrei dimenticare le parrucche e i costumi carini.
La contraddizione tra la popolarità e il desiderio di anonimato, agli occhi di Varda e degli spettatori, rende Birkin fallibile e umana, tangibile e concreta oltre la fantasia che personifica. Illuminante la metafora della copia della maschera funebre, ispirata al volto della donna trovata nella Senna, posseduta dalla Varda: una sconosciuta trasformata in celebrità, “uno straordinario nessuno” sulla quale si può fantasticare grazie all’impossibilità di sapere chi sia realmente. La somiglianza tra il paradosso della Birkin e quello della “Sconosciuta donna della Senna” (l'inconnue de la Seine) si esplicita visivamente attraverso la dissolvenza che alterna la maschera di gesso, la Senna e il volto dell’attrice.

[Alt Text: fotogramma di Jane B. par Agnès V. Transizione visiva che fonde la Senna e il volto di Birkin.]
Varda concede alla sua amica, per 90 minuti, la possibilità di essere quella presenza anonima che tanto agogna, asseconda il suo desiderio di essere nessuno, anzi di essere chiunque: Giovanna d’Arco – ruolo da sempre precluso a causa del suo accento inglese – Calamity Jane, musa, attrice, icona, cantante, madre, fino ad arrivare a Jane B., che piange fissando l’obiettivo mentre taglia una cipolla nella quotidianità della sua cucina. Jane B. par Agnès V. è un film sperimentale, da molti considerato troppo parziale e incompleto, che si propone di essere un memoriale redatto in un punto catartico della vita di Jane Birkin. «Comunque domani compirò quarant’anni» conclude Birkin negli ultimi minuti, un’osservazione che permette a entrambe le donne, nonostante la differenza d’età, di riflettere su se stesse e per stesse, sulle loro esistenze complesse e contraddittorie, abitate da desideri e ossessioni come quelle di chiunque altro. Jane B. par Agnès V. è un ritratto cinematografico che prende vita a partire dalla visione spontanea e irriverente di Varda, e Jane, rapita dalla sensibilità della regista, si fa guidare nella retrospettiva della propria esistenza fino a quel momento:
Quando torno a casa i miei figli mi chiedono cosa sto facendo. Non lo so, sono in un dipinto di Agnès.

[Alt Text: illustrazione per il film Kung-Fu Master!, Jane Birkin insieme a Mathieu Demy, che interpreta Julien, l’adolescente di cui Mary-Jane, il personaggio di Birkin, si innamora.]

[Alt Text: illustrazione per il film Le bonheur, i volti dei coniugi Chevalier (Claire e Jean-Claude Drouot) sono racchiusi dentro un girasole.]
Le felicità cicliche di Le bonheur (1965)
di Francesca Massarenti
“Le bonheur n’est pas gai” [la felicità non è allegra]


[Alt Text: François (Jean-Claude Drouot) e Thérèse (Claire Drouot) nel bosco durante un picnic domenicale, approfittano del riposino dei bambini per fare l’amore.]
Dice Varda, per la rivista Films and Filming, nel 1970:
Le bonheur parla di alberi: voglio dire, parla anche di altre cose, parla di fare sesso e di picnic. Ma parla anche di alberi.
Le bonheur parla di un uomo, François, che di mestiere fa il falegname: gli alberi li sega, pialla, truciola e pittura di blu. François è sposato con Thérèse, sarta semi-professionista che raccoglie enormi mazzi di fiori durante le gite della domenica, e veste abiti confezionati con tessuti floreali. Insieme si sono riprodotti due volte: Gisou e Pierrot sono i loro (adorabili) bambini, che non piangono mai, dormono ore e ore di seguito, rispondono a qualunque figura di autorità vengano affidati. La provincia colorata in cui abitano confina con boschi e laghi, ma anche con il cemento dei palazzoni che già erodono i confini dei giardini e degli orti privati. Fontenay-aux-Roses non è certo il villaggio bucolico che Varda dipinge, è in piena Île-de-France. Un sobborgo di Parigi, probabilmente nel 1965 già pronto a votarsi al pendolarismo sulla linea RER in costruzione. La natura del lavoro, intanto, è già in piena evoluzione: all'artigianato manuale, (semi)indipendente, la cui creatività è ricompensata con bottiglie di bordeaux e inviti al ricevimento di nozze, si susseguono forme di impiego burocratico, asettico, regolato da orari fissi, come un ufficio postale.


[Alt Text: la famiglia Chevalier durante una gita domenicale nel bosco. La famiglia rientra in furgoncino a Fontenay-aux-Roses. ]
Nei giardini di Fontenay non ci sono roseti, ma girasoli, e in casa di François e Thérèse le rose recise sono soffocate dai fiori di campo. Margherite, fresie, gerbere, primule, forsizie e lillà vivono nei vasi al civico 12 (ma anche allo stabile 2 dove andrà ad abitare l’impiegata postale Émilie), aspettano immobili di essere innaffiate, poi di appassire. Le bonheur imita il ciclo naturale delle piante: non è un film di rottura, è un film di contemplazione. L’estetica del grazioso che crea una spessa membrana attorno a Le bonheur – fiori, casette troppo piccole per quattro persone, completi coordinati per famiglie, piante in vaso – non smussa affatto la rabbia di chi guarda, anzi, forse ne accresce il disagio.


[Alt Text: Thérèse apparecchia la tavola, sulla quale ha posizionato un vaso di fiori di campo. Thérèse annaffia una pianta in vaso dentro casa.]
Tradimento e morte sono parte dell’ecosistema, mai messo in crisi o inquinato. È un sistema ideale perché chi lo abita esiste all’interno di un vuoto intonso, le coscienze non sono state avvelenate da nozioni antagoniste come “sessismo”, “genere”, “capitalismo”, “sfruttamento della forza lavoro”. Ciascuno – ma soprattutto ciascuna – è a suo agio e felice nel ruolo toccatole/gli in sorte. Gli uomini appendono le mensole al muro. Le donne si occupano di bambini, mariti, cene e picnic. Si susseguono l’una all’altra, diverse e costanti, come le stagioni. Non c’è bisogno di etica dove l’automazione funziona.


[Alt Text: un abbraccio tra François e Thérèse. Una conversazione a letto tra François ed Émilie (Marie-France Boyer).]
Notes on Women’s Cinema – un pamphlet inglese pubblicato nel 1973 dalla Society for Education in Film and Television, e venduto per corrispondenza a 25 pence – contiene un saggio sui film di Varda. Si intitola “Subjecting her Objectification, or, Communism in not Enough” e l’ha scritto Barbara Halpern Martineau. Martineau chiama in causa la curatrice dell’opuscolo, Claire Johnston:
Ho detto che le donne possono trascendere la loro oggettificazione osservandola in maniera creativa e Claire Johnston ha detto no. Ha detto “l’oggettificazione non può essere vinta semplicemente analizzandola mediante l’arte” e “‘la verità’ della nostra oppressione non può essere ‘catturata’ su celluloide” […].
Però “Le bonheur is a savage film”, scrive Martineau, è efferato e brutale nel fotografare il lato rovescio del selvaggio: l’ordine superficiale del decoro, la normalità della violenza. Indicare un’idea, suggerire una verità anche se non si riesce a toccarla – per Martineau e Johnston – fa un rumore particolare: è
[…] l’esplosione nella testa della donna che si accorge della propria oggettificazione e di quello che le succede intorno.
Lo scoppio è invisibile nella testa di di Thérèse, quando realizza la propria schiavitù e non trova soluzione al proprio degrado: si allontana, non per raccogliere fiori, ma per cercare le acque più profonde. Duplicata e declassata dal suo uomo, Thérèse si blocca, ma per Martineau:
[…] molte di noi sanno che la domanda seguente è “e adesso?”, e poi che da questo punto i litigi, le decisioni, i pericoli e le speranze prendono il via.


[Alt Text: due vasi di fiori recisi in casa di Émilie, uno sul tavolo del soggiorno, uno sul comodino.]
L’onda d’urto, però, colpisce anche gli spettatori maschi quando capiscono che Varda ha spedito loro una cartolina dal paese del patriarcato indiscusso: per la prima volta vedono da fuori i privilegi di cui godono, smascherati. Chissà come dev’essere riconoscersi in François, a cui è concesso sostituire una donna per l’altra, a suo piacere, senza conseguenze, senza rimorsi, senza scossoni alla sua routine, anzi, con un’impennata della produttività del suo nucleo familiare. Provare quel tipo di libertà, solitaria perché fondata sulla schiavitù altrui. Ritenerla scontata, un diritto, una delle mille forme della natura. All’apparenza Varda non serba rancore, e nella stessa intervista del ’70 commenta:
Perché gli uomini si comportano come alberi. E se osservi gli alberi da vicino, per un certo tempo, noterai che anche loro cambiano, come gli uomini. Tutti sono rimpiazzabili, si dice, ed è vero, ma solo in termini di funzioni di una persona. E così per ogni singolo albero. Unico e soggetto a cambiamento. È questa la natura.


[Alt Text: Émilie annaffia una pianta in vaso nella casa che era di Thérèse. La nuova famiglia, vestita coordinata, passa una domenica autunnale nel bosco.]
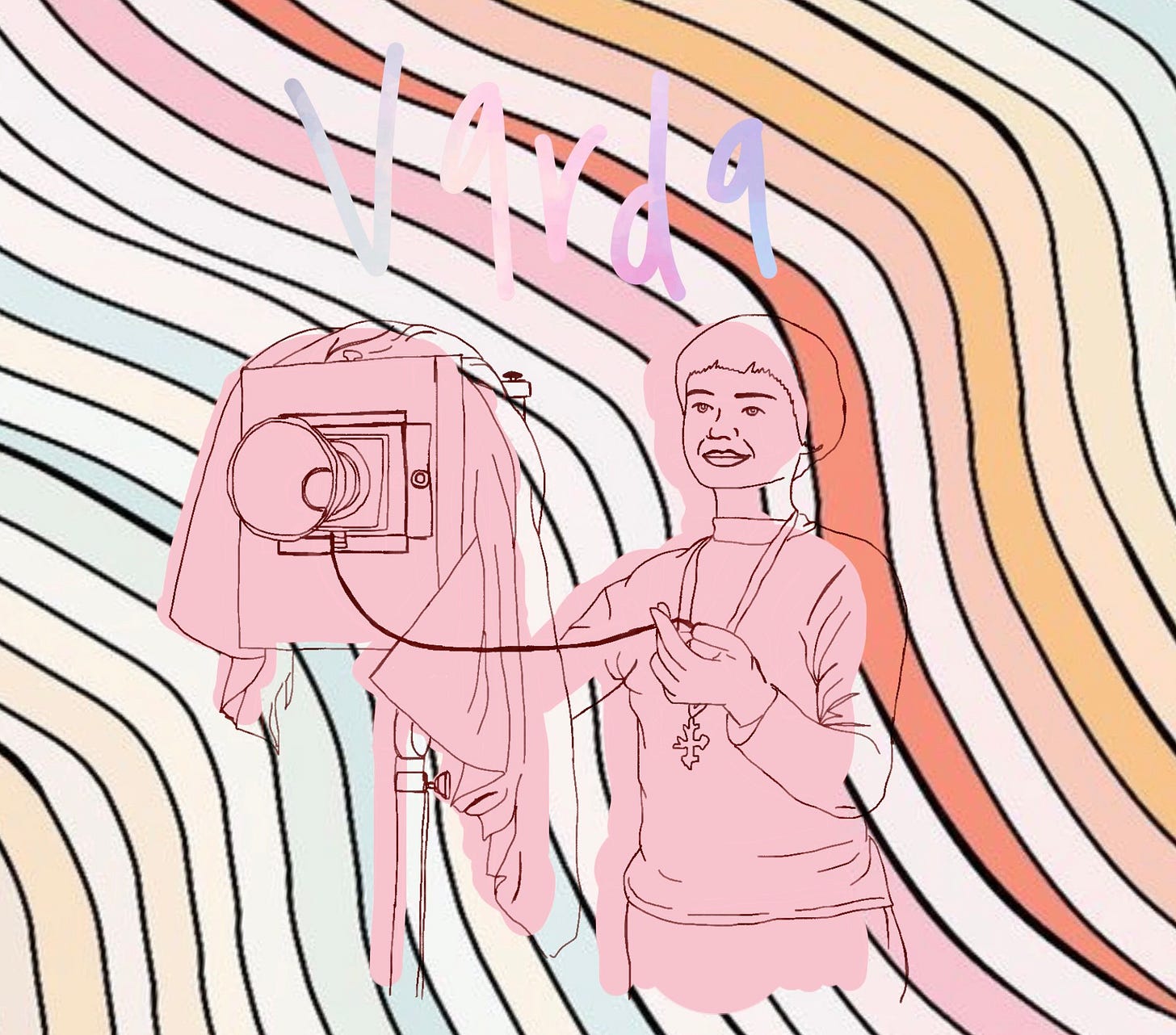
[Alt Text: illustrazione di una giovane Varda, in rosa, al lavoro dietro un apparecchio fotografico.]
Ringraziamo di cuore Chiara, Rebecca ed Ester per averci donato il loro lavoro! La seconda parte dello speciale Varda arriverà tra un mese, a metà novembre, ma ci rileggiamo (e forse incontriamo di persona?) prestissimo, il 31 ottobre.
Un abbraccio,
Francesca, Gloria e Marzia


