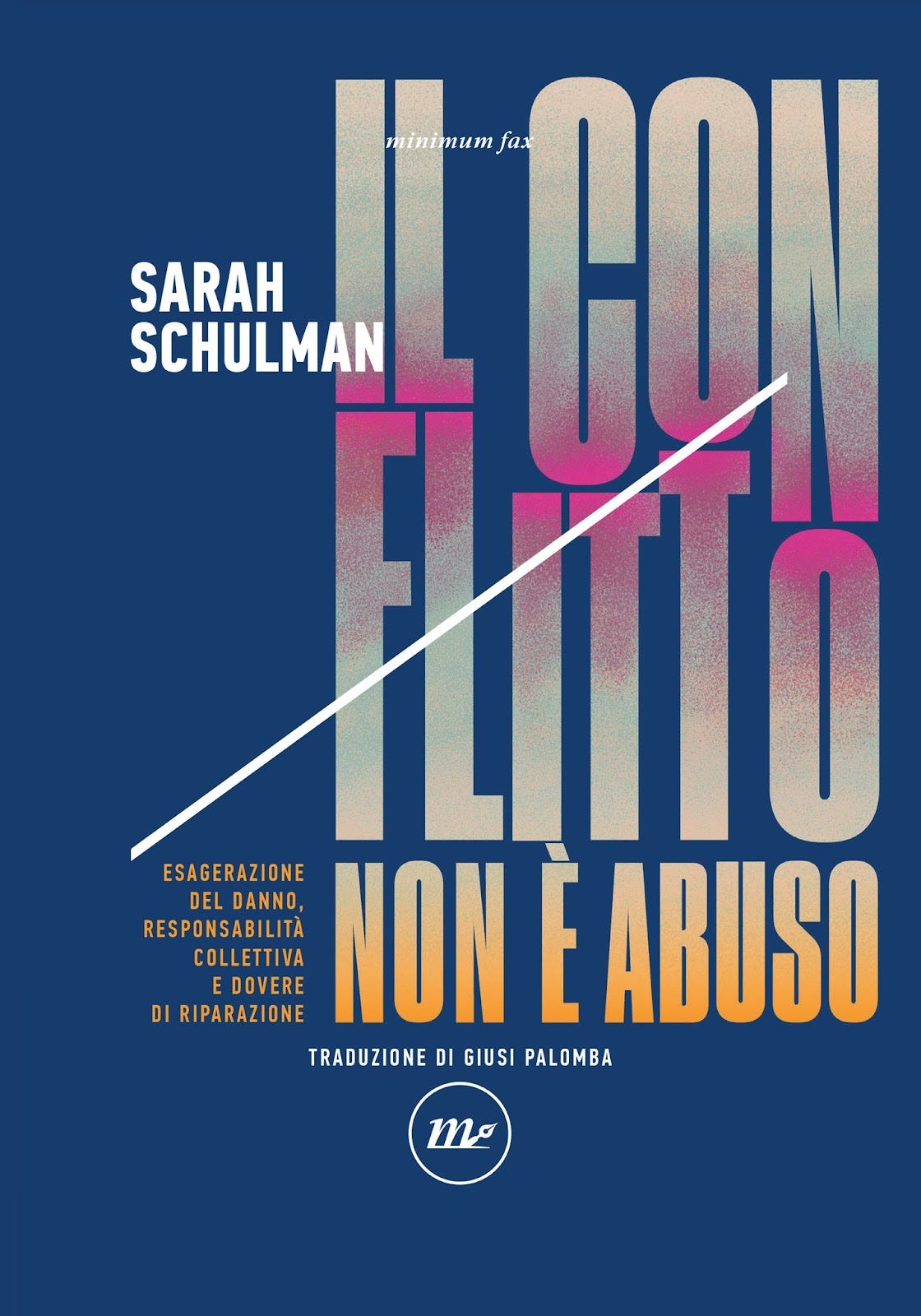La ghinea di settembre
Benvenutx a Ghinea, la newsletter orripilata. Questo mese torna Sara Giudice, a cui dobbiamo il nostro ultimo speciale, per un commento sulla serie Netflix La regina degli scacchi. Noi parliamo di Giorgia Meloni, del coraggio delle donne iraniane, e approfittiamo della traduzione italiana di Conflict is not Abuse di Sarah Schulman per rispolverare un nostro vecchio commento al riguardo. Buona lettura!
La regina degli scacchi e l’illusione del femminismo
di Sara Giudice
[Alt Text: fotografia in bianco e nero di una giovane Nona Gaprindashvili, impegnata in una partita di scacchi contro un avversario quasi del tutto fuori campo. Gaprindashvili è immortalata nell’atto di muovere un pezzo. Fonte.]
La regina degli scacchi (The Queen’s Gambit) viene reso disponibile su Netflix nell’ottobre del 2020. È la storia di Beth, Elizabeth Harmon, che scopre il suo talento per il gioco degli scacchi e comincia la scalata verso il successo internazionale, mentre affronta relazioni romantiche instabili, difficoltà a gestire la propria sfera emozionale e ciò che le rimane della sua difficile infanzia, fra la perdita della madre e l’adozione in tenera età.
Se l’evoluzione personale della protagonista scaturisce troppo spesso in sequenze in cui Beth, fra episodi depressivi e maniacali, non ha mai il diritto di non essere un bel corpo da consumare, è anche vero che altrettanti problemi si riscontrano nella gestione della trama orizzontale. Uno di questi, in particolare, ha portato Nona Gaprindashvili a fare causa alla piattaforma per 5 milioni di dollari, nel settembre 2021. Gaprindashvili, Grandmaster già nel 1978, georgiana di nascita, inizia la sua carriera in tenerissima età negli spazi, i tempi e le regole dell’Unione Sovietica, ma per gli autori de La regina degli scacchi (ambientato fra gli anni ’50 e ’60), Gaprindashvili non solo non ha mai affrontato giocatori uomini, ma esiste in una compartimentazione di genere totale che non si riscontra nella realtà.
Al centro della causa c’è l’ultimo episodio della miniserie: poco prima della metà dell’episodio, il commentatore del torneo che vedrà Elizabeth campionessa afferma che “[…] the only unusual thing about her really is her sex, and even that’s not unique in Russia. There’s Nona Gaprindashvili, but she’s the female world champion, and has never faced men” (The Queen’s Gambit, 1x07). Questo non è solo storicamente falso, ma ha portato alla luce questioni che per Gaprindashvili sono di natura personale, nonché diffamatoria della sua carriera e della sua posizione nel mondo degli scacchi, e per tutti gli altri sono questioni di responsabilità autoriale.
In un articolo comparso su Deadline nel gennaio di quest’anno, si riportano alcune informazioni interessanti rispetto alla difesa di Netflix. I rappresentanti della piattaforma rivendicavano il diritto di mettere mano alla materia storica a fini narrativi. Inoltre, sempre nell’articolo sopracitato, si fa riferimento alla presunta intenzione narrativa “femminista” della storia, che dovrebbe rafforzare la produzione di fronte a questo tipo di accuse.
Ma sono proprio queste presunte intenzioni autoriali che fanno emergere interrogativi importanti.
Se la storia nasce come narrazione di matrice femminista, questo presuppone che il rapporto di potere fra la protagonista e la società fallocentrica in cui esiste deve essere messo in discussione, in un modo o nell’altro. Ciò non accade – e non per la costruzione del corpo di Beth all’interno dello schermo televisivo, volto al consumo da parte di uno sguardo maschile, bensì proprio per quello che è il rapporto fra il corpo femminile fittizio (Beth) e quello organico (Gaprindashvili). Le modalità con cui la scacchista reale viene messa in scena dalla narrazione statunitense è un’operazione di scavalcamento che non può essere ignorata. Come possono coesistere due cose tanto opposte? Da una parte la cancellazione di una carriera lunga una vita, incarnazione di un talento reale e tangibile, e dall’altra la costruzione di un personaggio femminile, in una produzione audiovisiva che evidentemente non considera la possibilità di rivolgersi a uno spettatore non-maschile. Se è vero che l’abuso di alcol da parte della protagonista ha la funzione di descrivere la sua interiorità travagliata à la A beautiful mind (R. Howard, 2001), è anche vero che a Beth è concesso di vivere i propri problemi personali solo se può farlo in mutande. Questo già contraddice la piattaforma e, anzi, rafforza la posizione di Gaprindashvili: non c’è nulla di diverso, nella storia, dal desiderio di far prevalere uno spirito statunitense rispetto a uno sovietico, anche se per farlo bisogna sacrificare qualche donna, vera o fittizia.
[Alt Text: frame da La regina degli scacchi. La protagonista Beth, interpretata da Anya Taylor-Joy, fuma e beve sul divano, indossando soltanto canottiera, mutande, e un cardigan che scende sul braccio e lascia scoperta una spalla. La piega dei capelli è come fresca, e le gambe perfettamente depilate sono appoggiate a un tavolino su cui si intravedono diversi oggetti fuori fuoco, tra cui una scacchiera. Fonte.]
Un caso similare a cui è interessante far riferimento risale al 2018. Allora FX e Ryan Murphy Productions uscirono senza troppi problemi da una causa per diffamazione aperta da Olivia de Havilland: l’attrice accusava la produzione di Feud: Bette and Joan (FX, 2018) di aver fatto di lei un personaggio spiacevole e di aver minato alla sua reputazione, ma il processo si concluse con un nulla di fatto, al fine di difendere la libertà creativa degli autori e dei produttori di mettere mano alla materia narrativa nel pieno delle loro possibilità. In quel caso, quindi, veniva considerato legale ricostruire una persona reale, ancora in vita al momento della messa in onda, con qualche libertà e inaccuratezza. Come riportato sul New York Times, inoltre, Netflix, insieme alla Motion Picture Association of America, firmarono una memoria legale (amicus brief), per posizionarsi dalla parte del network e della libertà di espressione – un gesto coerente con il comportamento della piattaforma proprio nel più recente caso del 2021.
Seppure ci si muova qui nel campo della giurisdizione, è interessante vedere come non si riesca ad applicare una sentenza di taglia unica a ogni caso del genere. Le due cause riguardano, sì, entrambe la diffamazione di una persona reale attraverso una narrazione fittizia, ma esistono all’interno di impianti unici e non intercambiabili.
Il personaggio di Beth si inserisce, come già accennato, in un contesto narrativo che vuole rendere subalterni gli spazi e i tempi del gioco degli scacchi sovietico a quelli americani, mettendo a paragone il personaggio finzionale di Beth e la carriera reale di Gaprindashvili. Per quanto possa risultare legittimo il cambiamento di eventi storici in funzione delle proprie necessità narrative, La regina degli scacchi non è un pezzo di fantascienza, o anche solo fiction speculativa: è un coming of age di ambientazione storica, in cui una giovane donna supera le proprie difficoltà, personali e sociali, e diventa campionessa del gioco degli scacchi. Che durante il torneo finale si nomini Nona Gaprindashvili e si ridimensionino (in negativo) i suoi traguardi e la sua carriera più ampiamente intesa non è solo di cattivo gusto, ma soprattutto superfluo. Qual è il guadagno, per lo spettatore? Cosa aggiunge tale paragone con la Gaprindashvili finzionale, la cui presenza è assolutamente gratuita? La risposta è: niente. La presenza di Gaprindashvili non è uno struggle ulteriore per la protagonista (l’eroe della storia), che non percepisce nemmeno la presenza della presunta “competitrice”. Piuttosto, si percepisce il paragone, attraverso il commentatore del torneo, come una proiezione degli autori (Scott Frank e Alan Scott), che evidentemente necessitavano di creare un’immagine dell’Unione Sovietica “fragile” attraverso due corpi femminili, Beth Harmon e Nona Gaprindashvili, entrambe pedine nelle mani degli scrittori.
La narrazione che nell’articolo di Deadline veniva dichiarata “femminista”, si riduce così a una narrazione femminile, profondamente assoggettata a necessità occidentali e fallocentriche che sfociano in una risoluzione consolatoria e celebrativa tipicamente statunitensi.
Sara Giudice (1996) ha iniziato a studiare teatro, danza e performance art, ma ora si occupa di televisione, nello specifico di Rai. Il suo campo di interesse è la narrazione dei corpi a-normali nei media, tema che approfondisce anche nel progetto indipendente Crip 101. Ha fatto parte del collettivo Yawp.
Dell’ambiguità della figura di Giorgia Meloni, e di ogni donna di potere fintanto che gli assetti di potere non muteranno in modo decisivo, non possiamo liberarci con uno strillo. Per questo, dopo il contributo di Ida Dominijanni proposto nello scorso numero, segnaliamo due riflessioni che in parte se ne discostano, apparse su Machina: nella prima, Valeria Finocchiaro si domanda quale sia il posto di Meloni e di chi l’ha preceduta "nell'album di famiglia del femminismo”, prendendo le mosse dalla considerazione che
se anche Meloni non dovesse portare a termine nessuna politica femminista in senso stretto, se cioè in fin dei conti la sua elezione non segnerà nessun passo avanti sul campo delle politiche di genere, possiamo senz’altro dire che è vero il contrario, e cioè che è grazie al femminismo, alla sua diffusione in ogni segmento della società, alla sua capacità di modificare il nostro immaginario fino alle radici più profonde che Meloni ha potuto compiere la sua scalata al potere. Che Meloni abbia potuto fare a meno del femminismo è dunque certamente falso, ma allora bisognerebbe mettere in discussione anche l’altro lato dell’equazione, il che significa affermare che l’emancipazione femminile collettiva si nutre anche di episodi storici come l’elezione di donne come Thatcher o Merkel, vale a dire episodi in cui donne potenti che rifiutano il femminismo e che non vi si richiamano, agiscono – loro malgrado – da femministe nell’esercizio della propria autonomia.
Finocchiaro rifiuta, quantomeno sul piano teorico e filosofico, l’assioma che vuole femminismo e antifascismo indissolubili, e allarga il campo d’azione del femminismo coinvolgendo le persone e le fazioni politiche non necessariamente di sinistra per cercare una nuova definizione di autonomia rispetto al maschile.
Il secondo pezzo, a firma Francesca Ioannilli, Veronica Marchio, e Gigi Roggero, parte da qui per suggerire una riarticolazione del sistema patriarcato (ma soprattutto del sistema capitalismo) proprio in reazione non solo alle lotte femministe, ma all’ingresso delle donne nei luoghi del potere – e questo ingresso non è passivo, ma determina una mutazione nell’esercizio di tale potere.
In questo estratto dal suo nuovo saggio Gentrification is inevitable and other lies (Verso Books, 2022), Leslie Kern illustra il linguaggio bonario adoperato dai media per raccontare la gentrificazione, concentrandosi sulle parole e frasi ricorrenti che descrivono il fenomeno come necessario e inevitabile. La teoria dell’evoluzionismo biologico e la medicina prestano molti lemmi ai pezzi sulle trasformazioni urbane: i quartieri “si evolvono” anziché cambiare, “si adattano” piuttosto che essere stravolti, hanno “cuori pulsanti” e “arterie” e “centri nevralgici”, in un balzo metaforico che assoggetta le città a leggi naturali e dunque ineludibili. L’aumento dei prezzi degli immobili, l’omologazione delle attività commerciali, l’espulsione di famiglie povere, e tutti gli altri fenomeni (più o meno violenti) che si accompagnano alla gentrificazione di un’area urbana, divengono così parte di un processo organico anziché di un progetto umano e sfuggono, veloci, al giudizio politico e morale.
Dispaccio da Patras, tappa obbligata per ə migranti che pianificano di entrare nell'Unione Europea seguendo la rotta balcanica. Chiara Martini racconta la vita sospesa delle persone bloccate dalla burocrazia e accampate in ex fabbriche situate nell'area portuale della città, così da rimanere lontane dai luoghi frequentati dai turisti, e il cosiddetto "Gioco", vale a dire i tentativi di nascondersi nei camion che verranno poi imbarcati per l'Italia.
bell hooks, nelle parole affettuose di Sarah Ahmed.
In Iran non si fermano le proteste causate dall’omicidio della ventiduenne curda Mahsa Amini, avvenuto il 16 settembre. La ragazza è stata arrestata dalla polizia religiosa in un parco di Teheran perché non indossava correttamente il velo, ed è stata subito trasferita in un centro di detenzione e rieducazione per donne colte in violazione del decoro femminile prescritto dallo stato iraniano. Qui, secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, sarebbe caduta e avrebbe battuto la testa, per poi morire in ospedale dopo due giorni di coma. Ma le testimonianze oculari di chi era presente all’arresto e delle altre detenute smentiscono questa versione, e riferiscono di aver assistito al pestaggio della ragazza. Come spiegato dal collettivo anarchico locale FAE in questa intervista, i metodi violenti e le percosse non sono di certo un’eccezione nell’operato delle pattuglie religiose, che sono formate da militari di leva: non è raro che le donne vengano picchiate già in occasione dell’arresto, e poi scaraventate in strada dalle camionette al momento del rilascio, ed è naturale supporre che nei centri di detenzione la violenza prosegua, o addirittura peggiori. Il caso di Mahsa Amini ha infatti almeno un precedente: nel 2007, anche Zahra Bani Yaghoub, una dottoressa di ventisette anni, morì dopo essere stata arrestata dalla polizia religiosa, e il fatto fu derubricato a suicidio malgrado le insistenze della famiglia della donna affinché venisse svolta un’indagine sulle sue ultime ore di vita.
Tre giorni dopo la morte di Mahsa Amini, il canale informativo Iran International ha ricevuto il leak dell’autopsia. Il corpo presentava una frattura del cranio e un edema cerebrale, che secondo chi ha condotto l’autopsia sono da attribuire a “numerosi” colpi sulla testa, incompatibili con la ricostruzione fornita dalla polizia ma congruenti con un pestaggio. Le proteste nelle strade e nelle piazze erano già iniziate prima della morte di Mahsa Amini ma sono esplose il 16 settembre, allargandosi in quasi tutte le province dello stato e in tutte le più grandi città, e sono trainate dalle donne sebbene la partecipazione maschile sia corposa. Nei video e nelle fotografie disponibili, molte donne si tolgono l’hijab per poi bruciarlo, o si tagliano i capelli, e così facendo rischiano la vita. La risposta dello stato, inizialmente non più aggressiva del solito, è infatti diventata feroce: a oggi (29 settembre), 76 persone sono state uccise dalla polizia e dall’esercito, e ci sono stati numerosi arresti anche fra lə reporter presenti per documentare la lotta.
[Alt Text: moto della polizia in fiamme durante le proteste a Teheran.]
Per saperne di più:
Giulia Siviero ha raccolto le reazioni di alcuni movimenti femministi internazionali e di diverse studiose agli avvenimenti degli ultimi giorni
Democracy Now ha intervistato Negar Mortazavi, giornalista di origine iraniana e creatrice di The Iran Podcast
La solidarietà internazionale si è manifestata soprattutto sotto forma di proteste di fronte alle ambasciate iraniane (anche in Italia)
Una lettera di Mona Eltahawy alle donne bianche e occidentali che osservano da lontano
CALENDARIO
Il 16 ottobre Marzia sarà a Bologna, al Tank - Serbatoio culturale in via Zago 14, per parlare di letteratura (e) queer nell'ambito della rassegna String Events. Ci vediamo alle 19?
FATTO DA NOI
Marzia ha partecipato a Poesiaeuropa. Nel suo intervento ha parlato di “frocizzare i confini” (grazie a Nina Ferrante, che ci ha fatto riflettere sulla terminologia in questo speciale) e ha letto una poesia contro l’imperialismo britannico in onore della morte della regina.
FATTO DA VOI
Su Limina, Anna Maniscalco recensisce Abitare stanca di Sarah Gainsforth.
Chiara Zanini e Federica Fabbiani Galleni hanno intervistato Céline Sciamma.
La storia delle Pussy Riot, raccontata da Giorgia Maurovich.
[Alt Text: fotografia recente delle Pussy Riot. Lo scatto è professionale e inquadra le tre donne in primissimo piano, una dietro all’altra. Tutte indossano un passamontagna colorato: rosa, giallo fluo e viola. Fonte.]
UN LIBRO
Il conflitto non è abuso. Esagerazione del danno, responsabilità collettiva e dovere di riparazione di Sarah Schulman (minimum fax, 2022)
In occasione della traduzione italiana di Conflict is not Abuse, curata da Giusi Palomba e da poco uscita per minimum fax, riproponiamo la nostra recensione del testo apparsa nel numero uscito a maggio 2020, in cui discutevamo anche della difficoltà di tradurre nella nostra lingua i concetti espressi da Schulman. Per questo motivo abbiamo lasciato le nostre traduzioni anziché aggiornare il pezzo con quelle di Giusi.
[Alt Text: copertina di Il conflitto non è abuso, che presenta solamente il titolo del testo su fondo blu. Fonte.]
Scrivere del saggio del 2016 di Sarah Schulman Conflict is not Abuse presenta una serie di problemi lessicali: dato che nessuno dei lavori di Schulman è stato tradotto in italiano significa, per prima cosa, assumersi la responsabilità di proporre una traduzione di appoggio – provvisoria – dei concetti trattati, e dei loro nomi. La difficoltà principale, in realtà, è nel fatto che il pensiero italiano non possiede la stessa varietà di vocabolario (attenzione: non inferiore o insufficiente, ma semplicemente diversa) della speciale branca di sociologia narrativa di cui Schulman fa sfoggio.
In italiano “abuso” è, già di per sé, l’eccesso visibile, l’azione violenta, la costruzione illegale: ha il potenziale di un’azione generica, può avere valenza sia materiale che concettuale, suscitare reazioni ed effetti per una persona sola, un gruppo ristretto, una comunità allargata. Tradurre Conflict is not Abuse in “Conflitto non è abuso” è fuorviante rispetto all’operazione di estensione concettuale che Schulman tenta con il suo saggio. Riportare il significato angloamericano di abuse al suo valore polisemico più ampio – l’uso di qualcosa in una maniera nociva o moralmente sbagliata, il trattamento ingiusto, violento o crudele di una qualunque persona – è quello che Schulman si propone di fare. Abuse/abusive non è necessariamente o principalmente una caratteristica delle relazioni romantiche precipitate nel disagio, piuttosto, una parola che identifica e descrive relazioni tra pari in cui l’equilibrio è sbilanciato da violenze di vario tipo.
In italiano, però, togliere l’abuso dal conflitto sembra fare un torto alla diffusione dell’idea alla base di una presa di coscienza, individuale e collettiva, che può salvare vite. Significa complicare, quasi contraddire un concetto – quello della violenza di genere – che è ancora troppo debole nel dibattito italiano. In italiano parliamo di “violenza domestica”, “relazione violenta” per indicare quello che in inglese è, semplicemente, abuse. Infatti è comune l’uso dell’originale inglese anche in conversazioni italiane tra conoscitrici della materia, capita di incontrare l’errata italianizzazione “abusivo”, si sta facendo spazio la versione “abusante” o “maltrattante” per indicare sia la relazione che la controparte aggressiva. Finché il linguaggio stesso per descrivere il contesto di femminicidi, abusi sessuali e violenze domestiche resta gergo tecnico, dal suono grezzo e innaturale quando inserito in un discorso ordinario, la liceità del problema che vuole illustrare resterà incerta e contestabile. Importare strutture concettuali e pratiche testate in contesti peculiari, cercare di applicarle senza adattamenti, restrizioni, aggiunte a contesti politici, culturali e soprattutto linguistici diversi: un atteggiamento a volte ingenuo e spesso pericoloso, da controllare anche quando si affronta la lettura-commento di un testo ibrido come quello di Schulman. Il rischio di fornire contro-argomentazioni ai detrattori della violenza di genere, o suggerire che ogni tipo di violenza subita possa essere decostruita come un semplice caso di conflitto, o insinuare che senza prove non è possibile credere alle vittime, tuttavia, non ci appare come un’eventualità tale da farci desistere dal considerare, attraverso le argomentazioni di Schulman, le criticità al sistema concettuale, sociale e legale che stiamo creando. Il pericolo, al contrario, non sussiste una volta letto per intero il testo di Schulman. D’altronde, una delle citazioni di Edward Said scelte da Schulman stessa in apertura del secondo capitolo lo chiarisce: “la critica deve essere intesa come qualcosa che potenzia la vita”.
Schulman non è una negazionista dell’abuso relazionale, al contrario, legge simili dinamiche di abuso in contesti che non hanno nulla a che fare col genere, o molto più grandi di famiglie e coppie. La metodologia di Schulman è mista, volutamente non accademica, ma aneddotica, la ricerca fondata prevalentemente sull’esperienza piuttosto che sull’esperimento o la statistica, il lessico di lavoro preso in prestito da conversazioni private, corsi di aggiornamento, email e racconti di terzi. Sarah Schulman è una scrittrice e attivista statunitense, insegna all’università pubblica di New York e si occupa soprattutto della storia dell’epidemia di AIDS negli USA tra gli anni ’80 e ’90. Il suo pensiero è radicato nei luoghi in cui vive e informato dalla storia geopolitica che ha vissuto, e questa specificità contribuisce a complicare la traduzione e l’applicabilità delle sue idee nel nostro contesto. Il principio secondo cui Schulman pensa è lo stesso che applica alla sua scrittura creativa, buon senso piuttosto che pratica filosofica: “C’è un motivo per cui le persone agiscono in un certo modo”, “Le verità possono essere multiple, e sono rivelate dall’ordine degli eventi”. I suoi casi studio sono litigi tra coppie di amiche lesbiche, storie di persone con HIV discriminate dalla legislazione canadese attraverso l’obbligo di dichiarazione della sieropositività, l’occupazione israeliana in Palestina, incomprensioni con studenti o colleghi docenti, il razzismo violento della polizia statunitense. La dinamica di potere comune a tutti gli esempi di Schulman si riduce al quesito: come reagisce la comunità quando esiste un conflitto tra i suoi membri? Cerca di distinguere il conflitto normativo – il litigio fisiologico che nasce dalla differenza – dall’abuso di potere? Se sì, incoraggia la comprensione tra le parti oppure ripudia, a mo’ di capro espiatorio, la controparte a cui viene data la colpa? E se riscontra un abuso, si sforza di promuovere una qualche forma di giustizia riparativa?
Al centro della mia visione c’è il riconoscimento che, prima di tutto, la fonte della risoluzione è nella comunità attorno al Conflitto. La comunità detiene la responsabilità di opporre resistenza davanti a una reazione eccessiva alla differenza, e offrire alternative di comprensione e complessità. Dobbiamo aiutarci a vicenda per indicare e contrastare il ruolo dell’esagerazione del danno (‘overstating harm’) invece di usarla per giustificare crudeltà.
Schulman lamenta la tendenza a usare abuse esclusivamente nel contesto del regolamento di questioni private, ed è critica rispetto alla prassi che ha stabilito abusive come parola d’ordine, epiteto insindacabile per distinguere la persona “buona” da quella “cattiva”. Ormai, secondo Schulman, sembra sufficiente pronunciare la parola abuse o usare frasi fatte come he’s abusing me, o she’s abusive, per vedersi garantite attenzione, protezione e, soprattutto, la parte della ragione. Ma, ci ricorda, esistono zone grigie molto più comuni e sfumate (e complesse) di nette divisioni tra bianco e nero. Tradotto in italiano, il problema sembra non sussistere perché la lingua non permette un’ambiguità tale: nessun* direbbe del/la partner “è abusante” o “mi abusa”, la richiesta di aiuto implica in sé la descrizione precisa dell’azione commessa – “mi picchia”, “mi impedisce di uscire”, “controlla il mio conto corrente”, ecc. – e proprio questa precisione, come vedremo più avanti, permette una migliore valutazione caso per caso, oltre che traslare la prassi oltre la violenza domestica o di genere. Schulman ammonisce contro la “verginità etica” che si accaparra chi si definisce “vittima”: uno status di intoccabilità garantito dall’assenza di domande o richieste di spiegazioni da parte della comunità che attornia i soggetti. In un Twitter thread che abbiamo segnalato nella Ghinea di novembre, Vincenzo Latronico scrive che non è necessario credere subito, però bisogna aspettare a dubitare. Ci sembra che entrambi stiano indicando una sfumatura etica essenziale: nel momento in cui una persona lamenta un’ingiustizia è doveroso credere che il suo dolore sia valido, meritevole di indagine e fact-checking. Dare ragione senza ombra di dubbio alla controparte che si definisce offesa, perché corrisponde all’identikit della vittima tipo, perché è una donna contro un uomo, o la persona opposta a quella che vogliamo cancellare.
Il binarismo vittima/abuser, scrive Schulman, semplifica la confusione etica stabilendo a priori torti e ragioni, cancellando l’idea che la relazione è creata da azioni e reazioni di più parti, ognuna con una propria versione, preoccupazioni e diritti da tenere in considerazione. La responsabilità cui accenna Schulman non è ammissione di colpevolezza, o una variante di “eh ma l’avrai provocato!”, quanto una valutazione della propria presenza, una riflessione sul proprio ruolo all’interno della relazione. E ognun*, a prescindere dai torti subiti, ha una responsabilità rispetto a quello che dice e fa: “Avanzare un’accusa non ci dà ragione, arrabbiarsi non ci dà ragione, rifiutarsi di comunicare non ci dà ragione. Invece, tutte queste cose potrebbero farci sbagliare di grosso”. Il paradosso, Schulman nota, è che mentre molte persone, soprattutto donne, faticano a riconoscere e a vedere riconosciuto l’abuso fisico, psicologico, economico di cui sono vittime, molte altre persone, donne incluse, definiscono “abuso” situazioni e sentimenti che non riescono a controllare, risolvere o negoziare, anche se si tratta di conflitti in cui hanno una parte di responsabilità.
L’ingiustizia permessa dalla lingua inglese che Schulman denuncia, però, non è affatto affine al victim-blaming, all’atmosfera pretestuosa di “caccia alle streghe”, al terrore di essere denunciati – metooed – sotto il regime della cancel culture. Al contrario, Schulman si chiede come e quando è successo che solo denunciandosi come vittime di un abuso si ha la garanzia che il proprio dolore verrà riconosciuto e preso sul serio. In una società che raziona compassione e strumenti di supporto, drammatizzare il proprio conflitto per sollecitare attenzione è la mossa più elementare. Ogni sofferenza è legittima – percepire violenza come tale la rende autentica – ma nessuna sofferenza legittima la perpetrazione di altri attacchi. E se la distinzione tra conflitto e abuso non è chiara, anzi, se i due concetti vengono trattati come sinonimi di una stessa violenza, il ciclo dell’aggressività si autoalimenta.
A Schulman non interessa, o forse non si perita di definire che cosa costituisce un abuso, preferisce recuperare il potenziale evolutivo del conflitto, e separare i due concetti osservando dinamica e carattere del potere. Se si tratta di power struggle, “lotta di potere”, è un conflitto tra volontà e desideri discordi, da risolvere senza dichiarare un vincitore, ma esplorando uno spazio di evoluzione per le parti. Se si tratta di power over, “presa di potere”, l’abuso è inevitabile perché il controllo della relazione è sbilanciato. Schulman non spiega come orientarsi nella zona grigia tra lotta e presa di potere: invita a usare buon senso, individuale e soprattutto comunitario.
Schulman fa risalire alla prassi culturale dell’esagerazione del danno (“overstating harm”) la tendenza a fondere conflitto e abuso:
Senza in alcun modo minimizzare il ruolo della violenza nelle nostre vite, osservo, simultaneamente, come l’amplificazione retorica della minaccia confonde l’assenza di azioni, il conflitto normativo e la resistenza con l’abuso autentico hanno prodotto una diffusa pratica di esagerazione del danno. E l’esagerazione del danno spesso si esprime con il ripudio (“shunning”), il rifiuto letterale di parlare di persona con un altro essere umano, o un gruppo di persone, un’esclusione delle loro informazioni, l’attivo impedimento che una persona possa essere ascoltata e la presunzione che non esistano.
Quando qualcosa come un litigio, un’opinione diversa, una delusione, un fenotipo, la sieropositività, la resistenza all’occupazione militare viene ricostruita e raccontata come un attacco, secondo Schulman si tratta di drammatizzazione. È mediante la complicità del gruppo – il sistema di amici, “the cadre of friends” – che si elabora una definizione del danno tale da renderlo risultato di un abuso, invece che scontro tra parti in conflitto. Un gruppo che alimenta un pensiero distorto, pretende alti livelli di controllo dei suoi membri e non tollera differenze o autocritiche opera secondo un’ideologia suprematista le cui basi, però, possono essere radicate in un trauma passato o condizionamenti legati a stati d’ansia o malattia mentale, oppure frutto di una fabbricazione politica. In sostanza, condizionamenti che impediscono di considerare il quadro generale di una situazione e immaginare conseguenza a lungo termine per tutte le parti in causa.
Se la comunità è il crocevia delle definizioni di conflitto, abuso, punizione e riappacificazione, Schulman indica nella conversazione lo strumento più efficace per avvicinarsi alla risoluzione del conflitto. Tuttavia, è importante sottolineare che Schulman sceglie volutamente di limitarsi alla gestione del conflitto che non ha bisogno di ricorrere all’assistenza istituzionale. La giustizia di cui Schulman parla, infatti, non è da intendersi come obiettivo legale, e gli atti punitivi che descrive non sono penali, ma sociali. Non immischiarsi, badare ai fatti propri, rifiutare l’argomentazione contraria di amici, nemici e potenziali alleati se contraddice quella in cui vogliamo credere, dimostrare lealtà accettando come oggettivi resoconti di una sola persona, pensare per slogan riduttivi come believe all women, no means no (cui aggiungiamo not all men e all men are trash): pratiche sociali assimilate come diritti che Schulman definisce distorte, alla base di una logica fatalistica per cui “[...] il desiderio di riparazione è inteso come un assalto, la proiezione di fantasie negative è intesa come un diritto”.
Il controllo sociale basato sulla colpa e sulla vergogna causa resoconti semplificati in cui la complessità di ogni persona è necessariamente ridotta ai minimi termini per attrarre il beneficio della fiducia e il supporto della comunità: “In un mondo basato sulla colpa, le donne devono essere chiare per essere innocenti, quindi, sfortunatamente, evitare la colpa significa evitare la complessità, le contraddizioni, le ambivalenze”. “Capire che cosa sta succedendo è più importante che decidere chi punire”: fare domande è opportuno, fare le domande giuste è importante: “di cosa hai paura?”, “sei in pericolo, oppure di senti a disagio, arrabbiat_, ferit_?”.
A volte una persona nella nostra vita – amico, studente, vicina, parente – fa insinuazioni negative rispetto una terza persona (“è un abuser/partner violento”, “è una stalker”) e vuole che trattiamo con freddezza, escludiamo o puniamo in altri modi questa persona. La nostra prima responsabilità è determinare se la persona si trova esposta a una vera minaccia di violenza fisica. Se non lo è, dobbiamo chiedere di ripercorrere insieme l’ordine degli eventi in modo da rivelare le complessità della situazione e della sua storia. Non è etico ferire qualcuno solo perché ci è stato chiesto di farlo.
Il compito immediato che Schulman raccomanda per chi si trova a convivere in comunità con persone le cui azioni inaspriscono in gravità (“people who are escalating”) è capire quale trauma passato o paura per il futuro causano l’inasprimento della reazione nel presente: “questa è la responsabilità dell’amicizia autentica, la vera definizione dell’amore”. Nominare il dolore, indagarne l’origine, rintracciare responsabilità non per punire, ma per comprendere, accettare che il conflitto è causato da uno scontro tra le parti, ognuna delle quali include simultaneità di motivazioni, sfumature, debolezze e aree grigie, aprirsi all’autocritica, offrire o cercare aiuto: sono le azioni che la persona e il gruppo intenzionati a risolvere conflitti e riparare i danni degli abusi vogliono intraprendere.
Per approfondire: conferenze pubbliche di Sarah Schulman, e recensioni che evidenziano pro e contro della proposta di Schulman.
Ringraziamo Sara per il suo pezzo e ti aspettiamo a ottobre!
Un abbraccio!
Francesca, Gloria e Marzia
Ghinea è su Instagram, Facebook e Twitter tutti gli altri giorni del mese.
L’archivio completo dei numeri passati di Ghinea è accessibile qui.
Ghinea è un lavoro di amore e politica che realizziamo gratuitamente perché tempo e privilegio ce lo consentono. Puoi aiutarci inoltrando questa mail a qualcunx a cui vuoi bene (o a cui vuoi far cambiare idea?), condividendo link ed estratti citandoci sui social media, e seguendo i nostri profili.
Puoi aiutarci anche condividendo il carico: segnalaci articoli, eventi, temi, persone, libri, e questioni che per te sono importanti. Oppure puoi inviarci proposte per interventi e recensioni originali (su cui lavorare insieme) o pezzi già conclusi. Contattaci anche se disegni, fotografi, fai video o hai un’idea che potrebbe funzionare per Ghinea.
Per tutti i suggerimenti, apprezzamenti, critiche e correzioni scrivici qui.
Prendiamo in considerazione ogni proposta di collaborazione e recensione, ma ci riserviamo il diritto di trattare solo il materiale che ci convince appieno.
Ghinea rispetta la tua privacy. Iscrivendoti a questa newsletter ci hai dato esplicita autorizzazione a trattare i tuoi dati personali (indirizzo email). Leggi la privacy policy di Substack qui.