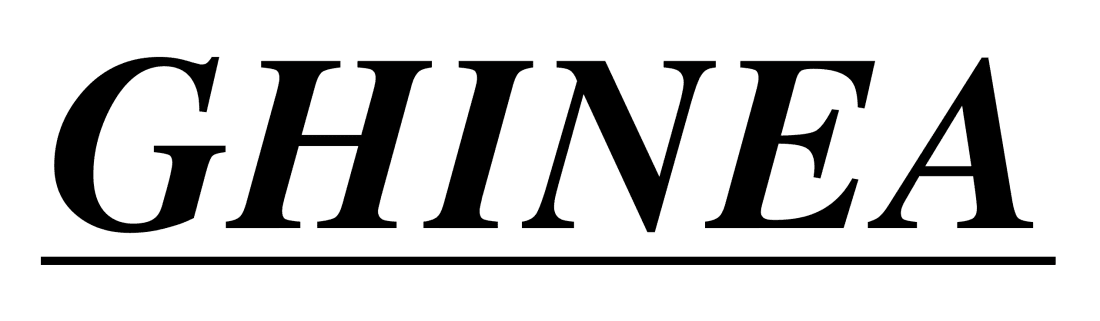Benvenutu a Ghinea, la newsletter dalla quale per disiscriversi basta cliccare l’apposito tasto in calce. Il numero di questo mese è felicemente affollato: ti presentiamo il primo libro di Giusi Palomba, in uscita a marzo per minimum fax (che ringraziamo), Giuliana Misserville torna con un contributo sull’ultimo romanzo di Nicoletta Vallorani, e Bianca Arnold ci parla di Bones and All e del potere di divorare. Buona lettura!
La trama alternativa. Sogni e pratiche di giustizia trasformativa contro la violenza di genere
di Giusi Palomba
[Alt Text: copertina del primo libro di Giusi Palomba. Una trama larga, ottenuta dall’intreccio di un filo viola elettrico e un filo celeste lavorati con un ferro da maglia stilizzato, circonda il titolo e il nome dell’autrice.]
Come facciamo a rendere una persona responsabile di un torto commesso, e allo stesso tempo a restare in contatto con la sua umanità quanto basta per credere nella sua capacità di trasformarsi?
Nel 1998 bell hooks pone questa domanda a Maya Angelou nel corso di un denso dialogo che tocca temi come la necessità dell’arte, della scrittura e della poesia, e poi della responsabilità collettiva e della compassione. Tutto è fedelmente riportato tra le pagine della rivista di ispirazione buddista Lion’s Roar e il dialogo è moderato dal caporedattore Melvin McLeod. Le due autrici si ritrovano a parlare del caso giudiziario che ha coinvolto il pugile Mike Tyson, accusato di stupro da Desiree Washington nel 1991, condannato a sei anni di prigione e scarcerato dopo tre. bell hooks racconta che negli anni in cui il caso dominava i media tutti volevano sapere per chi parteggiasse, senza nessuna ulteriore richiesta di riflessione, e ricorda di aver avuto la necessità di tenere insieme due tensioni: che Tyson rispondesse della violenza, ma che si aprisse anche un dibattito pubblico sulla cultura in cui Tyson era cresciuto e che l’aveva reso uno strumento di violenza. Sfortunatamente, era un dibattito a cui nessuno sembrava interessato.
Angelou allora le risponde chiamando in causa la polarizzazione della società: la scelta di schierarsi e basta, sebbene possa essere complicata, è di sicuro il modo più semplice di affrontare la complessità del reale. È un po’ come strappare la realtà in due esatte metà e scegliere di vederne soltanto una. Eppure, l’altra parte, il resto della realtà, continua a esistere, anche se appare sfocata e fumosa, anche quando ignorata.
Venticinque anni dopo siamo sempre lì: la realtà è ancora polarizzata come notava Angelou, e il dibattito a cui aspirava hooks è ancora inesistente. La violenza di genere, intanto, continua a invadere le relazioni intime e quelle pubbliche, e come la ruggine che corrode piano piano un meccanismo, rende molto complicato – quando non impossibile, o insopportabile – far funzionare la vita in comune.
Nel 2020 ho raccontato una versione molto ridotta della storia che è la prima parte di questo libro in un articolo pubblicato sulla rivista Menelique. L’impatto è stato più che inaspettato: il pezzo è stato letto da molte persone e, nel tempo, ho ricevuto molti messaggi e richieste di approfondimento, che ho cercato di soddisfare quando era possibile. Accanto ai messaggi di chi, per le più varie ragioni, considerava quella lettura un passaggio utile nella propria esperienza di elaborazione, ho ricevuto anche degli attacchi da persone, soprattutto donne, che vedevano nel mio articolo un’imperdonabile giustificazione per gli uomini che commettono violenza.
È qualcosa che mi turba ma che riesco a comprendere. In genere, l’idea di punire con l’esclusione e l’isolamento chi ha inferto un danno sembra l’unico modo possibile di garantire sicurezza, non c’è altro nella nostra immaginazione, nessuno ci racconta un’alternativa.
È stato importante iniziare a chiedermi in che modo si riconquista quello spazio di immaginazione, strappato alle certezze e ai percorsi obbligati, e in che modo si accresce la fiducia necessaria per innescare un confronto e si diminuisce il senso di minaccia che ne deriva. Che tipo di società può tenere insieme il superamento del punitivismo con la difesa di chi subisce la violenza?
I movimenti come il #MeToo hanno scosso dal torpore una società allenata a coprire gli uomini violenti, ma il femminismo che si è imposto negli ultimi anni ha spesso oscurato i margini e gli orizzonti del discorso, compresa la pratica di alternative alla punizione. Le critiche che hanno prodotto i femminismi più politici, e soprattutto i femminismi comunitari, decoloniali e anticarcerari, sono state completamente silenziate. Quello che è stato accolto a braccia aperte dai media è stato soprattutto un femminismo allineato con i valori neoliberali, in cui regna l’idea che le donne siano tutte uguali e per emanciparsi debbano sfondare il cosiddetto tetto di cristallo, conquistare il potere, aspirare al successo e occupare le stesse posizioni abitualmente occupate dagli uomini. Non importa quali idee incarnino, quali cambiamenti metteranno in atto, non importa se saranno portatrici delle stesse dinamiche oppressive: la sola rappresentazione delle donne di potere nello spazio pubblico è considerata emancipazione.
L’ambizione di questo femminismo è l’empowerment, nella sua accezione più individualista, legata a doppio filo al successo economico: la realizzazione sta nella carriera che permette l’accesso agli spazi del privilegio che prima erano negati. Ma questo accesso non è garantito a chiunque. È di sicuro più facile per chi si fa portavoce di un femminismo addomesticato, per sempre giovane, sensibile alle ricompense del mercato, avvezzo a smussare gli spigoli e a non avanzare mai critiche troppo scomode. Quello che si esprime principalmente tramite i media, i social, che frastorna e che produce incessantemente contenuti, sempre più lontano dalle storie reali, senza più genealogie.
L’enorme quantità di contenuti social di questi ultimi tempi ha cambiato in modo cruciale i modi in cui tradizionalmente si è fatta la politica orientata al cambiamento e alla giustizia sociale. Fino a qualche tempo fa, fare attivismo voleva dire avvicinarsi a qualche gruppo nel territorio in cui si vive, e piano piano partecipare alle iniziative, campagne, assemblee, proteste. E voleva dire anche adattarsi ad azioni, regole e dinamiche complesse, linguaggi non sempre facili da comprendere, a volte criptici e respingenti. Negli spazi virtuali invece, trionfa una lingua semplice, e l’accesso è garantito più o meno a chiunque abbia uno smartphone e un account sui social più diffusi. Fuori dai social ci sono figure e situazioni che intimidiscono chi è più introverso, chi viene da contesti marginali, chi per una ragione o un’altra non ha possibilità di partecipare nelle forme più tradizionali di protesta, mentre gli spazi dell’attivismo online più massificato rispondono meno a dinamiche di gruppo, a volte oscure, e più alle tecnologie su cui si fondano (altrettanto oscure). Ma c’è un prezzo invisibile che si paga e non si vede. Gli spazi delle piattaforme digitali di massa non sono neutri e indipendenti, non sono spazi liberati, ed è un po’ come se a un certo punto il fine si confondesse con il mezzo. Le forme del coinvolgimento si adattano alla struttura stessa della piattaforma: il protagonismo individuale, innanzitutto, i follower che ruotano intorno a un account che è il centro di potere, l’interazione ridotta al minimo e la facilità con cui si silenziano le voci contrarie.
Nel 2020, anno in cui inizia la pandemia, i social commerciali diventano canale di comunicazione e divulgazione privilegiato, superando i periodici scandali che li investono: le questioni legali sul trattamento dei dati, i problemi sulla salute mentale giovanile, i finanziamenti di gruppi sovranisti e organizzazioni di destra, senza tralasciare la questione della proprietà delle piattaforme, in mano a un ristretto gruppo di miliardari che si ritrovano a dover navigare in questioni importantissime come la libertà di espressione e l’integrità dell’informazione. Ogni tanto torno a fare visita al mio account Mastodon, una sorta di social alternativo, gestito senza poteri centrali, che esiste da tempo ma sta prendendo piede solo ora. È lì che ho letto un commento un po’ caustico di un’utente storica che mi è rimasto impresso: «Ora che siete arrivati in massa, evitate di portare da queste parti le logiche dei social commerciali!» Chissà fino a che punto queste logiche ci hanno in effetti già corrotto, tanto da non essere più in grado di riconoscerne gli effetti. Perché non bastano gli scandali e le crisi ad arginare il bisogno di comunicare, perché in fondo si fa quel che si può, con i mezzi a disposizione e quelli che troviamo più sostenibili in un dato momento per rimanere in connessione.
Forse, tra gli effetti più evidenti di questa esposizione massiva ai nuovi mezzi di divulgazione e comunicazione, c’è la perdita progressiva delle sfumature di senso. Ci permettiamo molto più facilmente di liquidare la realtà – e le situazioni complesse della realtà – in modo molto sbrigativo, non badiamo più ai contesti, facciamo più asserzioni che domande.
Anche l’attivismo femminista, nella sua versione online, ha subito un processo di semplificazione accelerato. Nei casi peggiori, lo sforzo per il cambiamento si riduce a un riassunto in grafiche Canva e liste nere e prescrizioni: cosa fare, chi odiare e chi idolatrare, un pacchetto completo di azioni da seguire, aggiornato quotidianamente. È il cosiddetto influencer feminism che irrompe sulla scena e raggiunge migliaia di follower e l’attenzione di molti brand. E sì, esattamente perché si sviluppa su social commerciali, la fiducia incondizionata riposta in personaggi di culto si tramuta in una vera e propria nicchia di mercato. Non si tratta di sostenere piccoli marchi indipendenti, o progetti per finanziare associazioni o gruppi no profit: questo successo attira l’attenzione di multinazionali e grandi marchi. Il mercato rincorre le giovani donne e lo fa sui loro canali, che non sono più i media tradizionali, ancora stretti in troppe maglie: i social, terra di nessuno in quanto a regolamentazioni del mercato pubblicitario, diventano una ghiotta opportunità di business, e la loro flessibile infrastruttura è in grado di accompagnare e condizionare le modalità di interazione per meglio rispondere alle proprie esigenze. Tocca capire a questo punto come misurare i passi avanti nella conquista di maggiore giustizia tra questi conflitti di interessi. L’aumento esponenziale di follower di pochi account dell’influencer feminism corrisponde a un progresso della società?
Giusi Palomba è originaria della provincia di Napoli e reduce di multiple emigrazioni. Oggi vive a Glasgow, in Scozia. Negli ultimi anni ha lavorato per lo più nella ristorazione, come cuoca o barista. Ha contribuito a organizzare iniziative di cultura e arte indipendente e militante, cospirando con gente meravigliosa. Ha pubblicato articoli per Laspro, Napoli Monitor, Pasionaria, La Falla, Altri Animali, Menelique, e accompagnamenti di opere artistiche e fotografiche. Scrive per fare più rumore della precarietà e dell’ansia.
Una bella intervista a Raquel Gutiérrez Aguilar, pensatrice e guerrigliera degli spazi e dei beni comuni.
Si scarica qui, gratuitamente, Homing/Ritrovarsi. Traumi E Translinguismi Delle Migrazioni In Morante, Hoffman, Kristof, Scego E Lahiri, un nuovo lavoro di Tiziana De Rogatis.
Un estratto da Insegnare il pensiero critico di bell hooks, da poco uscito per Meltemi.
Voglio essere vera. Vita e destino di Katherine Mansfield, è un podcast curato da Sara De Simone e Nadia Fusini. Si ascolta qui.
Nestlè: un durissimo reportage sul suo operato.
CALENDARIO
Appuntamento alla libreria Sette Volpi di Bologna: sabato 11 marzo Gloria presenterà Il senso della fine. Inesorabile storia d’amore di Marianna Crasto e dialogherà con l’autrice. Ci vediamo alle 18:30.
FATTO DA NOI
Marzia ha pubblicato su Argonline un estratto dal suo poemetto inedito “Conflitto”, tradotto una poesia di Lidia Riviello per Hunger Mountain, ed è stata ospitata da La Falla con la domanda “Cosa vuol dire letteratura queer?” (spoiler: non c’è risposta univoca o forse proprio risposta).
FATTO DA VOI
Un bel pezzo di Silvia Pelizzari su letteratura cilena e memoria.
Alessia Ragno scrive di Fausta Cialente.
Il 22 febbraio è uscito per effequ Il senso della fine. Inesorabile storia d’amore, il romanzo d’esordio della nostra amica Marianna Crasto. Ne puoi leggere (e ascoltare!) un brano tratto dal primo capitolo su inutile, rivista di cui Marianna fa parte insieme a Gloria, in qualità di redattrice, e di cui anche Francesca è stata redattrice. Trovi Marianna anche nell'archivio di Ghinea: ha scritto di Grace Paley e di Lucia Berlin.
[Alt Text: la copertina de Il senso della fine. Inesorabile storia d’amore raffigura una clessidra la cui ampolla superiore sta per svuotarsi del tutto. Dalla sabbia già presente nell’ampolla inferiore sbucano due fiori, uno viola e uno giallo e rosso.]
UN LIBRO
Le comunità impreviste di Nicoletta Vallorani: quando la fantascienza guarda al queer
di Giuliana Misserville
[Alt Text: primo piano di una sorridente Nicoletta Vallorani. Fonte.]
Considero Nicoletta Vallorani una di quelle scrittrici che, per caso o per intelligenza, hanno la funzione di fare da spartiacque tra un prima e un dopo, tra una narrativa che percorre storie tutto sommato lineari e una letteratura che improvvisamente realizza che qualcosa è cambiato e che occorre girare pagina, guardare a nuovi territori e a stilemi imprevisti.
Già nel 1992, quando uscì Il cuore finto di DR (vincitore del Premio Urania nello stesso anno), il romanzo di Vallorani aveva significato l'avvento di una nuova era della fantascienza italiana, quella in cui il genere diventava (altrove lo era già da decenni) questione di donne, autrici che pur scrivendo cyberpunk percorrevano strade loro proprie.
Stessa storia nel 2020. Dopo numerosi romanzi che sperimentavano vari generi letterari, Nicoletta Vallorani, con Avrai i miei occhi (Zona 42), tornava a alzare il tiro presentando un romanzo che, per cura e qualità di scrittura, portava la fantascienza nostrana nei territori della letteratura tout court, e a sottolineare questo innesto felice si era concretizzata la partecipazione del romanzo alla selezione del Premio Campiello e del Premio Napoli.
Con Noi siamo campo di battaglia (Zona 42), l'ultimo lavoro di Vallorani che ho tra le mani in questo momento, succede la stessa cosa, lo stesso cambio di pagina e di orizzonte – perché quello che l'autrice mette in campo nel 2022 è una fantascienza, italiana, che sembrerebbe guardare al queer come rivoluzione sociale necessaria.
Una rivoluzione che individua nello snodo giovan3-adult3 il perno saltato di una società che non sa più immaginarsi un futuro che non sia quello ripiegato sulle questioni del controllo e della sicurezza sanitaria. La funzione insegnante, esercitata da una cattedra o in qualsiasi angolo di strada open air, in qualsiasi discoteca, biblioteca o negozio di arti varie, sembra essere il punto di vista privilegiato dall'autrice, forse perché la scuola di ogni ordine e grado (Vallorani insegna letteratura angloamericana alla Statale di Milano) è divenuta la nuova linea di resistenza nei confronti di un potere che sembra avere dimenticato gli adolescenti e il loro futuro, come del resto possiamo leggere anche nelle ultime prove letterarie di Silvia Dai Pra', Laura Marzi e Gaja Lombardi Cenciarelli.
E Vallorani costruisce una storia che di resistenza e futuro molto dice, pur in un mondo devastato da un'epidemia che il potere ha saputo mettere a frutto per una svolta autoritaria.
Siamo sempre nella città di Milano, distopica come è nelle corde dell'autrice. La realtà di cui leggiamo ora è però impressionantemente simile ad alcuni momenti vissuti durante il lockdown e quindi si tratta di una distopia che estrae dal nostro presente istantanee e video per un album assai ansiogeno. Sono innumerevoli i riferimenti che Vallorani disperde tra le righe, raccontando così - si dice che la fantascienza sia la nuova narrativa sociale - l'ombra che abbiamo attraversato e che ancora ci sovrasta per gli esiti politici che ne sono derivati.
Nella Milano del romanzo di Vallorani, col mare che si è mangiato la Pianura Padana, i morti a migliaia, l'acqua razionata, le scuole chiuse e devastate, il suolo completamente cementificato per la paura che i miasmi assassini provengano dalla terra, seguiamo alcune creature compost. "Lukas, Amina, Luce, Attilio, Nina e Han - con le loro identità fluide - si muovono per le strade di Milano. Con loro Biz, che parla nei pensieri degli altri. Loro sono campo di battaglia. Non si arrenderanno", come recita il risvolto di copertina del volume. E non si arrenderà Carla, la prof, a cui dopo la morte della compagna sono rimaste solo le storie (sulla potenza delle storie è intervenuta più volte Ursula K. Le Guin) e pochi semi da piantare in un angolino dimenticato.
La polizia reprime in maniera assai cruenta le manifestazioni studentesche, e come se questo non bastasse un essere orribile si aggira a rubare le vite di chi deve fornire "volontariamente" corpi alla sperimentazione scientifica. Le partizioni del racconto sono orchestrate perché a un certo punto, a metà romanzo circa, sorga dalle pagine una voce nuova che non appartiene né a Carla né a quest3 nuov3 cucciol3 del maggio, ragazz3 perduti che hanno trovato nel fare giardino/fare mondo della prof. un nuovo punto di avvio. Una voce che dice "noi" e che è una sorta di promessa.
Quel noi è la voce di un soggetto plurale che mi arriva rimbalzato (e ne guadagno una consapevolezza che mi fa rileggere con occhi nuovi Noi siamo campo di battaglia) dalle pagine di un altro libro (Tessiture, Fandango 2022) un insieme di saggi in onore della studiosa e attivista italiana Liana Borghi, teorica femminista, lesbica e queer. Nel dialogo immaginario ma reale tra Liana e l'antropologa Elena Bougleux sulla quantum theory, il tentativo di avvicinare il comportamento degli atomi e i comportamenti umani mi aiuta a individuare il motivo del raffronto, la possibilità cioè che "i quanti possono aiutarci a riconfigurare modelli esistenti di società e di politica, a riflettere sul groviglio di scambi intrarelazionali fra umano e non umano (...)". Rivolgendosi a Liana, Elena immagina che:
Dicendo quasi-particelle, io so che tu percepisci (che) l'identità del soggetto, quell'antico concetto che produce isolamento, affievolirsi e sfumare in una fusione multiumana.
È a questa fusione che penso quando leggo il noi cui dà voce il romanzo di Vallorani, un noi che cerca negli interstizi lasciati scoperti dal potere il luogo in cui riconfigurare la propria resistenza.
Perché gli atomi, come i corpi degli umani, in un superfluido (l'insieme dei ragazzi) "generano invece collettivamente una condizione intrapersonale condivisa, spazialmente illimitata, sublimata in un common di materia-corpo-spazio" e "poiché viene messo al lavoro tramite dispositivi e reti affettive, - il queer - è portato a dialogare sulle pratiche di desiderio e a suggerire esercizi politici di trasformazione sociale, non solo delle intimità".
E questa condizione condivisa, questa common materia-corpo-spazio, questi esercizi politici che trasformano la dimensione sociale e quella intima, e che rimandano a una dimensione queer di quel "noi", tutto ciò informa la trama e le soggettività plurali di Noi siamo campo di battaglia. Filtrano così nella scrittura di Vallorani, senza che chi legge se ne accorga, le più recenti teorizzazioni delle studiose femministe. Abbiamo detto Liana Borghi ma anche Donna Haraway è evocata più volte nel romanzo per quel suo "siamo compost" ripreso come modalità di sopravvivenza in una città (o mondo) guasto. Insomma, la scrittura di Nicoletta Vallorani racconta di un vento nuovo in grado di generare soggettività e pratiche differenti. Le comuni vivaio che popoleranno le scuole di Milano saranno una rete silenziosa ma non inerte poiché da lì partirà la rivolta.
In gioco è il futuro e un nuovo modo di fare mondo che se sarà libero sarà anche queer.
Giuliana Misserville si occupa di critica letteraria femminista e la sua pubblicazione più recente è il saggio Donne e fantastico. Narrativa oltre i generi, uscito nel 2020 per Mimesis. Mentre, assieme a Federica Fabbiani ha ideato e realizzato “La mano sinistra. Il podcast delle storie fantastiche”, in corso di diffusione sulle maggiori piattaforme. Nel corso degli anni ha contribuito alla fondazione e diffusione della Società italiana delle letterate (SIL) di cui è stata Presidente nel biennio 2014-2015.
Fa parte della redazione di Leggendaria e per la rivista ha curato nel tempo il piccolo dizionario beauvoiriano, uno speciale su Trans/scritture (n. 132/2018) e il tema “Mixtopia” (n. 143/2020) mentre dal 2018 firma la rubrica “Giardini immaginari”.
UN FILM
Amore cannibale, capitalismo e il senso di colpa dei maschi in Bones and All di Luca Guadagnino
di Bianca Arnold
[Alt Text: un frame da Bones and all di Luca Guadagnino. Lee e Maren, i due giovani protagonisti, si stanno baciando. Fonte.]
Durante uno sleep over Maren (Taylor Russel) sta parlando intimamente con una ragazzina sotto a un tavolo di vetro. Dalle prime scene ci è dato sapere che per lei è difficile passare del tempo con delle coetanee, per cui questa scena è carica di aspettative. Mentre l’amica le parla, Maren avvicina il volto alla sua spalla, con movenze cariche di erotismo e desiderio. Maren desidera la sua amica? L’amica le porge il dito con l’unghia appena smaltata, e Maren prima lo lecca e poi… se lo mangia.
Il cannibalismo da solo ci unisce tutti. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente.
(O. De Andrade, Manifesto Antropofago, 1920, Revista de Antropofagia, Sao Paulo)
Così esordisce il Manifesto Cannibale di Oswald de Andrade, poeta di Sao Paolo che insieme ad altri come Mario de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Menotti del Picchia figura come fondatore del modernismo brasiliano. Antropofagismo come via di libertà dai colonizzatori, finalmente: divorare l'arte, la lingua e lo stile degli europei che è stata imposta in Brasile per secoli, per esprimere la propria differente identità. Ribellarsi appropriandosi della loro cultura e persino della loro religione.
La vicenda di Lee (Timothée Chalamet) e Maren è la storia d’amore di due cannibali in un road movie attraverso gli USA. Il periodo è un imprecisato tempo estetico delle case a schiera e degli autogrill, in un panorama in cui tutte le cose più strane possono accadere, proprio perché sembra essere la terra del nulla (e allo stesso tempo quella in cui ci sono le sparatorie di massa e l’aborto è illegale).
Il cannibalismo tradizionalmente si distingue in endocannibalismo, ovvero rivolto a individui all'interno della propria comunità, o esocannibalismo, al di fuori di essa. In Totem e tabù, Sigmund Freud pone come base della civiltà e distacco dalla barbarie l'atto di uccisione e divoramento del proprio padre. Freud racconta nella sua elaborazione che di conseguenza l'uomo, per la vergogna e il senso di colpa di aver divorato il proprio padre, decide di non poter possedere le donne della propria comunità, e da qui derivano l'esogamia e il tabù dell'incesto. Lee ama più di ogni altra sua sorella, che addirittura chiama "la mia donna", da cui deve allontanarsi ma a cui sempre ritorna.
È da segnalare come il cannibalismo nei secoli e nelle teorie occidentali sia sempre stato lo spartiacque, tra "noi" e "i selvaggi", oppure al contrario da Freud, tra la civiltà selvaggia e quella della ragione. Insomma, mangiare un altro essere umano ti rende o più selvaggio o più civile.
Mangiare il corpo dell'altro come atto sacro, incorporazione della vita dentro di sé, mantenimento della sua sacralità, attraverso la vita stessa, benedizione di noi stessi attraverso lo stesso atto: non è ciò che avviene nell'Ultima Cena? "Questo è il mio corpo, mangiatene tutti". Gesù compie un miracolo, o se vogliamo un atto di ontologia materialista, assegnando al pane il proprio corpo, e spezzandolo si dona ai suoi discepoli, affinchè essi lo portino dentro di sè anche dopo la sua morte, e così attraverso la Transustanziazione, e la comunione dei fedeli in tutto il mondo e nei secoli a venire.
Ma torniamo al Brasile: Francesco Remotti, antropologo di fama internazionale, nel suo celebre libro Contro l’identità parla della pratica antropofaga presso i Tupinamba, popolazione nota per il suo lungo rituale di preparazione del guerriero nemico per essere mangiato. Questi viene accolto, rivestito, cibato, gli viene pure assegnata una compagna, e per molti mesi vive nella comunità di cui è prigioniero esattamente come uno di loro. Descrivendo questa pratica, Remotti vuole mostrare la costruzione dell’alterità, e allo stesso tempo la sua assimilazione e il suo annientamento.
Questa conclusione di cannibalismo passivo (l’essere mangiati dagli altri)” afferma Remotti “a cui i veri uomini (ava-eté) tupinamba – a differenza delle donne, che muoiono nelle loro amache – infine aspirano, si realizza significativamente la condizione di pienezza, di completezza (aguyje), che coinciderebbe con l’accesso alla Terra senza Male. L’identità del “noi” da sola è “incompleta”: occorre aggiungere o raggiungere l’alterità.
(F. Remotti, Contro l’Identità, 1996, Economica Laterza, Bari)
L’esocannibalismo tupinamba è quindi da una parte sopraffazione ed eliminazione dell’altro e dall’altra parte è assimilazione e custodia dell’alterità. Tuttavia allo stesso tempo non è un’eliminazione totale dell’altro. I resti, come ad esempio le ossa, vengono utilizzati in svariati modi, tra cui la creazione di monili e flauti, in modo che la persona sia sempre in un qualche modo all’interno del ciclo della vita e in connessione con i suoi antenati. Ma che dire quando l’antropofagia diventa “bones and all”? Con tutto il resto? Lee e Maren sono disgustati quando sentono parlare con voce languida di questa pratica (anche se noi da bravi spettatori sappiamo la regola della pistola: se compare dovrà sparare). Come se nella comunità cannibale, il mangiarsi tutto sia ciò che “non è normale”, e quindi “non umano”.
Il primo bacio di Lee e Maren avviene non a caso in un mattatoio. Il loro amore cannibale sboccia in un luogo di morte e macello. E ciò che simbolizza è chiaro anche grazie alle parole di Maren: “non ci pensi che ognuna di loro ha dei figli, dei genitori, dei cugini, degli amici?”.
La questione di cosa e chi mangiamo è più che attuale. Mangiando facciamo entrare dentro di noi una parte di mondo. Questo "oggetto" che è il cibo, reso invisibile dalla nostra quotidianità con esso, è in realtà vivo e ha delle affordances che vanno al di là del nostro apporto calorico nutrendo la società e il suo modo di stare al mondo (G. Cocco, L’alimentazione di un sistema – la portata politica del cibo, 2020, Università di Bologna). Un bambino prende a morsi un bidoncino dell’immondizia: altro film tanto atteso quest’anno gira intorno alla stessa tematica, Crimes of the Future di David Cronenberg. Lì la questione viene affrontata in maniera più ontologica: siamo ancora umani quando i nostri stessi organi saranno qualcosa di non-umano e mangeremo gli scarti che la nostra umanità ha prodotto? Un cannibalismo più alla larga: per andare avanti l'umanità finirà per cibarsi dei suoi stessi prodotti sociali. Ma non lo sta già facendo?
Nancy Fraser ha pubblicato recentemente Cannibal Capitalism, un libro con un messaggio chiaro: qui non rimane più nulla. Fraser intende per Capitalismo non solo il sistema economico, ma la società tutta: un sistema che autorizza un’economia concepita ufficialmente per accumulare valore monetizzato per investitori e proprietari, mentre divora la ricchezza non economizzata di tutti gli altri.
Servendo quella ricchezza su un piatto alle classi aziendali, questa società le invita a fare un pasto delle nostre capacità creative e della terra che ci sostiene, senza alcun obbligo di ricostituire ciò che consumano o riparare ciò che danneggiano.
(N. Fraser, Cannibal Capitalism, How our system is devouring democracy, care and the planet – and what we can do about it, 2022, Verso, London – New York)
[Alt Text: disegno raffigurante un Ouroboros.]
Sulla copertina c'è l'immagine di un Ouroboros, un serpente che si ciba della sua stessa coda. Simbolo di ciclicità ed eterno movimento, è apparentemente immobile. Rappresenta il potere che si divora e si rigenera, l'eterno ritorno, la ciclicità di tutte le cose, l'immortalità. Meraviglia e orrore, Nancy Fraser lo identifica con il capitalismo, portato a divorare sé stesso e allo stesso tempo a rigenerarsi.
Fraser quindi si e ci chiede:
Possiamo immaginare un progetto emancipatorio e contro-egemonico di trasformazione eco-societaria di ampiezza e visione sufficienti per coordinare le lotte di molteplici movimenti sociali, partiti politici, sindacati e altri attori collettivi, un progetto volto a mettere a tacere il cannibale una volta per tutte?
Per trovare un'alternativa al capitalismo è necessaria una visione ampia che miri non solo ad un'alternativa economica al sistema, ma ciò che deve essere reinventato è un nuovo rapporto di produzione e anche di riproduzione sociale.
Lee e Maren sono molto carini e innamorati. Sono troppo carini, per cui ho passato gran parte del film a chiedermi perché. Voglio dire, sorge spontanea la domanda sul perchè sia necessario a questo punto fare un film che esalti l'amore romantico ed eterosessuale. Sono carini in una maniera vintage, come ero solita sognare l'amore a quindici anni.
Eppure c'è qualcosa di terribilmente vero e triste sotto questa carineria che pare vecchio stile. "non è lei che ha bisogno di lui, ma è lui che ha bisogno di lei" dice un altro cannibale incontrato durante i loro vagabondaggi. Ecco qui. La bellezza di Timothée sa essere straziante nella sua delicatezza e fragilità.
Secondo Vogue simbolo di una “nuova” mascolinità, ha in realtà qualcosa di molto antico. Non è un freak e nemmeno queer: è la sua eteromascolinità bianca straziata che non sa dove aggrapparsi che emerge dal personaggio di Lee.
Dopo aver mangiato suo padre, vorrebbe un mondo di amore, in cui non c'è violenza maschile che possa toccare sua madre e sua sorella perché "ci sarà lui a proteggerle". Ma anche la sorella viene mangiata.
Si rifugia nell'amore come se fosse l'unica cosa a redimerlo dalla catena di colpe che si trascina come un Sisifo sulla montagna. Ma è un miraggio, è l'estetica vintage di Guadagnino lo rende chiaro fin da subito.
È un immaginario che si romperà, si distruggerà ad un certo punto. L'ideale romantico della giovane coppia eterosessuale e monogamica, l'ideale del "let's be normal", troviamoci un lavoro in biblioteca e un appartamento, e chissà magari un giorno avere dei figli, non ha un buon finale. Perché finisce per divorarti, è non alla maniera rituale dei Tupinamba, in cui delle tue ossa venga fatto un flauto affinché tu possa continuare a vivere nel suono e nel respiro delle future generazioni. No, è un "bones and all", questo ideale romantico finisce per divorarti finché non resterà più niente.
Eppure è quello che Lee cerca fin dall'inizio. Vuole sparire, non vuole più portare il peso delle sue colpe, vuole essere redento e purificato. Quale miglior modo di essere divorato e inglobato dalla donna che ama.
Però, per curare la ferita, questa non può essere la strada. Ritorna ad essere un sogno orientalizzante dell'uomo bianco che si sente in colpa. Quale miglior modo di espiare che farsi mangiare dalla donna nera. Citando bell hooks:
Avere un assaggio dell’Altro, in questo caso intrattenere rapporti sessuali con donne non-bianche, era considerato un rituale di trascendenza, un movimento verso il mondo della differenza con un potenziale di cambiamento. Un accettabile rito di passaggio
(bell hooks, Eating the other: Desire and resistance. In Black Looks: Race and Representation, pp. 21–39. Boston: South End Press, 1992)
Riferendosi ai giovani studenti maschi di Yale, bell hooks delinea questa figura del ragazzo bianco progressista e di sinistra che vede nel corpo dell’altro un territorio da esplorare, una vera e propria frontiera che affermandosi come identità desideranti trasgressive può tuttavia essere terreno per la ristabilizzazione della norma maschile. Questo possiede al suo interno uno spirito di rottura con il passato coloniale e razzista, che vede l’assaggiare l’Altro come un modo per redimersi e riconciliarsi. A livello più ampio però, bell hooks ci vede un fenomeno nazionalista che vuole dimostrare come dei cambiamenti sociali stanno avvennedo per rendere di nuovo possibile l’American Dream.
E anche questo è un serpente che si mangia la coda. Troviamo un'alternativa a questo immobile movimento, a questo rituale orientalizzante che si ricrea ancora e ancora.
[Alt Text: Abaporu, dipinto di Tarsila do Amaral. Fonte.]
Per chiudere il cerchio dell’Ouroboros, ritorno un attimo al modernismo brasiliano. Il quadro più conosciuto ed economicamente rilevante all’interno del mercato dell’arte è Abaporu, che in lingua tupi significa “antropofago”, fu dipinto nel 1925 da Tarsila do Amaral che lo regalò ad Oswald de Andrare, suo marito e autore del manifesto. Rappresenta una mostruosa e solitaria figura umana, con mani e piedi giganti e una testa minuscola. Oltre a questa figura antropomorfa, senza sesso né età, nuda, ci sono un cactus e un sole.
Le traduzioni sono a cura di Bianca Arnold.
Bianca Arnold (Torino, 1997) è specializzat in queer Studies ed è un’artist visuale, dalla fotografia al video passando per la pittura. Nel 2017 ha viaggiato tra gli Stati Uniti e l’Ecuador, partecipando come volontario al Chelsea Film Festival a New York City, e vivendo presso la comunità indigena Kitchwa di Salasaka, sulle Ande. Ha studiato Antropologia, Religioni e Civiltà Orientali presso l’Università di Bologna. Nel 2020 si è iscritt al Centro Studi sull’Etnodramma, Scuola di Cinema Documentario Etnografico, presso Padova. Con i suoi lavori ha partecipato al Festival di Fotografia Europea a Reggio Emilia, al Festival di Fotografia di Ferrara e nel 2021 ha realizzato la sua prima mostra personale presso Green Whale Space a Bologna. Attualmente sta conseguendo una laurea magistrale in "Woman’s and Gender Studies", doppio titolo tra l’Università di Granada e l’Università di Bologna. Con i suoi lavori ha esposto a Londra, Budapest, Torino, Bologna, Reggio Emilia e Ferrara. Ha pubblicato Pangea, raccolta di racconti.
Ringraziamo Giusi e minimum fax per averci concesso la pubblicazione di alcune pagine del libro di Giusi, e Giuliana e Bianca per aver contribuito a questo numero. Non vediamo l’ora di farti leggere il prossimo!
Un abbraccio!
Francesca, Gloria e Marzia