Benvenut@ a Ghinea, la newsletter che dona e invita chiunque ne abbia la possibilità a donare un aiuto alle persone che si trovano in questo momento intrappolate a Gaza, in assenza di luoghi deputati a proteggerle e per questo perennemente esposte ai bombardamenti, nella complice paralisi di una comunità internazionale che non merita di essere chiamata tale.
Questo mese leggiamo con Martina Neglia Il libro della scomparsa, guardiamo con Sara Giudice la serie Baby Reindeer, e riflettiamo con Chiara Bonsignore sulla scomoda eredità culturale del nostro canone letterario. Buona lettura!
Baby Reindeer o l’onere di essere a disagio
di Sara Giudice
[Alt Text: immagine da Baby Reindeer. Martha è seduta a una fermata dell’autobus e appare triste e amareggiata.]
C’è una grande differenza fra raccontare una storia e venderne una.
Nel caso di Baby Reindeer, Netflix ha voluto dapprima vendere la storia di Richard Gadd come un thriller basato su una storia vera, in cui un giovane uomo diventa vittima di una stalker. Ma sono bastate una manciata di settimane, dentro e fuori da Internet, perché il pubblico si rendesse conto che non era quello il vero punto della storia. Cioè, che il cuore di Baby Reindeer non andava cercato nell’episodio pilota, bensì nel quarto.
Baby Reindeer racconta la storia di Donny Dunn, stand-up comedian che cerca di emergere nella scena londinese. Tutto viene messo in discussione quando Martha Scott, cliente del pub in cui Donny lavora, entra nella sua vita e comincia a perseguitarlo—al lavoro, via mail, online, durante i suoi spettacoli e poi anche a casa. Nel tentativo di mantenere un certo controllo sulla propria vita, quindi, Donny cerca di dividerla in compartimenti stagni. In uno di questi, coltiva la sua relazione con Teri, psicologa trans di cui è profondamente innamorato.
Un elemento emerge subito: Donny non riesce a essere sé stesso. Si nasconde sia sul palco che fuori, e presto si rende conto che non è così diverso da Martha.
Nel famoso quarto episodio, scopriamo che il motivo per cui Donny fa così fatica a fidarsi degli altri – e di sé stesso – è che, durante uno dei momenti più vulnerabili della sua carriera, è stato abusato ripetutamente da un uomo di cui si fidava. Una figura guida che lo riempiva di complimenti, gli dava attenzioni, gli mostrava come avrebbe potuto migliorare la sua vita se lui fosse rimasto sotto la sua ala. Da qui in poi, il pubblico può mettere insieme i pezzi della sua personalità e riceve chiarimenti sulle sue scelte spesso incomprensibili. È chiaro che Donny fa così tanta fatica a entrare in intimità con le donne della sua vita – che queste siano cis o transgender – perché è un ragazzo profondamente traumatizzato e sofferente, ma anche perché (di conseguenza) non riesce a lasciar andare Martha. Più la polizia, Teri e i suoi genitori gli chiedono di dimenticarla, più Donny è affascinato dalla sua stalker e vuole capirla fino in fondo. Nel frattempo, va tutto a rotoli.
[Alt Text: immagine da Baby Reindeer. Si tratta della schermata di Facebook di Donny nel momento in cui, dopo aver svolto alcune ricerche su internet riguardanti Martha, decide comunque di accettare la sua richiesta di amicizia.]
La verità è che Donny empatizza con Martha perché conoscere lei è conoscere sé stesso. Nella scena finale, infatti, Donny ordina un drink in un bar per poi rendersi conto di non avere soldi per pagare. Il drink, quindi, gli viene offerto dal barman. Dopo sette episodi stremanti, lo spettatore deve accettare che le posizioni di Donny (il perseguitato) e Martha (la perseguitatrice) sono puramente casuali. Entrambi vittime, emotivamente provati e socialmente poco capaci, fanno un viaggio uguale e contrario e Donny non diventa un perseguitatore (o predatore) solamente perché è in grado di mettersi a nudo di fronte a una platea intera.
All’inizio, Donny si nasconde dietro la sua amata anti-comedy, il suo finto profilo da catfish sui siti di incontri e il bancone del pub dove lavora perché non ha il coraggio di essere “solo Donny”, il ragazzo vulnerabile che ha assunto il GHB offerto dal suo stupratore. Donny non è, infatti, la vittima perfetta che il pubblico spesso brama: non denuncia mai il suo stupratore e rimanda a oltranza la denuncia di stalking (che pure ha tutti gli elementi per supportare) e, quando va dalla polizia la prima volta, non riesce a portarla a compimento. Ma, come si accennava prima, il tema attorno al quale si svolge la storia non è tanto lo stalking quanto l’abuso sessuale e le sue conseguenze. Il filtro è maschile. Per questo, la narrazione è ricca di momenti autoriflessivi in cui Donny parla di sé come un uomo indecifrabile, se non a tratti stupido nelle decisioni che (non) prende, soprattutto durante il quarto episodio.
Nel raccontare questo, da parte di Gadd, c’è molta onestà. Donny è impulsivo, certe volte sciocco, ma lo spettatore non è mai portato a giudicarlo. Una volta superato l’episodio quattro, la frustrazione rimane nello sguardo di chi non è mai passato per il labirinto dell’abuso. E Gadd, invece, lo conosce bene.
La serie chiarisce subito che la storia di Donny è basata su una storia vera: è sia una maniera per chiarire i confini della ricezione, sia una strategia narrativa. Nel primo caso, la serie funziona nel mercato dominato dalle IP (Intellectual properties) perché, come i remake, gli adattamenti e le riedizioni, rassicura il fatto che si stia facendo riferimento a un corpus narrativo già esistente: la vita di Gadd. Nel secondo caso, dice allo spettatore che c’è molto di più rispetto a quello che viene mostrato nei confini dello schermo. Confini entro i quali è stato difficile tenere a bada i fan, che si sono scatenati alla ricerca della “vera Martha” e il “vero Darrien”. E un’altra questione divisiva per la fandom riguarda i corpi femminili nella serie.
Sia Teri (una donna trans) che Martha (una donna grassa) sono punti di raccordo per quelle che vengono chiamate “rappresentazione trans” e “rappresentazione del corpo grasso”. Per analizzare i due personaggi in quest’ottica, si afferma subito che Martha è l’unica che può essere percepita come stereotipata: non è attraente né affascinante, e vive in un ambiente sporco e respingente. Teri, al contrario, è una donna di successo, con una vita completa e soddisfacente. Sappiamo della sua identità di genere solo perché Donny racconta di essersi messo alla ricerca di una ragazza trans online, e non per altri motivi. La sua storia è influenzata dalla sua identità di genere, perché è parte di lei, ma non ruota mai necessariamente intorno a quello. È molto di più.
Al contempo, il punto di vista interno (e insindacabile) del protagonista è il motivo per cui Martha passa dall’essere un corpo quantitativamente stereotipato a uno qualitativamente libero. Cioè, Martha si inserisce in una pletora di personaggi grassi usati come sfogo comico o come ricevitore di umiliazioni e insulti a favore del protagonista con un corpo più conforme, ma non lo è in sé. Lo spazio dello schermo abitato da Martha è profondamente legato al suo passato traumatico: la perdita del lavoro, il carcere, il fatto che non ha gli strumenti (e il sostegno esterno) per emanciparsi dal suo stato di indigenza. Eppure, il protagonista che empatizza non si esonera dal dire le cose come stanno: Martha, seppure vittimizzata in passato e abitante di un corpo non conforme, rimane un’adulta responsabile delle proprie azioni criminose. È una donna abbandonata, ma anche crudele. La sua forma umana mette a disagio lo spettatore? Sì. Ma se è vero che l’audiovisivo ha bisogno di una rappresentazione più onesta dei corpi grassi, è anche vero che non è questo il tipo di produzione disposta a farlo. L’obiettivo di Baby Reindeer è raccontare una storia vera dal punto di vista del protagonista, e questo detta la struttura e il ritmo della storia.
In conclusione, è difficile dare un giudizio su Baby Reindeer. È anche difficile dire come un corpo sia stato costruito in maniera “corretta” sullo schermo se, alla fine, lo scopo ultimo della serie era quella di raccontare una storia profondamente personale. Si può però lodare Netflix per aver portato al pubblico internazionale una storia con un taglio originale sul tema dell’abuso sessuale sugli uomini, che raramente trattiamo con onestà, dentro e fuori dallo schermo.
Sara Giudice (they/them) è Narrative Change Fellow presso la Coalizione Italiana Libertà e Diritti. Si occupa di audiovisivo, disabilità e neurodivergenza. Come scrittore, scrive di persone strane che fanno e vogliono cose straordinarie.
Il canone come specchio, ovvero: leggere il patriarcato per liberarcene
di Chiara Bonsignore
[Alt Text: The Rape of the Sabine Women (“Il ratto delle donne sabine”) dipinto di Alfred Basel, 1919. Il dipinto raffigura un gruppo di uomini in movimento, ognuno dei quali tiene in braccio e trasporta una donna. Le posizioni caotiche delle donne suggeriscono che stiano cercando di divincolarsi. Il paesaggio è un crinale erboso esposto a un dirupo, contro un cielo grigio informe. Fonte.]
Questa storia un po’ la conosciamo.
Siamo nell’VIII sec. a.C. circa, dentro l’evanescente paesaggio mitico delle origini di Roma. La città che crescerà fino a estendere il suo dominio su tre continenti è stata fondata sul sangue, ma dopo quell’inizio cruento Romolo, il primo re, si comporta – agli occhi di Tito Livio, lo storico che ci racconta tutto questo – quasi come un santo, e sotto la sua guida la nuova città cresce. I Romani, però, sono tutti uomini; la miracolosa grandezza cui sta assurgendo la città non vale nulla, perché si estinguerà nel giro di una generazione. Romolo manda quindi ambascerie ai popoli confinanti per chiedere di poter stringere dei patti matrimoniali con loro, e tutti gli ridono in faccia: il suo è un popolo nuovo, fatto di fuggiaschi e briganti, e nessun padre che si rispetti gli darà mai le proprie figlie. È qui che i Romani decidono di prendersi con la forza ciò che non gli è stato dato con la diplomazia, e Tito Livio ci tiene a dirci che Romolo è molto amareggiato, quando si vede costretto a tendere una trappola ai popoli confinanti. Organizza appositamente dei giochi pubblici, gli stranieri vengono in massa e i Sabini, in particolare, si presentano con le mogli e le figlie. Il resto è noto: appena tutti sono distratti dai giochi, i Romani fanno scoppiare un tumulto e rapiscono tutte le Sabine. Saranno queste donne rapite, terrorizzate e indignate a generare figli per i Romani e permettere loro di far crescere la grande Roma.
Questa storia, quella del ratto delle Sabine, un po’ la conosciamo. C’è però una scena che Tito Livio narra in coda su cui non ci si sofferma mai. Romolo, che per lo storico è ancora l’eroe buono della storia, non gioisce di fronte alla violenza e vorrebbe chiaramente metterci una pezza. Va da una donna all’altra, allora, e cerca di blandirle, con parole che per Tito Livio sono evidentemente l’epitome della saggezza. Quelle parole, che Tito Livio riporta in un discorso indiretto, sono queste: “che l’atto era stato compiuto per la superbia dei padri, che avevano negato il matrimonio ai confinanti; e le donne, comunque, sarebbero state accolte dai Romani in un matrimonio legittimo, in una condivisione di tutti i beni, della patria e – cosa più cara tra tutte per gli esseri umani – dei figli. Che ora dunque frenassero la collera e concedessero il cuore a chi aveva già ottenuto in sorte il loro corpo: poiché spesso dal torto subito sorge, col tempo, l’affetto” (traduzione mia). E, sempre stando a Tito Livio, le Sabine non gli saltano al collo per sfregiarlo, ma pian piano si lasciano persuadere.
Il ratto delle Sabine è di certo una di quelle storie che hanno recentemente portato a mettere in discussione il canone letterario che studiamo a scuola. Nella letteratura greca, latina ed europea le narrazioni che normalizzano la violenza e l’invisibilizzazione attuate sui subalterni – donne, schiavi, persone razzializzate – sono ubique, e il curriculum scolastico sul quale ci formiamo fin da bambini si regge su queste narrazioni. Problematizzare questa realtà non è solo legittimo, è necessario. Detto ciò, resta la domanda: che fare?
Una proposta frequente è quella di spostare il focus del nostro sguardo: ampliare il canone, includendo opere scritte da soggetti subalterni, oppure sostituire alcune storie con altre. Un articolo recente del Post, ad esempio, suggerisce tra le altre cose di smettere di proporre in classe la novella di Boccaccio su Nastagio degli Onesti, che presenta come giusta la morte violenta di una donna colpevole di aver rifiutato un innamorato, e di sostituirla con altre novelle sempre di Boccaccio, che – pur appartenendo sempre al canone – celebrano l’arguzia delle donne. Sono tutte proposte a loro modo valide, e, checché ne dica chi grida alla cancel culture (un esempio qui, ma il Foglio ha un intero tag su questo concetto, fumoso quanto l’altrettanto fantasmagorica teoria gender), sono tutte animate da spirito costruttivo, non distruttivo.
Tuttavia, penso che tenere lo sguardo ben fisso sulle storie più violente del nostro canone abbia una sua utilità; continuare a insegnare il mito di Pandora che diviene la donna responsabile di tutti i mali del mondo, Atena che dichiara in un tribunale che le madri non contano e contano solo i padri, le Sabine che devono pure ringraziare per essere state rapite è necessario. E il ratto delle Sabine è l’episodio giusto per spiegare perché.
Le parole che Romolo pronuncia alla fine della storia sono agghiaccianti. Potremmo dirci che sono figlie del loro tempo, che non meritano d’essere rilette oggi, e sostituire questa storia con un’altra durante le ore di storia antica o latino. Il punto, però, è che queste parole non le ha pronunciate solo un personaggio mitico del passato di Roma. Le hanno pronunciate per due millenni e mezzo tutti gli uomini che, in diversi momenti della storia europea, hanno proposto alle donne un matrimonio riparatore. Non è un caso: il diritto europeo è un’emanazione del diritto romano. Per quanto l’antica civiltà romana ci sembri cosa remota, la sua interpretazione del mondo ha concretamente plasmato l’interpretazione del mondo di tutta l’Europa. Anche le storie, i miti, gli archetipi ci influenzano, ma ci sarà sempre chi sarà pronto a dire che le storie sono solo storie, la vita vera invece è un’altra cosa.
Ecco, qui non ci muoviamo nel mondo astratto delle storie: il pensiero che soggiace alle parole di Romolo è l’esatta logica che ha influenzato il pensiero legale di buona parte dell’Occidente. Intendiamoci: il matrimonio riparatore non lo inventarono i Romani, se è vero che era già previsto nell’Antico Testamento. E, in un mondo radicalmente patriarcale - nel quale l’unico destino desiderabile per una donna era il matrimonio, e una donna stuprata era per giunta considerata indegna d’essere sposata - gli uomini che legiferavano possono aver visto davvero, in un principio del genere, una tutela per la donna. Le parole di Romolo lasciano intravedere però un meccanismo ulteriore: il fatto che, a volte, il mondo patriarcale non si accontenti di imporre alle donne la sua logica brutale per quello che è, ma chieda loro di partecipare docilmente alla propria deumanizzazione; perché, in fondo, è sempre più comodo che le vittime non recalcitrino. La docilità delle Sabine nella storia, allora, diventa ulteriormente rivelatrice delle necessità di chi racconta, non di chi è raccontato; la necessità, in questo caso, di dirsi che la violenza perpetrata è stata scordata. E, per parlare del nostro orticello, quello che le Sabine si sentirono dire da Romolo, le donne in Italia se lo sono probabilmente sentite dire, al riparo della legge, fino al 1981, quando, insieme al delitto d’onore, il matrimonio riparatore è stato finalmente espulso dal nostro codice penale.
Io capisco chi propone di non far più leggere una storia come il ratto delle Sabine: è inquietante, umiliante, esasperante. Mi sembra però che non leggerla ci privi della straordinaria opportunità di vedere i primi passi di una stortura che ha legalmente influenzato le nostre vite fino a ieri e, culturalmente, fino a oggi. Perché farlo? Perché vederne i primi passi ci dimostra che quella stortura non è una verità immanente, cui l’essere umano è sottomesso in modo ineludibile. Ci dà, invece, l’occasione di studiarla come la costruzione artificiale che è, dissezionarla, guardarla in faccia, e infine domarla. Certo, questo significa dirci ad alta voce che questi testi devono essere problematizzati, non studiati acriticamente; un approccio critico che nelle scuole pian piano sta entrando, ma che dev’essere senz’altro potenziato. Solo con una decostruzione critica tale, ad ogni modo, possiamo ambire a plasmare una società consapevolmente libera da sovrastrutture patriarcali. L’altra via – quella di evitare questa e altre storie – ci libera dal disagio di affrontarle, ma non ci libera dall’influenza che esse esercitano su di noi; anzi, ci rende più vulnerabili, perché più inconsapevoli. Possiamo ignorare la donna pazza chiusa in soffitta quanto vogliamo, ma lei darà fuoco alla nostra casa lo stesso.
Quando ci si interroga sul senso dello studio dei classici, spesso una risposta è che i classici ci hanno resi chi siamo. Lo credo profondamente, e penso che nell’eredità dei classici ci sia meravigliosa, dolorosa bellezza. Non c’è solo quella, però. I classici ci hanno resi quello che siamo, nel bene e nel male. Sono le nostre radici di bellezza ma anche di violenza, sono il nostro specchio e il riflesso non è sempre lusinghiero. Però, se davvero vogliamo emanciparci, da qui non si scappa: in quello specchio, volenti o nolenti, dobbiamo guardarci.
Chiara Bonsignore è nata a Cagliari, è diventata sé stessa a Roma e ora vive a Milano, dove si nutre di storie e fa la prof. Ogni tanto parla di gioie e dolori del canone greco e latino qui.
Un estratto da Le postromantiche di Carolina Bandinelli.
Una recente conferenza di Judith Butler in Italia.
Una lunga intervista alla scrittrice colombiana Maria Ospina.
Le vite di sei donne gazawe dopo il 7 ottobre.
Cristina Rivera Garza ha vinto il premio Pulitzer per L’invincibile estate di Liliana. Ne parlavamo qualche numero fa:
L'invincibile estate di Liliana comincia dove altri resoconti sarebbero terminati. In una calda giornata del 2019 Cristina Rivera Garza ha tentato di recuperare il fascicolo delle indagini sull'omicidio di sua sorella, presentandosi in diversi uffici che non erano mai l'ufficio competente prima di scoprire che il fascicolo, così vecchio da non essere stato digitalizzato, era praticamente irrintracciabile. Il gorgo che ha risucchiato le circostanze della morte di Liliana dice, con intenzione, del lungo disinteresse rispetto alle sempre allarmanti statistiche riguardanti la violenza di genere nel paese, e non c'è lieto fine possibile. Questa non è la storia edificante di una sorella ostinata che chiede e ottiene giustizia, e non si conclude con il colpevole che viene infine rintracciato e sottoposto a giusto processo. Certi ostacoli sono semplicemente insormontabili e alcuni danni sono irreparabili: non c'è modo di rimediare al fatto che questa giovane donna sia morta e che il suo assassino non ne pagherà mai le conseguenze.
Di fronte alla certezza che la storia di Liliana Rivera Garza non terminerà come quella di Lesvy Berlín, lo spazio di azione e di speranza si riduce molto. Ma non scompare. L'unica giustizia possibile per Liliana non risiede in un qualche tribunale, bensì nello sforzo di scrittura che si oppone alla cancellazione di una vita, risale la corrente e corre in direzione opposta a quella del tempo. L'invincibile estate di Liliana non è una seduta spiritica: non è un fantasma a essere rievocato, ma una ragazza viva e tutti i suoi sogni.
Qui invece la lettura di Ludovica Ciasullo.
[Alt Text: fotografia di Cristina Rivera Garza, ritratta all’aperto e in primo piano. I lunghi capelli grigi sono raccolti in una coda di cavallo bassa, e la scrittrice porta gli occhiali da vista e un rossetto rosso.]
Su Altreconomia puoi leggere un’intervista alla ricercatrice Mjriam Abu Samra, che si occupa di studiare i movimenti studenteschi che lottano per la liberazione della Palestina. Nel frattempo, anche in Italia ha preso piede la forma di protesta delle acampadas: studenti universitari che piantano le tende di fronte agli atenei e lì restano, organizzando laboratori, discussioni e interrompendo occasionalmente momenti della vita accademica per contestare i rapporti di collaborazione con le università israeliane e alcune industrie italiane, come Leonardo, che producono armamenti e tecnologie di impiego bellico.
Su Internazionale puoi vedere un breve videoreportage sulle terribili condizioni delle lavoratrici nordcoreane che lavorano per l’azienda ittica cinese (che esporta anche in Europa) Donggang Jinhui Foodstuff: confisca dei documenti, abusi sessuali, turni estenuanti e percosse. Sul sito di The Outlaw Ocean Project, l’organizzazione che si è occupata della realizzazione del reportage, è presente un articolo di approfondimento.
Rhythms of Liberation: l’emancipazione femminile nera dal gospel alla trap.
Una storia di due mogli (e quattro mariti?): la cronaca di due donne eccezionali della Roma imperiale.
Nicoletta Vallorani ha scritto uno splendido ricordo di Alice Munro, scomparsa lo scorso 13 maggio:
Le storie di Munro – ormai pubblicate con regolarità su The New Yorker, The Atlantic Monthly e The Paris Review – prendono sempre di più la forma non di un viaggio ma di un puzzle, in cui il progresso non è mai lineare, ma un garbuglio in cui alla fine tutti i pezzi vanno al loro posto. La definitiva adesione alla forma del racconto non determina una diminuzione della complessità, ma semmai un incremento della passione costruttiva, mentre i temi restano potentemente agganciati alle esperienze invisibili ma epifaniche di una provincia che vive di formalismi e tradizione. In essa compaiono con sempre maggiore evidenza colpe innominabili e pulsioni sempre negate, quanto meno alle donne. Ha ragione Atwood quando dice che pochi hanno saputo raccontare l’amore nei termini dell’attrazione fisica e della sessualità femminile, con tutte le bugie e gli imbrogli connessi alla necessità maschile tanto quanto femminile di adempiere il desiderio. Non è un percorso lineare, quello di Munro, anche perché implica la necessità di venire a patti col suo passato familiare e con la legacy per metà scozzese e presbiteriana del padre e per l’altra metà, quella materna, irlandese e anglicana. In entrambe le tradizioni, i doveri della donna non includono la possibilità di soddisfare il proprio desiderio, soprattutto se di desiderio sessuale si tratta. Religione e senso di colpa restano potentemente agganciati, e tuttavia Munro è capace di una consapevolezza salvifica, che comprende anche una valutazione contradditoria delle potenzialità del perdono.
FATTO DA NOI
Ragazzə Laser di Marzia ha vinto il premio Pagliarani e sarà presto pubblicato. Puoi leggerne due estratti qui.
FATTO DA VOI
Marta Corato ha scritto delle Vergini Suicide di Sofia Coppola.
[Alt Text: frame da Il giardino delle vergini suicide. Quattro delle cinque sorelle Lisbon si trovano in casa, sul letto di una camera dai colori pastello, e sono concentrate a guardare la cornetta del telefono che una di loro tiene in mano.]
Cristina Resa ha visto Furiosa: A Mad Max Saga.
Tre domande a Marta Lamalfa, poste da Alessia Ragno.
Antonia Caruso sullo stato di polizia interiore della comunità trans.
Il nuovo podcast delle Missconosciute parla di Goliarda Sapienza!
Un appello alle persone trans-enby da parte del nostro amico e ricercatore Fau Rosati:
Sono una persona trans nonbinaria e faccio ricerca nell'ambito della salute mentale. In Italia ci sono pochi o nessun dato su di noi: con questo studio vorrei provare a dimostrare l'impatto che le microaggressioni ma anche le microaffermazioni possono avere sulle nostre vite. Tengo molto a questa ricerca e sono grato a chi ci dedicherà del tempo. Se puoi, partecipa e/o condividi il questionario con persone che potrebbero partecipare.
👉 Alcune info utili da sapere: La compilazione dura circa 20-30 minuti e vengono poste sia domande a scelta sia domande a risposte aperte. Alcune parti del questionario possono essere impegnative, ti consiglio di dedicarti un tempo di cura dopo averlo fatto. Se hai bisogno di supporto e di chiarimenti sullo studio sono a disposizione: fau.rosati@gmail.com
Per partecipare puoi accedere qui.
Silvia Di Gregorio, ideatrice della serie LOVE CLUB, ci segnala Fai bei sogni, una sua performance politica che combina arte e moda: durante il red carpet dei Diversity Awards, Silvia ha indossato un abito sul quale tredici artistə e illustratrici hanno rappresentato collettivamente il dolore su ciò che sta accadendo in Palestina, in Ungheria, in Iran ma anche nel nostro paese. L’opera sarà messa in vendita e l’intero valore sarà devoluto all’associazione UNRWA.
[Alt Text: ritratto da photoshoot di Silvia Di Gregorio che indossa un abito banco con alcune frasi e illustrazioni. Tra queste spicca, in rosso e all’altezza del torace “nolite te bastardes carborundorum” (non lasciare che i bastardi ti schiaccino), espressione resa celebre dal romanzo distopico di Margaret Atwood Il racconto dell’ancella e rapidamente diventata slogan in favore dei diritti riproduttivi. Tutti i crediti qui.]
UN LIBRO
Il libro della scomparsa di Ibtisam Azem (Hopefulmonster)
di Martina Neglia
[Alt Text: la copertina in bianco e nero de Il libro della scomparsa raffigura una giovane donna con lunghi e scuri capelli ricci e, dietro di lei, alcuni alberi spogli.]
C’è qualcosa di straniante nel parlare di un romanzo che immagina la scomparsa improvvisa della popolazione palestinese su territorio israeliano, mentre da mesi assistiamo al genocidio che Israele sta compiendo nei territori della Striscia di Gaza, ma ci proverò. Ibtisam Azem è una scrittrice e giornalista palestinese, nata e cresciuta a Taybeh, a nord di Giaffa, ora corrispondente a New York. Il libro della scomparsa è il suo secondo romanzo, e il primo pubblicato in Italia da hopefulmonster nella traduzione di Barbara Teresi. Pubblicato nel 2021, è stato recentemente riscoperto grazie alle persone che lo hanno consigliato, sulla scia degli eventi recenti, insieme a tanti altri testi utili ad approfondire l’esperienza e la cultura del popolo palestinese.
Il libro della scomparsa gira intorno a un evento spiazzante: improvvisamente tutti i palestinesi nei territori dello stato di Israele scompaiono. Non si sa perché, né per mano di chi, semplicemente non ci sono più. Gli amici non rispondono, i dipendenti non si presentano al lavoro, le case restano vuote. Il racconto delle reazioni di chi resta passa attraverso l’esperienza di Ariel, giovane giornalista israeliano, che si accorge dell’assenza dell’amico e vicino di casa Alaa e decide di indagare entrando nell’appartamento di cui possedeva una copia delle chiavi. All’interno dell’abitazione dell’amico scomparso, Ariel trova un diario, e nella ricerca di informazioni inizia a leggerlo. La narrazione del romanzo alterna quindi principalmente questi due racconti: il primo in terza persona di Ariel, il secondo in prima persona di Alaa nel suo dialogo intimo con la nonna da poco mancata.
In un’intervista, Ibtisam Azem ha dichiarato che l’intento del proprio romanzo era quello di affrontare il colonizzatore con uno specchio, ma in maniera più importante quello di esplorare con sarcasmo le pratiche del colonizzatore di fronte a un evento del genere. Chiedersi quindi: come reagisce uno/a Stato/Nazione che ha fondato la propria identità sull’esistenza di un “nemico” una volta che quel “nemico” scompare?
Come scrive Ariel M. Sheetrit in un articolo su Middle Eastern Literatures, infatti, Il libro della scomparsa è uno dei pochi libri scritti da autor* palestinesi che mette al centro della narrazione il punto di vista di una persona israeliana. Anche il dialogo di Alaa con la nonna arriva in qualche modo attraverso la mediazione di Ariel, che entra nell’appartamento dell’amico con buone intenzioni per poi prendersi inesorabilmente il suo spazio lì dentro e appropriarsi di un oggetto così privato come un diario.
Viviamo le reazioni della popolazione israeliana proprio attraverso ciò che vede Ariel, chiamato anche a scriverne in alcuni articoli che arricchiscono la narrazione. E la reazione descritta è quella di una popolazione spiazzata, impaurita. Terrorizzata da ciò che potrebbe essere dietro una così sistematica e assoluta assenza. Vivono quindi giorni di attesa e impotenza, incapaci di prevedere una mossa. Come sottolinea ancora Sheetrit, si ritrovano in quello che è anche una sorta di rovesciamento di un’esperienza tipica della popolazione palestinese: l’attesa infinita ai checkpoint, l’attesa di un ritorno dall’esilio, l’attesa in ultimo di una definitiva giustizia.
Quando andavamo in gita scolastica in Galilea o in qualsiasi altro posto, io mi domandavo: dovrei muovermi in punta di piedi? Sto camminando sui cadaveri di chi è passato da qui, di chi ha perso la vita nella Nakba, il grande esodo, il disastro? Sto calpestando un terreno fatto di salme decomposte? Mi sembra di camminare sui cadaveri quando cammino in Palestina. Ho sempre in mente quell’immagine, una moltitudine di esseri umani che fuggono terrorizzati. Sono rimasto senza nonni, a parte te. Sarà che respiriamo i corpi decomposti? Cosa ce ne facciamo, di tutta questa tristezza? Come faremo a ricominciare da capo? Cosa facciamo con la Palestina? Sono stanco, anch’io sono stanco… Ma quando mi sveglio, al mattino, penso a te e sorrid+o. E dico: «Dio ce la manderà buona», come dicevi sempre tu. E ascolto la canzone di Fayrouz, Sì, c’è speranza, perché la sua voce traduce, anche se liberamente, quel che dicevi tu. Credo che intendessi proprio questo con «Dio ce la manderà buona». Ma davvero c’è speranza?
L’unica voce dei palestinesi che invece leggiamo è, come detto, quella di Alaa che immagina tra le pagine del proprio diario un emozionante dialogo con la nonna, ed proprio qui che si dispiegano le radici di quanto accaduto. La scomparsa de* palestinesi non ha una spiegazione né una soluzione. Sono davvero tutt* scompars*, ma quello che spiazza come avvenimento improvviso è in qualche modo l’espressione massima e finale di un processo iniziato ben prima e coscientemente portato avanti fino alle estreme conseguenze. Il ricordo di Alaa della nonna è la ricostruzione di uno scambio tra generazioni, tra palestinesi prima e dopo la Nakba (letteralmente “disastro”) del 1948. C’è in queste pagine la volontà di raccontarsi e tramandarsi nella propria identità, dal tratteggiare nei ricordi i dettagli di una città come Giaffa ormai drasticamente cambiata, al tentativo doloroso di tenere saldi i legami familiari di fronte ad alberi genealogici dai mille rami recisi dai lutti e dalle separazioni forzate.
Ciò che traspare dalle pagine di Alaa è un’identità palestinese profondamente intrecciata alla perdita e al dolore e al non sentirsi mai completi cittadini di una nazione che si abita senza essere del tutto riconosciut*. Alaa confida al proprio diario infatti anche gli eventi più recenti, l’amicizia con Ariel, il loro rapporto di amicizia segnato anche da incomprensioni e divergenze insanabili. La scrittura del diario in questo caso diventa non solo uno strumento di trasmissione memoriale, ma anche una via per esplorare le proprie emozioni in maniera non condizionata dall’esterno, non sottoposta a giudizio. Scrivendo Alaa prende potere sulla propria storia e sui propri pensieri senza che nessun* possa silenziarli.
All’interno del romanzo sono poi presenti dei brevi racconti narrati dalla prospettiva di comuni cittadini israeliani che affrontano la scomparsa de* palestinesi. Tra questi il più doloroso e significativo è “Un uomo e un ricordo” dove Dayan, un anziano israeliano, ricorda il momento in cui nel 1948 partecipò a uno stupro di gruppo su una donna palestinese. La sua persona si racconta come profondamente segnata dal senso di colpa, da ciò che avrebbe potuto fare per sottrarla a quella violenza. Eppure in maniera sottile la rende in parte responsabile: “Lei non aveva gridato. Perché non aveva gridato?”. E anche adesso che vorrebbe finalmente chiederle scusa dopo tanto tempo, lei non c’è più.
Azem scrive quindi un romanzo che non è importante solo come rappresentativo del vissuto presente e passato del popolo palestinese, ma perché muovendosi tra i punti di vista e le focalizzazioni, che si scambiano e mediano fra loro, si interroga sulle voci legittimate a raccontarsi e raccontare, sulle voci che possono dominare un racconto, rispetto ad altre all’opposto sistematicamente messe all’angolo, cancellate, dimenticate.
Ma è anche un libro che in seno alla tragedia conserva un nocciolo di amore e speranza per il proprio popolo. Dice Azem durante una recente intervista: “Non so se vedrò il giorno in cui saremo liberi. Ma so che quel giorno arriverà.”
Ho portato con me una bottiglia di ‘araq di produzione locale. Dà alla testa. Non prendertela se bevo ‘araq in casa tua. Sto ascoltando Umm Kulthum, quella canzone che ti piaceva tanto. Ti ricordi? Lontano da te. La ascolto e mi manchi, e nella nostalgia c’è amore. Brindo a te, nonna, e alla Palestina. Ah, quant’è bella la Palestina.
Martina Neglia è nata a Palermo nel 1993, ma vive a Milano ormai da qualche anno. Fa parte della redazione di menelique e del più giovane lay0ut magazine, per cui cura il gruppo di lettura “I terrestri”. Si interessa soprattutto di femminismi e di letteratura delle donne. La sua vita è un pendolo che oscilla tra una partita dell’Inter e l’altra.
Grazie a Sara, Chiara e Martina per i loro pezzi e il loro lavoro. Ci leggiamo tra un mese.
Un abbraccio!
Francesca, Gloria e Marzia



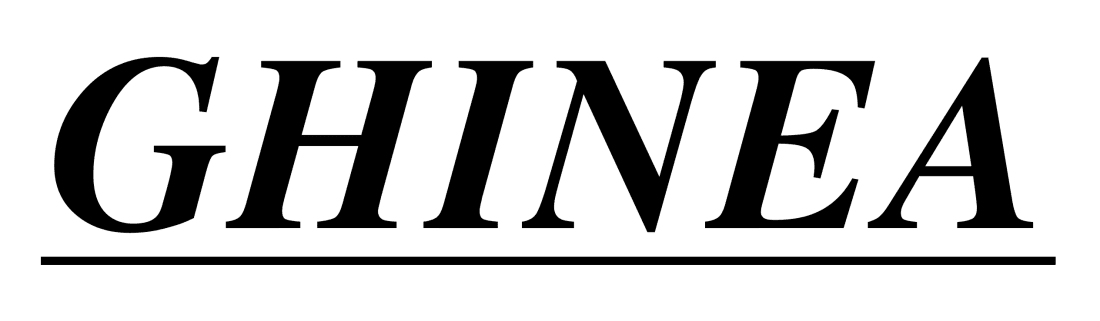







Numero stupendo 🩷🍉