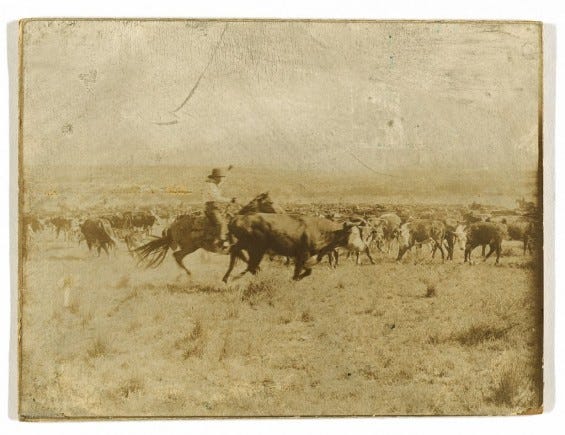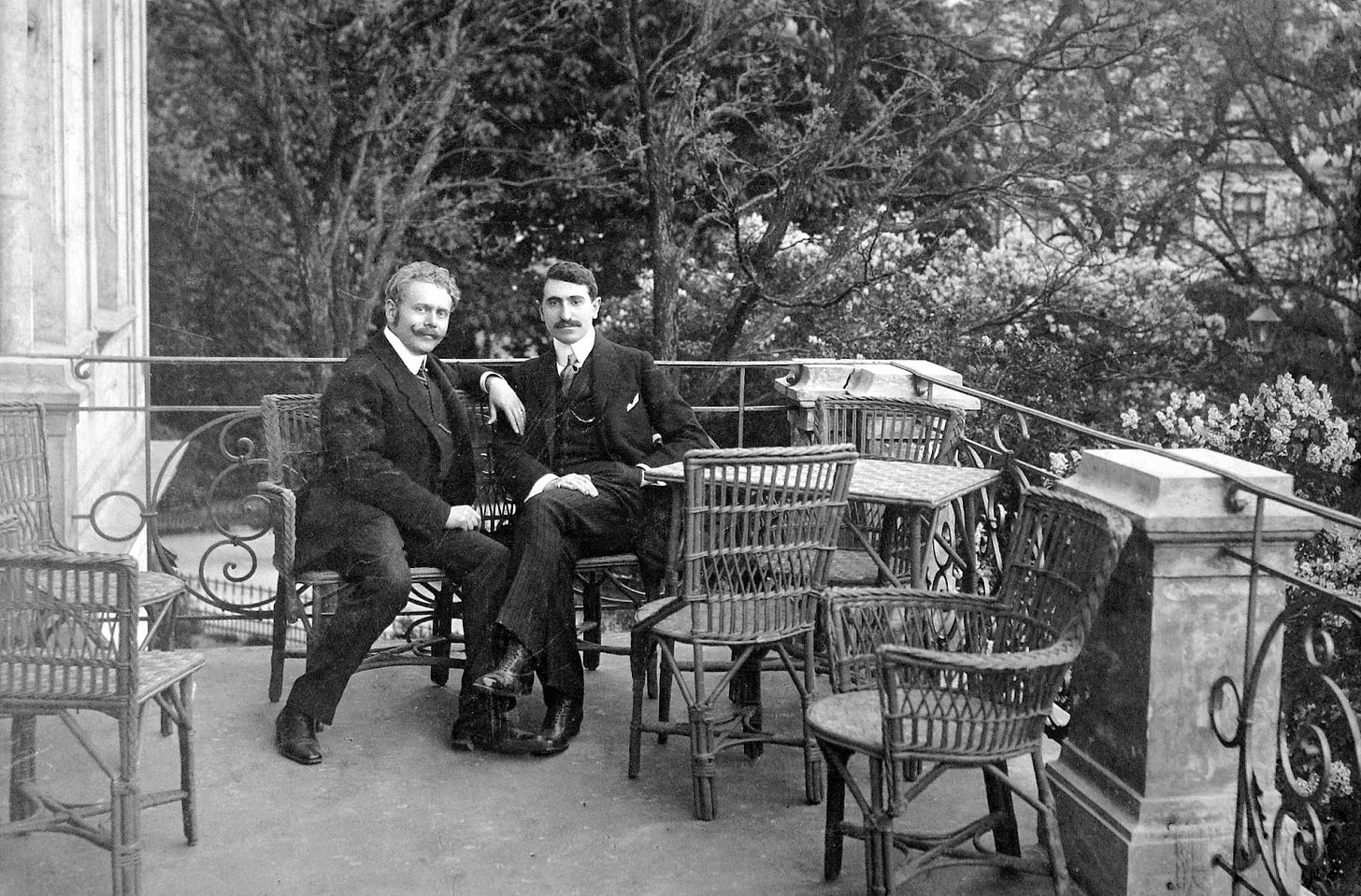Bentornatə, il nostro tredicesimo speciale a sorpresa è una conversazione tra Gloria e Francesca sul saggio I miei tre papà. Come liberarsi dai fantasmi del patriarcato, scritto da Jessa Crispin, pubblicato da SUR nella traduzione di Giuliana Lupi.
[Alt Text: il celeberrimo dipinto American Gothic di Grant Wood (1930), un cui dettaglio è stato scelto per illustrare la copertina italiana di I miei tre papà. Fonte.]
F: Mi ha un po’ fatto ridere la scena in cui Jessa Crispin si presenta a colloquio con gli editor newyorchesi per pitchare un potenziale libro true crime basato sui suoi ricordi di infanzia e la sua prossimità con un vero assassino (il suo insegnante di educazione artistica delle scuole medie). Ho sghignazzato perché in passato avevo ascoltato Crispin demolire il concetto di “true crime” come una morbosa e deplorevole ossessione statunitense per il corpo martoriato della “vittima ideale”: la giovane donna bianca senza macchia ingiustamente bersagliata da un killer sadico e impenitente. “Ma come Jessa, ci caschi anche tu? LOL”, ho pensato.
Adoro il piglio guastafeste di Crispin, la sua capacità/disponibilità a fare sempre il bastian contrario, trovare ogni volta il punto debole in ciò che osserva – libro, film o moda culturale – il dettaglio artificioso, stucchevole, pedante che a una prima impressione era sfuggito, e una volta indicato costringe a ridimensionare l’entusiasmo suscitato in precedenza. Mi rendo anche conto che non sarebbe possibile avanzare critiche puntuali (alle volte acuminate) del calibro di Crispin senza seguire con attenzione e costanza anche le peggiori banalità proposte dalle industrie culturali, rischiando pure di venirne contagiate, come forse è successo a Crispin quando ha pensato fosse una buona idea narrativizzare un trauma d’infanzia e la storia orrenda di persone che ha conosciuto davvero.
Il progetto del libro però non parte, forse perché la storia della famiglia Pianalto non si adegua a uno dei criteri fondativi del genere true crime. Per diventare intrattenimento, il killer deve essere uno sconosciuto squilibrato e crudele, non un padre di famiglia che un giorno imbraccia il fucile e apre il fuoco su sua moglie e le sue due figlie, per poi suicidarsi. La morte dei Pianalto è troppo ordinaria, è un crimine troppo autentico per poter aspirare a essere “true crime”: conferma tutte le statistiche per cui la possibilità che una persona di sesso femminile venga uccisa da un membro maschile della propria famiglia (marito, padre, fidanzato, fratello, ecc.) è talmente alta da rendere l’idea del killer sconosciuto praticamente una leggenda.
Secondo te I miei tre papà nasce dalle ceneri del memoir true crime che Jessa Crispin voleva scrivere? O pensi che fosse più interessata ad affrontare gli effetti della cultura patriarcale sulla psiche maschile?
G: Come si fa a resistere alla lusinga del denaro torrenziale che questo tipo di pubblicazione, spesso convertita in film o serie TV, ti sventola davanti? Chissà se Crispin, che nello stesso capitolo in cui racconta il progetto true crime confessa di non potersi permettere un’assicurazione medica privata che copra l’esorbitante fattura di un dentista, ha pensato soprattutto a questo, illudendosi forse di equilibrare il macabro della storia dei Pianalto con sobrie riflessioni sulla solitudine delle piccole comunità e sull’ambigua promessa della vita familiare: uno spazio simbolicamente e materialmente chiuso che protegge ma isola, una membrana che respinge la violenza che proviene dall’esterno ma all’occorrenza può trattenere e celare con efficacia quella che si consuma all’interno. In ogni modo, alla fine ha dovuto scegliere perché i due approcci non si tengono insieme, o perlomeno non sono indirizzati allo stesso tipo di pubblico ─ e quindi come si fa a venderli contemporaneamente?
[Alt Text: fotografia in bianco e nero di un gruppo di sovrintendenti e capisquadra presso il cantiere della diga di Norris, 1933. Fonte.]
Mentre leggevo il botta e risposta con l’agente ansioso di rendere il pitch di Crispin appetibile per il mercato di riferimento, non riuscivo a non pensare alla gestione mediatica dell’omicidio di Giulia Cecchettin: da una parte le signore del pomeriggio televisivo in collegamento con la troupe sul luogo del delitto, gli ospiti pronti per il dibattito in studio e le scalette serrate ma sempre pronte ad accogliere un colpo di scena, dall’altra la sorella della vittima che sin dal primo momento ha preferito concentrarsi sulla violenza di genere, quella cornice in cui ogni femminicidio si inscrive e in cui i dettagli dei vari episodi contano perché segnali d’allarme riconoscibili, e non per il loro shock value. Eppure anche questa storia è ora un libro. Gli intenti sono nobili, e non è il caso di avere la presunzione di sapere che cosa stia cercando chi lo acquista, ma il formato della lettera alla figlia e le pagine che ho sfogliato in libreria possono perlomeno confermare l’irrispettoso teorema enunciato da Crispin: maggiore la prossimità di chi scrive con chi è morto, peggiore la qualità letteraria delle memorie che ne ricaverà.
Temo di aver divagato, ma il true crime e la cronaca nera mi tormentano come mi tormentano tutti i risvolti deteriori della cultura e dell’intrattenimento, e mi pare che funzionino proprio come le mura domestiche di cui parlavo poco fa: cristallizzano nella narrazione alcuni aspetti (la perfetta felicità della famiglia nucleare in un caso, la cronistoria di un delitto e delle successive indagini nell'altro), escludendo gran parte di ciò su cui varrebbe la pena soffermarsi (l’asfissia dei legami stretti, in che modo nasce un certo tipo di crimine, come prevenirlo, a che condizioni si realizza la giustizia una volta che è avvenuto).
Per provare a risponderti, comunque, ho ripescato il tweet con cui Crispin annunciava quello che credo sia diventato I miei tre papà, e già dalle poche informazioni rivelate all'epoca si può giocare a indovinare gli aggiustamenti successivi. Il titolo è meno aggressivo ma il testo, immagino, più personale, e già dal nuovo titolo è chiara la scelta di discutere i danni che il patriarcato (ma anche le strategie con cui si cerca di combatterlo?) ha arrecato non solo agli uomini, non solo alla società, ma anche all’autrice in persona.
[Fonte]
Questo parziale cambio di fuoco mi incuriosisce, così come mi affascina la presenza costante e onestissima, nel testo, di Crispin alla stregua di personaggio che agisce sotto l’influenza di, e al contempo nel tentativo di liberarsi da, diversi e profondi condizionamenti di matrice patriarcale. Secondo te la sua strategia di rendersi quasi un self-insert funziona?
F: Funziona, certo, da una parte mi sembra una bella ammissione di umiltà — Crispin non pretende di spiegare come funziona il patriarcato, ma lo descrive radicandosi nella propria esperienza dei suoi effetti — dall’altra mi sembra un conveniente allineamento con la tendenza maggioritaria nel campo delle lettere negli ultimi anni, la prima persona singolare. Non dico “conveniente” in senso dispregiativo, come se Crispin avesse ceduto alla forma più pop per arrivare al pubblico, lo intendo come “appropriato”, “vantaggioso”. L’io è la modalità più giusta per raccontare un certo frammento del mondo come sensazione, dare priorità all’emozione piuttosto che alla ricerca. O meglio, smussare le asperità della ricerca fredda — Crispin dimostra di averne fatta parecchia — mettendo i fatti in un ordine soggettivo, che ne valorizzi l’importanza e il significato per chi scrive.
Ho una mia teoria in merito al successo e alla diffusione internazionale delle modalità narrative dell’io — memoir, non-fiction creativa e biografica, narrativa in prima persona, saggistica comparativa o compilatoria in cui le scelte autoriali sono ben evidenziate. Penso a recuperi storici come Joan Didion, Susan Sontag, Tove Ditlevsen, ma soprattutto alle contemporanee Olivia Laing, Maggie Nelson, Annie Ernaux, e innumerevoli altre. Non mi sorprende che si tratti spesso di libri molto popolari sui social media, e di primo acchito verrebbe da pensare che ne siano la naturale propagazione nella vita IRL, azionate dallo stesso presunto narcisismo sordo ed egotico che fomenta le identità digitali artificiali.
Secondo me, testi del genere sono quanto di più distante ci sia dall’onanismo e dalla gelosia su cui speculano Meta e sodali. Istintivamente, credo, ci rendiamo conto di quanto false e parziali siano le vite esposte su Instagram, e ne cerchiamo l’antidoto nelle confessioni, nelle prospettive “da dentro”, nella complessità, nell’impegno che questi altri oggetti, testi, ci richiedono. Forse l’affezione per la prima persona singolare nei libri esprime, latente, una voglia di prima persona plurale. Per me, è di sicuro una reazione contraria all’esibizione dell’io perfetto o, peggio, reso vulnerabile ad arte. C’è sempre qualcosa che stona on the grid, una spia accesa a segnalare la bugia. È raro che un testo autobiografico o di auto-fiction, per quanto cesellato e ritoccato, procuri quella stessa sensazione di presa in giro. La lettura è un’esperienza più difficile, forse meno piacevole dello scrolling, ma è tra le poche capaci di rimarginare lo strappo tra noi e gli altri, specialmente quando non funge da spiraglio per spiare, ma è invito a riconoscere una sofferenza altrui resa comprensibile sulla pagina.
È una tecnica che, se ben utilizzata, fa le veci di un posizionamento autoriale — dà informazioni su chi scrive, come scrive, da dove arriva e quale punto vuole portarsi a casa — e aiuta a stringere un’allenza con la lettrice oltre le strettoie della presentazione editoriale. La scrittura del sé è tra i pochi metodi narrativi che conservino la capacità integrata di proteggersi dalle AI e dagli assemblaggi contenutistici, assicurando, per definizione, la presenza dietro la tastiera di un vero (e singolo) essere umano. È la prova che la conoscenza passa attraverso percorsi diversi dalla mera logica o dall’intelligenza esclusivamente cognitiva, ma spesso sceglie sensi e ricordi che solo una mano umana può rendere intelligibili. Per questo credo che Crispin sia stata sia saggia sia astuta a inserirsi nel testo, usare se stessa come leva per riflettere su altro.
[Alt Text: fotografia d’epoca di un cowboy al lavoro intento a radunare il bestiame a sella di cavallo, 1907. Fonte.]
Aveva già usato una sorta di self-writing in Dead Ladies Project, un suo libro del 2015 per metà reportage di viaggio e per metà ricerca di predecessori letterari ed esistenziali. Mi ricordo che mi colpì molto il capitolo in cui analizzava una sua delusione/ossessione amorosa ripercorrendo la vita e le fughe di William Somerset Maugham, uno scrittore britannico bisessuale dalla reputazione (personale e letteraria) altalenante. Per quanto mi riguarda, la figura di Maugham mi ha affascinato talmente tanto in passato che ci ho scritto sopra una tesi di laurea. L’ho sentito nominare di rado da scrittori, critici, intellettuali in genere come figura di riferimento. Il fatto che Crispin lo nomini, lo legga e si affidi alla sua biografia per orientare un capitolo della propria vita è stata una sorpresa, ma anche la prova che non ero l’unica ad aver riscontrato una particolare affinità, sia con lo scrittore sia con i suoi personaggi.
Secondo Crispin l’attenzione spasmodica di Maugham per le derive tossiche nelle relazioni umane ha origine dalla sua esperienza diretta, specialmente dal suo matrimonio disastroso con la moglie Syrie. Scrive in Dead Ladies:
Non ne uscì davvero indenne. Maugham non si riprese mai da Syrie o da nessuno dei suoi altri fallimenti amorosi. Per il resto della sua vita venne sempre descritto come amareggiato e serpentesco. Una vita passata a tenere la testa bassa, a moderare le proprie aspettative, lascia il segno.
L’unicità di Maugham è che, nella sua produzione vastissima, la cosmogonia di rapporti umani corrosivi, limitanti e grotteschi non vanifica gli incredibili ritratti di chi tiene vivo il proprio candore — che sia mediante corazze inscalfibili, ingenuità incolmabili o sprezzante noncuranza. Maugham non invita mai a guardare il lato roseo, non suggerisce alcuna morale positiva, eppure riesce a consolare incredibilmente bene, e Crispin lo sa. Ancora in Dead Ladies:
La parte di me che è infelice, sola e si corica sempre accanto ai predatori apprezza la compagnia e le sagge intuizioni dei suoi romanzi. La parte di me che è pura zitella è grata per le zitelle di Maugham, sempre in viaggio verso qualche luogo elettrizzante, padrone delle proprie finanze, pronte a baciare i marinai. E quella parte di me sa che la saggezza si conquista duramente. E che la saggezza è un'altra cosa per cui vale la pena soffrire.
Mi fa molta tenerezza quando — in I miei tre papà, quindi sette anni dopo Dead Ladies Project — Crispin sembra essere rimasta (o tornata?) allo stesso punto morto. Ammette di sentirsi talmente sconsolata e sola per la mancanza di un uomo stabile nella sua vita da arrivare a chiedere aiuto a una cartomante per manifestarlo. E il plot twist (?) è che funziona! Jessa manifesta il marito dei sogni! È un po’ come se, non riuscendo a trovare una via d’uscita dall’eterosessualità, Crispin ci si tuffi a capofitto, quasi come una sfida, per capire che cos’è che davvero non va negli uomini — What is wrong with men, come il titolo del libro predecessore di questo — ma non per distruggerli, per curiosità. Per amore?
[Alt Text: Cartolina “photochrome” con ritratto di James A. Garfield Velarde, leader del clan Jicarilla Apache, 1899. Fonte.]
Mi è tornato in mente quello che bell hooks sentenzia nell’incipit di La volontà di cambiare, il suo bellissimo saggio sulla mascolinità: ogni donna desidera l’amore di un uomo, amare ed essere amata dagli uomini nella sua vita. Mi ricordo che leggere quella frase fu liberatorio per me. Lo stereotipo della femminista iper indipendente, contenta con i suoi gatti e i suoi libri, è incallito, dogmatico. Non solo confessare, ma rivendicare la propria volontà — necessità! — di intrattenere rapporti romantici, amicali, fraterni, familiari, professionali con uomini è spesso percepita come una debolezza, un’eresia, ben oltre gli ambienti separatisti più radicali. Eppure la donna che si basta da sé, che non ha bisogno di nessuno — che è un altro modo per dire: che non scomoda mai nessuno con i propri bisogni — è un archetipo deleterio, la promessa di una solitudine assoluta e vertiginosa.
Ti riferisci anche a questo quando scrivi che Crispin vuole “discutere i danni che il patriarcato (ma anche le strategie con cui si cerca di combatterlo?) ha arrecato non solo agli uomini, non solo alla società, ma anche all’autrice in persona”? Personalmente sono stanca delle scorciatoie ideologiche che si rifugiano dietro gli slogan della mascolinità tossica e dell’eteropessimismo per rifiutarsi di vedere le ferite che anche gli uomini si portano dietro, o zittire sul nascere ogni tentativo di adottare pratiche riflessive meno conflittuali, o perlomeno propense a considerare la propria dose di responsabilità (o almeno la propria presenza?) in qualsiasi interazione umana.
Mi sembra palese che ostinarsi a classificare tutti gli uomini solo come predatori, stupratori e sfruttatori non possa portare ad alcun misurabile cambiamento positivo, ma solo a un irrigidimento nelle proprie posizioni opposte, a un digrignare di zanne ancora più sonoro e pauroso. Mi accodo a Crispin quando scrive “Sono stufa di quelli che credono di conoscere l’organizzazione ideale del mondo”. La cosa che mi sembra più intellettualmente stimolante è, invece, cogliere l’invito della psicanalista Janine Chasseguet-Smirgerl — che Crispin mette in esergo al libro — a “scoprire, affrontare e assumere” il padre nazista — anzi, “l’Hitler in uns” — che ci portiamo dentro per evitare che, rimosso, ritorni nascosto dietro altre maschere. È un processo doloroso, e non è certo un progetto accattivante, specialmente su larga scala. Mi sembra quasi che l’unica arrivata più vicino a sperimentarlo è Taylor Swift (invisa a Crispin!), che ripetutamente sprona interi stadi di ragazze e donne a gridare “It’s me, hi! I’m the problem, it’s me”.
[Alt Text: fotografia dell’allunaggio durante la missione Apollo 11, 1969. Fonte.]
G: Mi fa piacere che siamo atterrate su Taylor Swift, un’altra donna che non ha paura di parlare ripetutamente di sé e delle proprie esperienze — anche se, sospetto, in modo meno generoso e più narcisistico delle scrittrici da te citate. Non sono sicura che Swift sia del tutto sincera quando si definisce antieroina, o che creda davvero di essere il problema. Dai tempi di Reputation, Swift porta avanti quasi senza sosta il racconto dell'underdog, della donna accerchiata ma dotata di troppa forza di volontà per poter essere sconfitta, e penso che fatichi a staccarsene perché è ormai parte del suo brand. Da anni racconta come tutti siano riuniti in salotto a sorseggiare tè e a sparlare di lei, che finisce così per convincersi di essere un mostro. Ma, in Anti-Hero come nella realtà, ride bene chi ride ultimo: all'apertura del testamento, non c'è un centesimo che l’avida nuora di Swift abbia ereditato, proprio come al momento nessuno dei suoi storici nemici gode di una fama paragonabile alla sua. Giustizia è fatta! Nell'epica swiftiana, l'eroina si riscatta con il successo e con i soldi ma soprattutto si riscatta da sola, e questo è secondo me fondamentale per capire come mai Taylor Swift sia in grado di parlare a gran parte delle ragazze soggette, poverine, all'insulso dibattito popfemminista e iperindividualista contemporaneo.
Swift dà voce alla te traumatizzata, alla te ubriaca d’amore o alla te che si vendica (e la adoriamo per questo) ma soprattutto non dà voce a nessun altro, e il suo personaggio è un buco nero che ingoia tutto ciò che lo circonda, un primo termine di paragone così luminoso e accecante da eclissare il secondo. Patti Smith viene nominata soltanto per distanziarsene con modestia, Clara Bow e Stevie Nicks appartengono alla stessa schiera di ragazze spremute dallo star system di cui Swift è l'attuale massima esponente, e tutti gli oggetti delle sue canzoni d'amore hanno un'identità inconfondibile per le fan eppure sfocata nelle liriche, in cui a risaltare, e restare, è solo quello che hanno fatto a lei e con lei. Sarà un caso che in uno dei suoi pezzi più celebri le scene di un amore ora perduto siano raccontate con la specifica che ci vengono restituite come Swift — centro dei mondi che ci consegna e unica focalizzazione possibile — le conserva nella memoria (cioè: troppo bene, e come smentirla)? O che in un altro brano inviti il suo innamorato a ricordarla fotograficamente non facendo ricorso ai propri sensi, bensì come lei stessa procede subito a descriversi — una visione folgorante ma tutto sommato vaga e di facilissima immedesimazione e riproducibilità, standing in a nice dress, staring at the sunset, red lips and rosy cheeks?
Crispin detesta Taylor Swift in parte perché critica nei confronti del culto delle celebrità e della stan culture, ma nel caso specifico anche perché Swift è oscenamente ricca e diffonde spesso uno pseudofemminismo di convenienza, il cui scopo si esaurisce nella denuncia di storture sessiste che la sfavoriscono nella sua professione e nel conseguimento di obiettivi personali (o in una didascalia a effetto su Instagram): tutto ciò che Perché non sono femminista critica. A questo aggiungerei che Taylor Swift in tutte le sue emanazioni pubbliche (narratrice, superstar, amministratrice oculatissima della propria immagine) afferma il primato assoluto di un sé non necessariamente ostile ma spesso dimentico dell'altro e disinteressato alle sue ragioni, non solo ma tanto più se l'altro è un uomo.
[Alt Text: fotografia in bianco e nero di una coppia di eleganti uomini baffuti seduti all’aperto in terrazza, 1915. Fonte.]
Non posso che condividere la tua frustrazione nei confronti degli slogan generici e perentori che inchiodano gli uomini al loro destino di oppressori, anche se comprendo il desiderio di voltare le spalle alle ingiustizie e alla violenza del patriarcato almeno in quei cosiddetti luoghi sicuri in cui è possibile tenersene al riparo. Prendere coscienza della frattura tra il desiderio di volere bene agli uomini delle nostre vite e l'incapacità di questi stessi uomini di amarci a loro volta non è, credo, doloroso soltanto per le donne eterosessuali, e rinunciare allo sforzo di ricucire questo strappo può anche sembrare la soluzione migliore, se non addirittura un diritto.
Mi rendo conto che la proposta di bell hooks, che invita gli uomini a voler cambiare e le donne ad accompagnarli in questo percorso insegnando loro l'amore, risulti ingenua quando la sfiducia è troppa, o limitante quando si vorrebbe esprimere una legittima rabbia. L'approccio opposto, però, mi appare sterile come tu lo descrivi, oltre che politicamente traballante: se, come spesso si legge, non è nostro compito assumerci "il lavoro emotivo di educare l'altro" (frase che Crispin ha scritto quasi con le stesse parole almeno una volta, e sarei davvero curiosa di sapere se la pensa ancora così), se in sostanza abdichiamo alla fatica della relazione, quale potrà mai essere il nostro spazio di azione in una società di cui riconosciamo i difetti? E che valore ha il nostro desiderio di modificarla?
Come dice spesso la mia amica E., tutti vogliono fare la rivoluzione ma nessuno vuole lavare i piatti. È sin troppo vero ma anche troppo taciuto che ogni progetto che si ponga obiettivi seri prevede compiti pratici, quotidiani, fastidiosi e sfiancanti, che non è detto che riusciremo a svolgere al primo tentativo, che non garantiscono successi tangibili o gratificazioni immediate — e che non per questo possiamo però scegliere di trascurare. Scrive Crispin:
In America la libertà è un feticcio, ma in genere ciò che le persone intendono quando dicono di voler essere libere è che vogliono essere sollevate dall'obbligo di prendersi cura degli altri.
Ma:
Prima di poter pensare a ciò che ci è dovuto, è necessario pensare a ciò che dobbiamo gli uni agli altri. Altrimenti ce ne stiamo lì, con le mani tese, indignati, senza alcuna intenzione di soddisfare i bisogni di chicchessia se prima non sono stati soddisfatti i nostri.
È semplice e ovvio, eppure è totalmente contrario al nostro odierno modo di pensare. Ciò vale in particolare per i gruppi che si sono trovati per decenni a condurre lotte per l'uguaglianza alimentate da resoconti dettagliati dei danni subiti, dal ricordo reiterato di ciò che è stato fatto ai membri del gruppo, di ciò che gli è stato negato e di ciò che gli è dovuto.
Leggendo, può sorgere un'obiezione che Crispin previene subito: come la mettiamo con quelle che lei chiama “teste di cazzo”? Che spazio possono trovare nei nostri piani di trasformazione sociale (o anche solo relazionale) le persone che, che so, credono nelle gerarchie e le trovano giuste e naturali, quelle che non ci pensano neanche a rinunciare ai propri vantaggi, quelle che se necessario alzeranno le mani? Crispin non solo fornisce una risposta, ma si serve della domanda per anticipare la questione della legittimità della violenza politica — non tanto quella che proviene dai nostri nemici, perché è tutto sommato facile riconoscerla e condannarla in chi spara a un medico che pratica aborti, o getta bombe su ospedali e scuole, o non soccorre una nave di migranti, quanto piuttosto quella adottata da chi combatte un'ingiustizia con tutti i mezzi a propria disposizione. Quello tra chi ammette l’impiego della violenza politica e tra chi invece lo rifiuta, ritenendo che annulli la distanza morale tra chi reprime e chi si libera, è un dibattito sempre vivo, che qui in Italia si esprime per esempio nelle valutazione tutt'altro che unanime delle azioni dei partigiani durante la Resistenza.
La prima immagine che si forma nella mia mente è quella, molto vivida, tratteggiata da Frantz Fanon ne I dannati della terra (1961), che dedica parecchie pagine alla violenza dell'oppresso: poiché lo scontro tra colonizzato e colonizzatore non si svolge sul piano razionale dei punti di vista, bensì sul piano materiale ed esistenziale,
[l]a violenza che ha presieduto all'assetto del mondo coloniale, che ha ritmato instancabilmente la distruzione delle forme sociali indigene, demolito senza restrizioni i sistemi di riferimento dell'economia, i modi di presentarsi, di vestire, sarà rivendicata e assunta dal colonizzato al momento in cui, decidendo di essere la storia in atto, la massa colonizzata investirà le città proibite.
Trovo davvero efficace questa scena quasi cinematografica dell’assalto alla “città proibita”, che rappresenta lo smantellamento di un modello sociale ed economico imposto con la forza e per questo inaccessibile ai colonizzati se non come subalterni, e come forza lavoro nello specifico, fintanto che da subalterni non si tramuteranno in massa rivoluzionaria. Fanon legge la violenza dei processi di decolonizzazione anche come rifiuto, da parte del colonizzato, del segno positivo dei valori occidentali. Liberando sé stesso e il proprio popolo, il colonizzato distrugge a colpi di "roncola" la superiorità morale del colonizzatore. Crispin non è d’accordo: per lei, voler decretare chi ha diritto di vivere è di per sé un ragionamento da terrorista.
[Alt Text: tre corridori in posa abbracciati per un ritratto fotografico post gara, circa 1940. Fonte.]
F: Non mi sembra, e non gliele faccio assolutamente una colpa, che Crispin stili il profilo dell’essere umano “NON testa di cazzo”: che cosa significa non esserlo, non risultare fastidioso, o nocivo per gli altri? Forse nessuno può dire con certezza che cosa farebbe se potesse godere appieno della libertà concessa da welfare, rapporti famigliari non oppressivi, infrastrutture logiche e funzionali, facilità e gratuità dell’accesso alla conoscenza. La vertigine potrebbe frastornare!
Abbiamo solo esempi parziali degli spazi di libertà che sono stati conquistati dalle persone nel passato. C’è molta fascinazione in Crispin per gli esperimenti utopistici e il pensiero strategico collettivo in genere. Non a caso il passo che citi sul significato comunemente inteso di libertà equivalente all’“essere sollevate dall'obbligo di prendersi cura degli altri” è inserito nella sua descrizione dello stile di vita delle beghine, donne medievali che, indecise al bivio forzato tra maternità e matrimonio da un lato, e vita di reclusione religiosa dall’altro, si sono inventate una terza via. Un vita comunitaria tra donne nubili, non fondata sulla condivisione del culto, ma sulla spartizione oculata di risorse materiali e l’attenta salvaguardia del proprio spazio individuale. Una sorta di cura reciproca alleggerita dall’assenza di ruoli fissi e dalla molteplicità di individui disposti a dare una mano. Crispin è anche incuriosita da John Wesley, il teologo protestante fondatore del movimento metodista — la tradizione nella quale Crispin è cresciuta — e dalla pletora di sette e sotto-congregazioni cristiane che, libere di praticare la propria fede eterodossa altrove, hanno trovato terreno fertile in Kansas (pure la serietà e la curiosità che Crispin riserva alla tematica religiosa è un atteggiamento inconsueto nel discorso femminista). Quando commenta la rivoluzione concettuale di Lutero — l’idea che il filtro-guida dell’autorità spirituale non sia più necessaria alla fedele munita di Bibbia tradotta nel suo vernacolo — Crispin segnala l’enormità dell’impegno richiesto al singolo quando viene “responsabilizzato”.
Definirla libertà sembra ridicolo. Significa portarti dietro dio tutto il giorno, ogni singolo giorno. Non c’è un posto dove posarlo. Ti sta attaccato, ti fagocita. I confini tra questo e l’altro mondo diventano indistinti. Ciò presuppone l’idea che la gente voglia essere liberata dalla superstizione e dalle guide, o stia meglio se lo è, che preferisca la semplicità alla decadenza, che l’ideologia venga sempre ingoiata tutta intera, o addirittura che esista una forma non superstiziosa di cristianesimo mentre ce ne stiamo tutti qui seduti a fingere che il vino sappia di sangue.
Crispin sta insinuando un pensiero alquanto radicale, cioè che forse tutta questa “libertà” non ci serve, che abbiamo messo al primo posto un valore molto fotogenico, ma spesso reso concreto al minimo della sua potenza, contorto, estraneo (se non avverso) ad una serie di bisogni esistenziali dati per scontato troppo a lungo. In sostanza, sta dicendo che essere “liberi”, se applichiamo alla lettera i valori di questa società, vuol dire essere “soli”.
A distanza di tempo dalla prima lettura, però, mi è chiaro quanto I miei tre papà sia impostato come un “quaderno di doglianza”, uno spazio che Crispin si ricava per lamentarsi di tutto quello che c’è di sbagliato al mondo. Solo in secondo luogo è un saggio di analisi e ricerca, e questa particolarità mi è evidente perché faccio fatica a ritrovare singole informazioni e ricostruire a memoria i suoi ragionamenti. Questa struttura, che da una parte ispira fiducia quando le tesi sono radicate nell’esperienza personale, sarebbe d’intralcio a Crispin qualora volesse ergersi a guida (e non penso sia la sua ambizione). Sebbene abbia una nutrita serie di valori alternativi da proporre — idee principalmente legate alla responsabilità della cura e altre cose noiose, ma imprescindibili (!) per arrivare a domani — non c’è l’intenzione di redigere un manifesto, ma nemmeno uno studio storico che illumini cause e conseguenze passate fino ad arrivare a noi. Il “Come” del sottotitolo “Come liberarsi dai fantasmi del patriarcato” non sfocia in vademecum, ma reitera l’insoddisfazione per lo stato attuale. Sento che manca un punto interrogativo in fondo alla frase. L’esortazione di Crispin è sia astratta sia stizzita, e comunque traboccante di speranza:
Il modo di utilizzare quelle risorse è aiutare le persone a ristabilizzarsi. È questo che faceva la chiesa, sia pure soltanto per alcune. Possiamo raccogliere le risorse che ancora esistono e distribuirle. È ancora tutto lì.
Prima della comunità, come già sosteneva Mark Fisher, è necessaria una società: che funzioni senza bisogno di siglare un’appartenenza, in cui anche gli antipatici e le teste di cazzo abbiano abbastanza risorse per “stabilizzarsi”.
Di Fanon è noto l’appello alla “violenza” come modalità di arrivo alla decolonizzazione, un atto che tuttavia mira alla costruzione, o riscoperta, di un nuovo sé per il soggetto colonizzato tramite una “catarsi collettiva”, la scoperta che la propria pelle nera, nascosta sotto una maschera bianca, non vale meno di quella del soggetto colonizzatore. Da non dimenticare che Fanon si forma e opera come psichiatra, e la parte conclusiva di I dannati della terra è una collezione di casi clinici osservati da Fanon nel corso del suo lavoro presso un ospedale psichiatrico algerino durante la guerra d’Algeria tra gli anni ‘50 e ‘60. Ai sopravvissuti a torture, stupri e traumi bellici si aggiungono le storie di adolescenti assassini, poliziotti europei depressi, disturbi comportamentali infantili, “psicosi puerperali” delle donne rifugiate partorienti. Patologie del pensiero e del comportamento che, Fanon mette ben in chiaro, si possono notare anche nella popolazione “pacificata”. Questo perché è osservando consistenza e quantità dei colpi violenti (fisici o psichici o culturali) incassati da ogni singolo soggetto colonizzato nel corso di una giornata qualsiasi che possiamo davvero cogliere il danno provocato dalla soppressione di umanità. Scrive Fanon:
Poiché è negazione sistematizzata dell'altro, decisione forsennata di rifiutare all'altro ogni attributo d'umanità, il colonialismo costringe il popolo dominato a porsi continuamente la domanda: “Chi sono io in realtà?”.
Mi accodo alla preoccupazione che Crispin impiega molto più spazio ad articolare, il disagio e l’insofferenza davanti alla miriade di sfumature di violenza quotidiana che milioni di persone vivono, violenze palesi ma “neutralizzate” da una sorta di realismo capitalista che se non trova modo di giustificare le iniquità, le monetizza. La vendita a ciclo continuo di simulacri identitari non è minimamente in grado di supplire al bisogno di una guida — “Mother!” pigolano e squittiscono le swifties alla comparsa di madre-Taylor — un modello che ci indichi la (una?) via giusta. È desolante vederlo reiterare da Crispin, ma sembra davvero che qualcosa di prezioso — bello, spirituale, nutritivo — sia andato perso insieme all’universo morale che abbiamo smantellato. Lo squallido risultato è che ora siamo incapaci di volerci situare nel tempo e nello spazio — reintegrarci con gli altri — per dare un senso autentico (e perciò autonomo) alle nostre vite.
Mi è tornato in mente un altro medico, il pediatra e psicanalista britannico D.W. Winnicott, e un saggio fulminante, cristallino (rielaborato dal copione di un suo intervento alla radio degli anni ‘50), “The Mother’s Contribution to Society” (”Il contributo della madre alla società”). È il dopoguerra e Winnicott è impegnato a sviluppare proposte pedagogiche che, mettendo al centro il benessere di bambini e adolescenti, rinsaldino l’avversione agli autoritarismi — politici, famigliari, mentali. In poche righe Winnicott svela e descrive il rapporto di interdipendenza che caratterizza ogni relazione umana a partire da quella tra madre e bambino: la più estrema, la più impari, tanto da terrorizzare chi, rendendosi conto una volta cresciuto di essere stato alla mercé di un’altra, rifiuta di riconoscerne l’importanza. Riconoscere questa dipendenza, chiarisce Winnicott, porterebbe a una diminuzione della paura che noi stessi proviamo, non rinsalderebbe il temibile giogo della subordinazione.
Se non c'è un vero riconoscimento del ruolo della madre, allora deve rimanere una vaga paura della dipendenza. Questa paura a volte prenderà la forma di una paura della DONNA, o paura di una donna, e altre volte assumerà forme meno facilmente riconoscibili, includendo sempre la paura della dominazione. Sfortunatamente, la paura della dominazione non porta i gruppi di persone a evitare di essere dominati; al contrario, li attira verso una dominazione specifica o scelta. Infatti, se si studiasse la psicologia del dittatore, ci si aspetterebbe di trovare che, tra le altre cose, nella sua lotta personale sta cercando di controllare la donna la cui dominazione teme inconsciamente, cercando di controllarla comprendendola, agendo per lei, e a sua volta richiedendo totale sottomissione e “amore”.
Crispin ha fatto il lavoraccio di guardarsi dentro e tirar fuori i suoi fantasmi patriarcali, i suoi tre papà — Joseph Pianalto, John Brown, Martin Lutero — che dall’aldilà le riempiono testa e orecchie di “non puoi” e “devi” e “non ti si può amare se non [x]”. Forse è questo il suo esempio come guida, mettere nero su bianco il lento processo di pulizia, scarto e conservazione che ognuna di noi dovrebbe fare, per “stabilizzarsi” nell’animo, almeno. Il padre, il cittadino, il dio: quanti altri fantasmi mancano all’appello secondo te? Io mi sento ancora molto la testa e la vita infestata da tutt’e tre, ma anche dagli archetipi della madre-misogina, dalla pick-me girl, da tutte le voci femminili che hanno assorbito i valori patriarcali, li hanno affilati e usati senza remore contro le altre donne. Alla fine, anche quella è una tradizione che dà sensazione di sicurezza, un gioco in cui conoscendo le regole si sopravvive, o addirittura si prospera.
[Alt Text: ritratto in seppia di quattro soldati afroamericani non identificati in uniforme, Fonte.]
G: Se la mia personalissima statistica è attendibile, le madri che rovesciano la propria misoginia non solo su se stesse ma anche sulle loro figlie femmine sono il motivo per cui la maggior parte di noi donne millennial si trova al momento in analisi, per cui penso proprio tu abbia individuato un fantasma piuttosto ingombrante! Trovo essenziale che il femminismo ci dia le parole per dare un nome all’altrimenti inspiegabile risentimento della madre nei confronti della figlia, e con esse un possibile terreno di dialogo e uno spazio di comprensione. Senza questi strumenti la confusione che proviamo quando, senza un apparente motivo, le nostre madri si sottraggono all'alleanza di genere che ci aspetteremmo riservandoci particolare asprezza, o mettendosi di continuo in competizione con noi, potrebbe facilmente inaridire il rapporto o precipitarci nella ripetizione degli stessi atteggiamenti, fino a farci diventare un anello della “catena di donne mute e stizzose da cui prov[eniamo]”, secondo la definizione di Elena Ferrante.
Proprio dopo una rilettura integrale dei romanzi di Elena Ferrante negli ultimi mesi, mi sono resa conto che ciò che mi parla di più in questo momento è in effetti la sua descrizione del materno: indifferente, mostruoso, antipatico, in ogni caso non pacificato o gioioso e di certo non risultante nella dissoluzione della persona nel suo ruolo di madre. Olga de I giorni dell’abbandono, portata a uno stato vicino alla follia dal tradimento del marito, trascura i figli e arriva a odiarsi per essersi sacrificata, lei sola, nella creazione di una famiglia; Leda de La figlia oscura ed Elena di Storia di chi fugge e di chi resta spariscono per anni dalla vita delle figlie piccole preferendo a loro un amore, una carriera, o entrambe le cose; la stessa madre di Elena è scissa tra il desiderio di non farsi superare dalla figlia e la vanità per i traguardi che quest’ultima sa raggiungere, e si comporta in modo duro ed esigente, privo di tenerezza. In tutte queste storie emerge ciò che la maternità toglie in sfavore di ciò che può dare e talvolta anche l’impulso a tornare indietro, recuperando terreno sulle proprie rinunce. So benissimo che le scelte di libertà che le personagge di Elena Ferrante spesso compiono sarebbero giudicate terribili e contronatura dalla madre misogina che anch’io, come tantə, posso vantare. Eppure queste donne non fanno altro che comportarsi come è perdonato se non concesso agli uomini e ai padri, e suscitando ad arte un giudizio negativo nei confronti delle proprie personagge Ferrante non fa ai miei occhi che smascherare una mistica della maternità accogliente e infallibile, sempre pronta al passo indietro, sempre all’altezza della responsabilità – interrogando di conseguenza l’aspettativa di amore costante e incondizionato che nutriamo come figliə.
Sta di fatto che mi sento trascinata nella mischia nel ruolo di figlia: più libera di mia madre, consapevole e partecipe soltanto grazie alle mie letture della sua esperienza che è invece vissuta e incarnata, come mai, sorprendendomi (seccandomi) di alcuni suoi atteggiamenti, fingo che la cultura patriarcale non abbia messo lei, ben prima e ben più di me, in una posizione difficile? Dubito che troverò mai la risposta conclusiva a questa domanda.
Tornando alla nostra collezione di fantasmi, mi colpisce la mancanza del padrone. Dobbiamo pensare che anche Jessa sia così immersa nel realismo capitalista da aver trascurato di nominare la presenza che di fatto aleggia dietro tutti i suoi fantasmi? In fin dei conti, è il padrone che mi vuole sistemata in una famiglia nucleare, è ancora il padrone a lamentare la denatalità e di conseguenza ad aver bisogno che venga convinta o costretta a rinunciare ai miei diritti riproduttivi, ed è sempre l’interesse del padrone a precedere la necessità di prevenire con interventi strutturali l’aggravarsi della catastrofe climatica e i suoi effetti nella disponibilità delle risorse, nella tenuta delle infrastrutture e in numerosi altri aspetti della nostra quotidianità. Convivere con questo fantasma è stancante e la minaccia che esso rappresenta è esistenziale, impossibile da lasciare sullo sfondo mentre ci dedichiamo ad altro: e infatti non ne possiamo più di questo padrone. Nella conclusione al suo Le grandi dimissioni. Il nuovo rifiuto del lavoro e il tempo di riprenderci la vita (2023), la sociologa Francesca Coin propone delle misure di contrasto alla significativa disaffezione al lavoro che stiamo osservando negli ultimi anni e puntualizza che l’obiettivo principale non può che consistere nel benessere della classe lavoratrice, cui devono essere offerte garanzie e solidità:
[...] alzare i salari, aumentare gli organici, la sicurezza del e sul lavoro, introdurre un salario minimo legale, contrastare il lavoro sommerso e il dumping contrattuale, introdurre un congedo genitoriale paritario e nuovi servizi per l’infanzia, abolire tutte quelle forme di lavoro gratuito che abituano gli studenti a lavorare gratis. Bisogna, inoltre, potenziare le misure di welfare universalistico, perché migliorare la qualità del lavoro significa anche consentire alle persone di dire no al lavoro povero.
Welfare capillare e reddito dignitoso e assicurato non sono già la risposta a diverse delle “doglianze” enumerate da Crispin? E forse ci permetterebbero di metterci senza ansie alla ricerca del senso di cui il suo testo lamenta la perdita, in modo da riempire con autentica soddisfazione il vuoto che ora ci spinge verso una spiritualità individualista e posticcia ma chiamata a sopperire sia alla solitudine personale che a una crescente precarietà materiale. Sbarazzarci di un sistema di valori senza trasformare con la stessa radicalità il contesto materiale in cui si è sviluppato ci ha lasciato con un involucro cavo. E pesante da sostenere.
[Alt Text: tre uomini posano accanto a una botte posta su un carro, ognuno regge un bicchiere contenente una bevanda scura, forse birra o vino. Fonte.]
La pagina in cui Crispin elenca a raffica gli aspetti quotidiani di un mondo insensato è l’apice della sua esasperazione. I suoi esempi sono molti e ne riporto solo alcuni per dare l'idea del tenore: cinque film di supereroi all’anno, i meme, i filtri di Instagram, fare la fila per fotografare un quadro in un museo, il true crime (ecco), donne di mezza età innamorate di Timothée Chalamet, e così via. Questa nostra epoca può essere esilarante o deprimente nella maggior parte delle sue manifestazioni, a seconda di quanto tempo ci pensi su. Nel suo diario del lockdown uscito su Netflix nel 2021 e intitolato appunto Inside, Bo Burnham chiama il nostro spaesamento di fronte a queste assurdità “funny feeling”, e procede con la sua lista in forma di canzone non dissimile da quella di Crispin: app di meditazione in alta risoluzione, leggere i termini d’uso di Pornhub, un libro di auto-aiuto ordinato online e consegnato da un drone. Quella sensazione strana, che Burnham evoca alternando nel testo trivialità e fatti ben più drammatici come il cambiamento climatico o le sparatorie nelle scuole, è lo straniamento di trovare in continuazione nello stesso contenitore, sia esso un social o un telegiornale, notizie di importanza molto diversa ma proposte orizzontalmente, senza gerarchia. “Ti può interessare un po’ di tutto nello stesso momento?”, cantilena in un altro pezzo. La risposta è no, certo che no!, ma lo stimolo a rivolgere la nostra attenzione a troppe cose, a scorrerle con superficialità per passare subito ad altro, è davvero incessante e difficile da eludere.
Sia I miei tre papà che Inside sono nati subito dopo la pandemia e il nostro conseguente isolamento: forse è un caso, ma a me piace pensare di no. Credo che noi tuttə riconosceremo una “sensazione strana” ricordando la contemporaneità delle fan fiction erotiche su Giuseppe Conte e dei mezzi militari che sfilavano trasportando bare in una Bergamo vuota e spettrale, dell'hashtag #iorestoacasa e dell’appuntamento serale con il numero ufficiale delle vittime diffuso dal Ministero della Salute, delle canzoni improvvisate sui balconi che rimbalzavano ovunque con commenti su coraggio e resilienza mentre, fuori da ogni inquadratura, tantə perdevano il lavoro e tantə altrə erano obbligati a presentarsi in fabbriche e uffici che non rispettavano i nuovi protocolli di sicurezza mettendo così a rischio la propria vita. Un continuo sollecito a distrarsi mentre attorno a noi il mondo cadeva a pezzi. E mai come nelle settimane trascorse a casa, d’improvviso privə di impegni e distrazioni esterne, abbiamo avuto l’opportunità di accorgerci davvero di questa sensazione e di doverci convivere.
Rileggo la nostra conversazione e mi rendo conto che anche noi, analizzando questo saggio, abbiamo colto l’occasione per discutere anche delle rispettive lamentele, per dirci cos’è che ci affatica e spazientisce e che vorremmo diverso. Diverso come, però, io non sempre lo so. Inginocchiata di fronte alla testa di Santa Caterina nella basilica di San Domenico a Siena, Crispin chiede alla reliquia: Che facciamo? Le risposte non provengono dalla testa della santa ma da quella della supplice, e non sono certo definitive: che altro possiamo fare se non provare ogni giorno, sbagliare, cercare di essere buonə e amorevoli, constatare che spesso non lo saremo, talvolta soffrire, e alla fine morire? Sembra la dichiarazione di un’impotenza paralizzante, oltre che una conclusione in minore a questo nostro dialogo. Secondo me invece è proprio l’opposto: è un sollievo che questo libro non sia stato pubblicato allo scopo di separare le cose ASSOLUTAMENTE GIUSTE dalle cose ASSOLUTAMENTE SBAGLIATE o di dettarci la ricetta per CAMBIARE IL MONDO PRIMA DI SUBITO quanto piuttosto per descrivere un malessere, e non mi sembra irresponsabile o sbrigativo, bensì onesto e in qualche modo fiducioso, scrivere che, malgrado le storture e la violenza e le sensazioni strane, possiamo ancora cavarcela, singolarmente e collettivamente. O almeno dovremmo provarci.
Gloria Baldoni e Francesca Massarenti hanno fondato e curano Ghinea insieme a Marzia D’Amico.