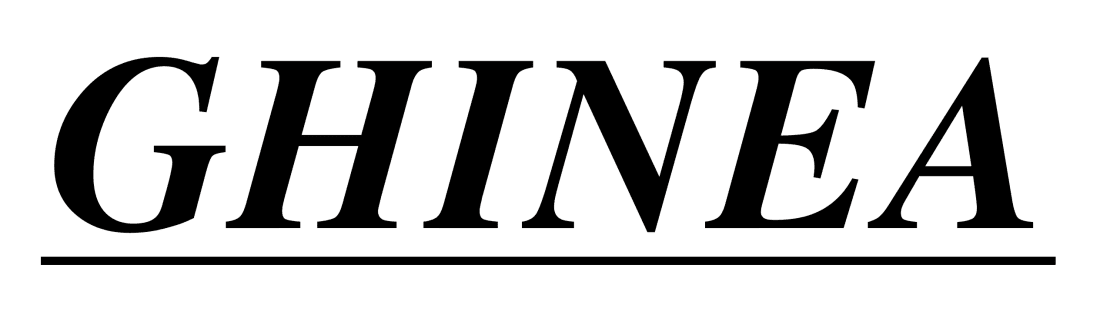La ghinea di febbraio
Benvenut* a Ghinea, la newsletter seguita anche dai suoi nemici politici. Gli eventi su cui in questi giorni è concentrata l’attenzione di noi tuttə esigono un rigore nella trattazione che una sola settimana ci ha reso impossibile garantire. Perciò, il numero di questo mese contiene soltanto quello che avevamo già pronto prima del 22 febbraio, vale a dire un intervento di Nadia Agustoni sull’intreccio tra letteratura e lavoro, e sulla poesia che proviene dai margini.
Ti segnaliamo inoltre una lista di organizzazioni femministe e queer che lavorano in Ucraina e che hanno bisogno di aiuto. La distanza geografica e linguistica non ci permette di verificarne l’affidabilità con la precisione che vorremmo, perciò ti esortiamo a considerarla un punto di partenza, e a scriverci per correzioni o aggiunte. Buona lettura!
Lavoro e poesia
di Nadia Agustoni
PS: ascolto le parole di Monica Guerritore al funerale di Luana D’Orazio che aveva avuto qualche piccola parte, come attrice o comparsa, in qualche film, prima della fabbrica. Monica Guerritore dice che il mondo dello spettacolo era il mondo di Luana. Tutti quelli/e che lavorano in fabbrica facendo anche altro, essendo ben altro, si saranno chiesti come me: è vero? Davvero il mondo dello spettacolo era il mondo di Luana, quello a cui apparteneva davvero? E noi che scriviamo apparteniamo alla letteratura? È così? Forse un po’ è vero. Apparteniamo a questi mondi, ma come corpi attraversati da un filo spinato. Divisi. Alla fine non apparteniamo a nulla. Resta questa ferita. Questo sentire spaccato.
(Lettera indirizzata al collettivo La rosa e le spine, che lo ha letto in un sit-in a Brescia il 24 giugno nell’ambito di iniziative sulla nostra costituzione)
Da più parti mi è stato chiesto cosa significa per me essere divisa tra lavoro in fabbrica e poesia e in senso più ampio letteratura. Dopo il mio intervento in forma di lettera inviato al collettivo femminista di Brescia La rosa e le spine, pubblicato poi da Letterate Magazine ho pensato molto a questo.
Nel post scriptum della mia lettera definivo i corpi divisi tra lavoro dorsale e letteratura, cinema o altre forme creative, come “attraversati dal filo spinato” e da questo la domanda su cos’è questo portare in sé il filo spinato di un lavoro di fatica, uno di quei lavori senza alcuno sbocco ma che da sempre devono riempire le casse dello stato perché la collettività stia meglio e tutti abbiano gli stipendi pagati, scuole, ospedali ecc.?
I nostri stipendi sono miseri, si sa, e finire nei recinti del lavoro svalutato significa avere riconoscimento solo in caso di emergenza, quando urgono le consegne e interi settori se non funzionassero trascinerebbero il paese sul fondo. Tuttavia questi lavoratori sono disprezzati, le tantissime morti bianche fanno notizia per poco e così la somma totale di queste vite perse sfugge ai più.
Cosa significa allora scrivere, fare teatro, fotografia o cinema o tentare di farlo, rimanendo in un mondo dove il lavoro è fatica e i corpi soffrono per logoramento, sfruttamento, eccesso di produzione e quanto altro?
Il filo spinato lo portiamo nei corpi e più che dividere, forse, è parte del dolore e della svalutazione di un’intera vita. È qualcosa che ti ricorda un’esistenza sbagliata, spesso mancata per le opportunità che non c’erano e confinata quindi in un ambito dove nulla conta di più del produrre.
Cosa può salvare la scrittura o un qualunque atto creativo a chi vive in questo? Non credo che scrivere salvi, non in senso vero, ma scrivere lascia un’integrità che permette di avere uno sguardo diverso sul mondo. Questo vedere porta con sé la sola possibilità concessa: non permettere ad altre parole, parole del potere, di dire che consentiamo. Nessuno consente alla sofferenza. Viene imposta. Le ultime leggi in tema di lavoro in Italia, ma la cosa è globale, ne sono la prova.
Tutto questo trova complicità immense. Trova una società che dipende dagli introiti del lavoro di produzione (industria e agricoltura) che sta alla base di tutto, e sapendolo è più che disposta a chiudere entrambi gli occhi perché non trova ingiustizia nemmeno nel numero di vite che mancano.
Se questa non è guerra di classe cos’è? Guerra su chi non riesce a difendersi e allora meglio parlare di altre emergenze, ignorando il fatto che alla base di ogni ingiustizia e di ogni stortura che dilagano, ci sono persone che non vi seguiranno in altre battaglie se la loro sono lasciati soli ad affrontarla. La sofferenza e l’abbandono tolgono forza e spingono a chiudersi.
Quello che manca sul piano della società, non è una pietas generica, ma il senso di una ecologia della persona, dell’essere umano, del ridare valore a ogni singola vita perché ogni singola vita investita di valore, si assuma la responsabilità di quello che accade agli altri, alla terra, agli animali, all’ambiente sotto ogni aspetto.
Non si tratta di rendere, come ha fatto di recente un settimanale pubblicando un servizio fotografico dalle fabbriche, un valore estetico agli operai o ad altri lavoratori, ma di riconoscere a quei corpi la loro integrità, il loro diritto alla salute, alla dignità, alla giusta retribuzione e al riposo.
Qui siamo oltre la poesia, ma tutto questo mi fa dire anche che la poesia non è solo una parola. È una parola che ha dietro di sé un mondo e dei corpi. Se quei corpi sono attraversati dal filo spinato non vi diranno mai quello che volete sentire, né vi affiancheranno in battaglie che dovrebbero e potrebbero essere di tutti. Se tutto brucia e nulla cambia, è anche nel silenzio dei dimenticati che ne va cercata la ragione.
Nuovi appunti su lavoro e poesia. Marginalità, scrittura e lettura.
Un lungo articolo di Renzo Sabatini, sul primo numero della rivista “Emma”, semestrale di culture e pensieri libertari, racconta, in un reportage sulle rovine e i guasti dell’impero nord americano, anche l’esperienza dei frigoriferi comunitari inventata a New York per rispondere in modo solidale alla pandemia di COVID-19. Invece di affidarsi ai vari enti di beneficenza, questi frigoriferi permettono a chiunque di portare del cibo per chi non ne ha o ne ha poco e di prenderlo, sulla base della sola fiducia, a chi ne ha bisogno. Chi ha proposto questa pratica si è ispirato ai “reietti” di Ursula Le Guin, uno dei suoi libri più noti. Mi sono chiesta se tra gli emarginati di Harlem e Brooklyn qualcuno avesse letto Ursula Le Guin o se, come probabile, qualcuno ha letto per loro e associato la solidarietà a questa narrazione. Parto quindi da qui per chiedermi cosa sia leggere, educarsi alla lettura e magari anche scrivere, quando si vivono vite al margine, quando il lavoro è precario, cattivo, pagato pochissimo o niente del tutto e quando si vive in quartieri affollati o in realtà violente, spersonalizzanti e la propria collocazione sociale è in basso o indefinibile sulla scala dei valori accettati.
In un certo senso è più facile trovare scritture del margine, o vicine al margine, piuttosto che capire se queste siano fruite, lette, elaborate o discusse dai meno fortunati. In una sua famosa poesia, Adrienne Rich parlava con le donne che riteneva avrebbero letto le sue parole e infondeva una minima fiducia nel potere delle parole, se non salvifico, almeno capace di aprire crepe nei muri dell’incomunicabilità.
So che stai leggendo questa poesia/tardi, prima di lasciare il tuo ufficio … / So che stai leggendo questa poesia/ in una stanza in cui è accaduto troppo per poterlo sopportare/… So che stai leggendo questa poesia che non è nella tua lingua …
(Dediche)
L’esperienza della lettura è in parte privilegiata. Leggere poesia, in particolare, presuppone un interesse, a volte una ricerca e una presa di coscienza riguardo le parole stesse, sul modo di usarle e di interagire col testo, perché magari chi legge è anche qualcuno che scrive. Tuttavia se la poesia può raggiungere in fretta le persone e la brevità e la concisione favoriscono il leggere, non sempre aiutano l’approfondimento. Questo avviene anche quando la poesia parla contro qualcosa, assurgendo subito a manifesto di una ribellione allo status quo e finendo poi in dispute da cui solo il narcisismo dei poeti esce rafforzato.
Ci sono però poet* il cui impegno tocca tasti dolenti e sanno evidenziare alcuni punti della situazione sociale, partendo da quello che le persone pensano e che può sembrare normale.
[ALT TEXT: collage fotografico verticale in bianco e nero. A sinistra, una giovane Paley in abito al ginocchio viene scortata da un poliziotto. Al centro, Paley indossa un grembiule su cui si individuano parole di ribellione alla guerra (qui si può leggere in merito), con un cappello a uncinetto. A destra, Paley è sul palco e tiene nella mano sinistra un microfono. Indossa abiti formali, una camicia e una lunga gonna nera. Fonte: LitHub.]
Grace Paley, scrittrice, poeta e attivista statunitense, con la poesia “I ricchi dal cuore duro” riflette su quel tipo di pensiero superficiale, che associa la povertà all’incapacità o alla fannullaggine:
“l Oh quanto sono duri i ricchi dal cuore duro/ quando incontrano un lavoratore nei loro luoghi/di lavoro — un taxi o la cucina di un ristorante/ e il cuore duro — batte e spinge — la bocca/ a dire be’ probabilmente prendono/ il minimo salariale … / probabilmente …
Abbiamo qui un testo molto immediato, con immagini chiare e parole scelte con l’accuratezza di chi vuole essere capita. È sempre possibile, quindi, che se il caso o altro lo mettano in mano anche a chi non legge, trovi consenso e partecipazione. Purtroppo, va detto che in questo nostro caotico tempo non sono solo i ricchi ad avere cuore e orecchio duro. La lotta tra poveri rende difficile la solidarietà e il pensiero egemone appartiene ormai a una destra sfacciata e capitalista come non mai, che con i suoi modelli si è imposta ovunque, anche nella testa di chi li subisce. Così di giorno in giorno, impunemente, erode i diritti dei lavoratori e di tutti i subalterni, presentando le sue “innovazioni” come priorità di un tempo nuovo e parlando di democrazia partecipata. La mancanza di una narrazione che si opponga in modo forte a questa deliberata confusione, ridando fiato, speranza e facendo convergere le lotte contro patriarcato e capitalismo, fa sentire il suo peso nelle vite di ognuno di noi, nonostante la ricca produzione di pensiero che ogni volta ci fa immaginare altre realtà e possibilità.
Tornando alla questione della lettura, rimane la domanda su come ci si educa alla poesia e se gli emarginati della società leggano.
Alla poesia ci si educa leggendo poesia, la si scriva o no. Leggere poesia è già accettare di capire lo spazio in cui questa si muove. Quello che sconcerta i lettori casuali di poesia, i meno avvezzi, è lo spazio bianco delle pagine. Se la poesia riempie la pagina la carta non è sprecata, se il testo è breve o minimo, ecco che scatta il senso di perdita. È un vero senso di perdita, perché lo spazio bianco li mette di fronte a un silenzio, fondamentale nella poesia, ma che per loro è straniante, assurdo e pericoloso perché li ferma lì dove sono e li avvicina a se stessi. Eppure il senso di ogni poesia è qui: avvicinare a se stessi e aprire la difesa interiore che allontana dalla vita; la propria, mal vissuta e negata e quindi quella altrui, specie quando vi sono di mezzo questioni come il genere e la razza.
Tutti abbiamo visto giovani ragazzi immigrati cercare di vendere i loro libri di poesia sulle spiagge o nelle piccole fiere di paese. Il loro modo di comunicare e dirci chi sono implica una grande fiducia nelle parole, quelle in cui hanno creduto sempre Adrienne Rich e Grace Paley, ma a cui crede molto anche il poeta e scrittore islandere Jón Kalman Stefánsson, che nel saggio introduttivo a La prima volta che il dolore mi salvò la vita, libro che raccoglie in italiano tutto il suo lavoro poetico, spiega come dopo aver portato la sua prima opera ai suoi compagni di lavoro, marittimi e portuali (Stefánsson ha svolto molti lavori di fatica) si sente dire che è un peccato tanto spreco di carta. Se questo inciampo lo ha amareggiato non gli ha tolto né la voglia di scrivere poesia né un senso dell’universalità che dai suoi testi fa capolino spesso e riguarda lui come ognuno. Un piccolo frammento, quasi un lampo, mostra come parli a un’umanità che non smette di interrogarlo:
Vi raccomando/ di orientare la vita/ verso il monocolo del cielo/ da lì parlerò.
Nella mia esperienza, sia di fabbrica che altrove, non è l’incomprensione che trovo, a parte alcuni casi. Le persone leggono, rileggono e spesso apprezzano, o a volte protestano perché non c’è punteggiatura e gli a capo le mettono in difficoltà, ma è sulla pagina bianca, in quell’ampio spazio libero da parole, che vedo concentrarsi la maggiore perplessità. Mi domando se sia dovuto al cercare in un libro, non domande e interrogazioni sull’umano, sul non umano, sul significato del silenzio e altro, ma un vademecum.
In Italia poeti/e/* con esperienza di fabbrica o di lavori di facchinaggio vari non sono mai mancati. Dai lontani anni Settanta con Ferruccio Brugnaro, Luigi Di Ruscio, Tommaso di Ciaula e Giuliana Rocchi, il lavoro e l’universalità della propria presenza nel mondo hanno avuto ampia testimonianza.
Questi quattro autori sono stati tra i più importanti e riconosciuti dalla critica. Hanno parlato e scritto di lavoro, ma anche di molto altro, rifiutando di essere inquadrati sotto qualche sigla. Ognuno di loro ha avuto una sua originalità linguistica. Una forte indipendenza.
Giuliana Rocchi è stata scoperta e incoraggiata da Rina Macrelli, come lei di Santarcangelo di Romagna. Rina Macrelli, mancata il 7 novembre 2020, era, oltre che scrittrice e militante femminista e lesbica, anche un’autorevole critica letteraria. Fece parte del Circolo dei giudizi dove alcuni tra i più noti poeti italiani, Tonino Guerra, Nino Pedretti, Gianni Fucci, Raffaello Baldini, leggevano i loro testi ancora inediti.
Suvvia nonno, non piangere/forse cucinerà presto anche oggi la pignatta delle fave/ anche al fumo degli altoforni/ anche alla lingua dura del cemento che avanza./ Io non domo cavalli/ né porto pecore e cani alle pasture,/ io sono qui al bivio,/ con la tuta ruvida, incerto se venire da te./ Ma la fabbrica è troppo vicina,/ e poi non ho nemmeno cera, alle orecchie/per le sirene.
(Tommaso di Ciaula, Tuta blu; Feltrinelli 1978)
L’è mèi ch’ a n’apa/ cmandoè mai/ u m’avrébb piséu/ l’oèra pulóida.
È meglio che non abbia/ comandato mai/ mi sarebbe piaciuta l’aia pulita.
(Giuliana Rocchi, Poesie nel cartoccio; Maggioli editore 1998)
Il rumore dei miei passi/ mi rimane/ incastrato/ dentro/ pieno di domande/ interrogativi/ sordo/ prepotente./ I miei passi/ di trent’anni/ dai gradini del terzo piano / di casa/ alle scale scrostate dei reparti…/.
(Ferruccio Brugnaro, Le stelle chiare di queste notti; Campanotto 1993)
Hanno bisogno solo di se stessi/ almeno così credono comunque state attenti/ la lavatrice sarà necessario accomodarla/ un giorno avrete a che fare con i becchini/ la solitudine perfetta…
(Luigi Di Ruscio, in Poesie operaie; Futura editore 2007)
[Alt Text: primo piano in bianco e nero di Nella Nobili, coi capelli mossi e corti, la bocca appena aperta, una camicia bianca larga, e la mano destra che tende verso la camera come in un saluto. Fonte: Istituto Italiano di Cultura di Parigi.]
In tempi più recenti sono emerse molte voci, tra giovani e meno giovani. Segnalo la scoperta di Nella Nobili, su di lei ha scritto (e raccontato in radio) Maria Grazia Calandrone e ne ha curato la raccolta completa delle poesie. Nella Nobili ha lavorato fin da bambina in fabbriche di ceramica e vetrerie (come del resto toccò a Giuliana Rocchi), studiando di notte, scrivendo e frequentando gli intellettuali della sua città, Bologna. Nel 1953 emigrò in Francia e là visse con la sua compagna Edith Zah con cui scrisse Le femmes et l’amour homosexuel. Scrisse anche altri libri di poesia in francese. Viveva di piccolo artigianato. Nella Nobili rifiutava, giustamente, come limitante, l’etichetta di “poetessa operaia” e visse apertamente il suo lesbismo già negli anni Cinquanta. Morì suicida nel 1985.
… Ormai solo il vero conta./ Penetrare nel vero, affidarsi al senso più concreto/ Con i mezzi più concreti:/ Ogni uomo li possiede.
(Nella Nobili, Ho camminato nel mondo con l’anima aperta; Solferino 2018)
Tra le voci contemporanee, la trama del lavoro emerge costantemente e nessun* si etichetterebbe, questo vale anche per me, come poeta operaio. Bisogna capire che il passo compiuto da Kae Tempest per la scelta della denominazione del genere identitario vale per molt* altr* e in più ambiti. La scelta di non essere definit* o di non appartenere a categorie, create per rassicurare qualcuno, si estende oltre il genere, anche per persone che non sanno nulla del queer. Nel mio caso, per quanto riguarda il genere, ero queer prima ancora di incontrarne le formulazioni. Non è nemmeno inusuale trovare, in ambiti lontani dal queer militante, persone che sono queer, ma non conoscono il significato della parola.
[ALT TEXT: primo piano del volto di Kae Tempest, dai colori chiari, con capelli corti e due cerchietti in oro all’orecchio destro. Sullo sfondo una sfocata natura verde brillante. Credits: Wolfgang Tillmans]
Dirsi non significa voler appartenere a una categoria, ma parlare dal punto di vista di quello che si vive e che si sa. La domanda vera sarebbe perché qualcuno ha sempre bisogno di dare un’etichetta, di genere o di specie, letteraria o di classe, di casta o quant’altro, riservandosi la libertà di nominare e rimanere libero da definizioni.
Dare un nome o inserire in una categoria chi non lo chiede e non lo vuole, è esercitare un potere su un’altra vita, anche quando chi lo fa, pensa di essere dalla parte degli ultimi o penultimi. Quello spazio, sgradito, per molti è peggiore della marginalità.
Chiedere di non essere definiti e rimanere indefiniti è un atto politico rilevante come quello di chi sceglie di definirsi entro le denominazioni date.
Purtroppo se le voci femminili trovano ora un migliore ascolto, si tende a negare o meglio, a sorvolare, sulle voci di chi è persona non binaria.
Un’ultima domanda bisogna porsi. Abbiamo tutt* bisogno di universalità?
Penso che ognun* di noi, poeta o non poeta, rifletta in se stess* l’universale e ne abbia bisogno e diritto. È solo il privilegio che si nutre di esclusività.
Porto due esempi, perché a volte una scrittura rivela qualcosa, sia quando chi scrive ne ha l’intenzione, sia quando non ce l’ha.
Ilse Aichinger, nel suo unico romanzo La speranza più grande riedito di recente, fa i conti con il suo ebraismo e le perdite di alcuni dei suoi familiari durante il nazismo e dà voce ai bambini, alla loro paura e innocenza, alla loro paziente attesa di una grande salvezza, racchiudendo in ognuno di loro l’intera umanità. Paradossalmente, Aichinger lascia al pescecane, al console, a Colombo, a personaggi che difficilmente oggi collegheremmo al positivo, il compito di consolare e regalare uno spiraglio, per quanto esiguo, ai ragazzini deportati o in procinto di esserlo:
Rimanete e ascoltate, amate e splendete! Lasciatevi disprezzare e bagnatevi nelle lacrime. Le lacrime schiariscono gli occhi. Trapassate la nebbia e scoprite il mondo! Essere: è questo il lasciapassare per l’eternità!
Al contrario Radovan Karadzic, condannato per i numerosi crimini contro l’umanità durante le guerre nell’ex Jugoslavia pur tentando di negare l’umanità degli “altri” riesce solo, nella sua scialba poesia “Sarajevo” (citata nel supplemento de Il Sole 24 ore, 23 maggio 2012), a farceli vedere:
La città brucia come un pezzo di incenso/ nel fumo rimbomba la nostra coscienza. / Abiti vuoti scivolano giù per la città…
La poesia vorrebbe essere marziale nell’insieme, ma quegli “abiti vuoti” sono più visibili del fumo e di chi marcia coi fucili.
Chissà se questa visibilità dei vinti è una rivincita anche per la poesia, così inutile, ma anche impossibile da fermare. E chissà se la parola poeta quando è usata da un criminale di guerra ha ancora un’aura appetibile.
Leggere e leggere con attenzione è comunque un atto creativo. Il vero lettore è necessario come il vero scrittore. La lettura, le traduzioni, le scritture di chi parla da luoghi a cui nessuno o pochi guardano, sono un moltiplicarsi di possibilità e di incontro, servono a capire che la terra stessa su cui camminiamo è umanità. Se non altro perché è stata riempita di sangue.
Per chiudere un’ultima cosa: viviamo in un paese dove in alcune biblioteche del nord alcuni quotidiani non sono ammessi e alcuni libri, mi viene detto, non si trovano più. Qui dove la vita di chi lavora non vale niente, dove un giornale fa paura, dove i libri non si trovano più, la nostra vita ha bisogno, anche senza salvezza, di ogni singola parola che faccia splendere quello per cui abbiamo lottato e per cui lottiamo.
Nadia Agustoni (1964) scrive poesie e saggi. Suoi testi sono apparsi su riviste, antologie, lit-blog. I suoi ultimi libri sono del 2021 [la casa è nera] (Vydia edizioni), del 2020 è Gli alberi bianchi (Gialla oro Pordenonelegge-Lietocolle), del 2017 è I Necrologi (La Camera verde), del 2016 è Racconto Aragno, del 2015 Lettere della fine. Vive vicino a Bergamo.
Dr Alice Evans, speaker e curatrice del podcast ROCKING OUR PRIORS, invita la storica Nwando Achebe (Professoressa presso la Michigan State University) a discutere alcuni dei temi presenti nel libro Female Monarchs and Merchant Queens in Africa, quali eguaglianza di genere, linguaggio non marcato in termini di genere, reti di solidarietà femminili nelle società pre-coloniali. Il podcast, inglese, offre anche una trascrizione dell’audio.
In Colombia l’aborto è stato parzialmente depenalizzato.
Roxane Gay ha deciso di rimuovere il proprio podcast dalla piattaforma Spotify, come azione diretta contro il podcaser Joe Rogan e la disinformazione che promuove. Intervistata dal podcast Offline, Gay offre una più ampia riflessione su media e consequence culture.
Il lavoro del giovane collettivo francese Nous Toutes, da alcuni anni impegnato a combattere la violenza di genere.
Fotografare le donne del Kashmir.
L’archivio affettivo-politico di Liana Borghi.
FATTO DA NOI
In questa lunga puntata di Ricciotto, puoi ascoltare Gloria, Alice Cucchetti e Federica Bordin che parlano della musica e del cinema di Lin-Manuel Miranda.
FATTO DA VOI
Eris Edizioni ha appena pubblicato il primo libro di Antonia Caruso, LGBTQIA+. Mantenere la complessità.
[Alt Text: copertina fucsia di LGBTQIA+. Mantenere la complessità. Fonte.]
Ringraziamo Nadia per il suo contributo. Ci leggiamo a fine marzo!
Francesca, Gloria e Marzia